Testo e copertina di Silvia Antonelli
Destinazione Andreis. Non saprei spiegare per bene perché. Certo, perché c’è nato e vissuto Federico Tavan. Perché le voglio guardare coi miei occhi quelle quattro case, dopo averle guardate con i suoi, di occhi.
Federico Tavan è maledetto fin da quando si trova nel ventre materno, additato dalla falange ossuta della strega di paese e a niente serve il volto dolente della Madonna sulla testa di Colette che prega al mattino e al pomeriggio, prega tanto Colette, la mamma di Tavan, la chiesa è là vicino, ad Andreis è tutto vicino. La strega apre la porta e segna e urla:
E la vecchia urlava: “Nascerà un giorno IL MOSTRO, qualche cosa che non è NOSTRO” sta vecchia.
Una condanna calata dall’alto, premonizione di corpo estraneo, furia d’ignoranza. Colette sviene e perde sangue, un principio di aborto di quel feto o corpo o cosa?
Tavan nasce sotto questa cattiva stella, una cometa di pianto che dura tutta una vita. Il desiderio di essere parte, la volontà di rimanere ai lati, la dialettica dell’emarginazione. La confidenza agli ultimi, ai cristi a testa in giù, alle ortiche a bordo strada, alle infestanti nei giardini della serenissima.
Le erbacce si coltivano perché sono belle, in fondo, perché la normalità stanca, la mediocrità congela e chi la vuole allora la normalità, se volete il matto, allora matto divento.

Al destin de un om
Al podeva capitate anc a ti
Nasce t’un pegnatòn
Tra zovatz e zufignes
De stries cencja prozes
E al dolour grant de ‘na mare
Me soj cjatat a passa
De che bandes
[Il destino di un uomo Poteva capitare anche a te / nascere in un pentolone / tra rospi e intrugli / di streghe senza processo / e il dolore grande di una madre // Mi sono trovato a passare / da quelle parti]
E i preti, madonna quanti preti nella vita di Federico, tutte quelle sottane nere di corvi, e la chiesa e le preghiere e quel dio che almeno una volta potrebbe battere un colpo.
Il collegio Don Bosco, per raddrizzare quel figlio sghembo, pensa il padre, ti farà bene, lo rassicura. A fine anno è quinto su tutti perché sa scrivere Federico, è bravo. Ma non era scemo? si chiedono in famiglia. E come si fa a deludere il sangue del tuo sangue. E da quinto diventa lo zimbello, parla poco, urla molto, lo volete il matto, eccolo qui, a prendere botte dai compagni e le punizioni dei preti, quelle sottane sporche di fango e una notte intera in piedi sotto la pioggia, difenditi cretino gli dicono i preti.
San cugnî
1.
S’e soi brut e cjatîf
Ch’e me doi apena al bundì
No me sopuarte
Ch’e non me doi mai razon
Me soi antipaticu
Ch’e e goze massa
Me insordìs
Che pa’ no cjatâme
E scjampe
Che
Jò
‘e cun
Tignîme
2.
Ai da stâ dentre al tiô vuoe pas jôdeme
3.
A quindes an ‘e vêve i dincj rotz
Adés ài i dincj rotz
A quindes an ére mal vestît
Adés ‘e soi mal vestît
Culturalmente sempre chiel
[Necessità 1. Se sono brutto e cattivo/ che mi do a malapena il buongiorno/ non mi sopporto/ che non mi do mai ragione/ che sono antipatico/ che grido troppo/ mi rompo i timpani/ che per non trovarmi/ scappo/ che/ io/ devo/ tenermi 2. Devo stare dentro ai tuoi occhi per vedermi 3. A quindici anni avevo i denti rovinati/ adesso ho i denti rovinati/ a quindici anni ero vestito male/ adesso sono vestito male/ culturalmente sempre lo stesso]
Dove si mette la sofferenza che sgorga come acqua di una fontana? C’è un luogo in cui portarla? Un’isola ecologica dove riciclarla? Cosa si fa di tutta quella tristezza in esubero? Dove si butta, come si butta, come si estirpa, dove finisce, in quale canale di scolo va smaltita?
Fadîa
Ce fadia convince la zent
Che al gno mout de vive
A no je fai mal a nisciun
[Fatica Che fatica convincere la gente/ che il mio modo di vivere/ non fa male a nessuno]
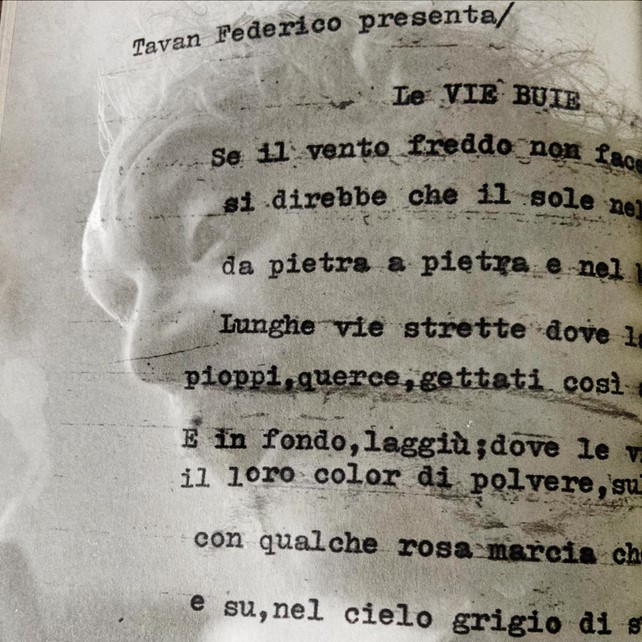
È un viaggio allucinato la vita di Tavan e io mi ci voglio sedere in prima fila, nella giostra della sua difformità, la voglio respirare fino a quando mi uscirà il sangue dalle orecchie per la troppa pressione. Mi calo il casco da astronauta che poi sembra un poco una muta da palombaro, perché lo spazio e gli inferi si assomigliano spesso e sulla naf spazial mi faccio sparare in orbita a danzare senza fiato tra le sue parole, di Federico, quelle parole così lucide e opache, luminose e nere.
Quelle parole che sono le mie parole.
Non è una vittima, non è un condannato pur essendo stato tranciato dal giudizio altrui, di tutti o quasi. È uno che vive, che la vita se la mangia tra un caffè e una sigaretta, nonostante tutto e nonostante tutti, una vita che sferza tra i suoi versi e quella solitudine che si attacca alla coda come sale. Ma non è una vittima Federico, toglietevelo dalla testa, non è matto come dite voi. È uno che ci prova, a vivere, a modo suo, ci prova e voi mi sa che spesso non ci provate nemmeno.
Il monte Raut incombe su Andreis come un padre patriarca e d’inverno la cima innevata e poi d’autunno o a marzo, quando le nuvole nere si raccolgono attorno come una corona, sembra cadere giù, il monte Raut, sradicarsi dalle fondamenta come un dannato e piombare corpo morto su quelle quattro case. E ancora di corpi si tratta, troppo grandi, troppo in alto per raggiungerli.

Al mostru
Sì ‘e soi jò
Inventat da vo.
Ma dopo ‘e ve soi scjampat.
E dal mostru
Al paron ‘e soi deventat
[Il mostro Sì, sono io / inventato da voi / Ma poi di mano vi sono sfuggito / e del mostro / mi sono impadronito]
Comincia presto la processione tra casa e ospedali: le visite, i ricoveri, gli ambulatori, tra neurologia, dove ci sono “gli aspiranti”, dice lui, e psichiatria dove invece ci vanno quelli che ce l’anno fatta a diventar matti. Dov’è finito dio in questa liturgia laica, in questo rito di matite spezzate, di corpi abusati.
Non è matto Tavan, siete matti voi a non conoscerlo.
Sognando la religione
Signore
Non credo non credo
Eppure sono qui
Davanti inginocchiato
Ah se sapessi
Mi piacciono le contraddizioni
Per poter restare me stesso
Sono uno stupido
Non occorre che te lo dica
Il meno riuscito
Dei tuoi figli
Sono brutto sono un fallito
Eppure non ho nulla da chiederti
Non voglio miracoli per me
Mi accontento che il sole
Mi dica buongiorno.
Signore, non sono qui
Per fare la ruota come un pavone
Ma neanche per battermi il petto
Domandano perdono.
Io sono solo un bambino
Che piange e arranca a fatica.
Io muoio su una croce diversa
Mordendo i chiodi
E spingendo i piedi
Verso il basso a sentire
L’erba che cresce
Non chiamatelo poeta bambino, perché Tavan bambino non è mai stato, avrebbe voluto, certo. Non c’è niente dell’infanzia nel sentire il mondo senza pelle, nel partorire al mondo parole esatte, come un taglio chirurgico, senza sbavature, senza sbrindellare.
È una vita precisa quella di Federico, che risale la corrente del pregiudizio, che ci prova fino alla fine ad addentare una libertà che con la normalità ha davvero poco a che fare.
E zue su doi taulins
E zue su doi
Taulins
Sul taulin
Dal tuart e de la razon
Ai rezon
Sul taulin dal
Pierde e vinze
E piert.
[Gioco su due tavoli Gioco su due/ tavoli/ sul tavolo/ del torto e della ragione/ ho ragione/ sul tavolo del/ perdere e vincere/ perdo]
Federico è un mondo che non si esaurisce nelle parole degli altri. È corpo anzitutto, un corpo che agguanta lo spazio, che rimbomba, che si muove, che afferra, e una voce che urla, spesso, che impreca. Gesticola tanto Federico, traccia immagini, si mangia l’aria, si stende lungo un mondo che non lo vuole e allora lui se lo prende. Bisogna ascoltarlo nelle registrazioni che si trovano della sua voce; altro ancora diventano le poesie lette da lui. Bisogna guardarlo nelle fotografie che negli anni gli sono state scattate (Danilo de Marco, tra tutti), mentre si fa soggetto, icona, composizione, diventa immagine pur rimanendo sé stesso. Bisogna viverlo, Federico, fargli spazio tra muscoli e tessuti, farlo incuneare in mezzo alle ossa. Diventa cuore Federico, sistema linfatico, pezzettini di stomaco, piastrine, nervi, maledetti nervi. Non si risparmia, si dà tutto, non si trattiene, avvampa come un cerino in un moto di generosità entusiastica. Si spezza per questo, spesso, si sfrange sul petto di chi non capisce, chi lo divora perché fa comodo, chi lo deride perché la paura parla. Bisogna solo accoglierlo Federico, come una giornata invernale di sole, come una cosa che fa così tanto male da diventare bellissima.
Me pense mare
Me pense de cuan’ che
In t’una stanzia d’ospedal
E strengeva fuart
La man de me mare
Je vordave i vuoe gjai
Ch’i me lasciava par sempre
Poi i’ ài dit
Mare jò e te
‘e cugnìn nome muri
[Mi ricordo mamma Mi ricordo di quando/ in una stanza d’ospedale/ stringevo forte/ la mano di mia madre/ La guardavo negli occhi gialli/ che mi lasciavano per sempre/ Poi le ho detto/ Mamma io e te/ possiamo solo morire]
Scorticato, cavalca il mondo come un uccello in mezzo al vento. Senza pelle, è uno di quelli Federico, è uno di noi?
Solo una velina a segnare un confine che non è recinto ma soglia, tra il dentro e il fuori, quel dentro sempre esposto e quel fuori fortemente desiderato. Una soglia violata, spesso, dalla violenza comune. Vibra quella sottile membrana che non separa ma confonde, espone.
Fa tanto male la poesia, fa tanto male il mondo. Non c’è speranza nella poesia di Federico, è la poesia stessa la speranza, finché sgorga, finché placa e cura, poco ma cura.
Mont
In chist mont
Ch’al va indenànt
Jo me sòi fermat
Zà in che volta
Ultin
E ce fadìa pierde
[Mondo In questo mondo/ che va avanti/ io mi sono fermato/ già allora/ ultimo/ e che fatica perdere]
Detesto allontanarmi da casa, uscire dal piccolo borgo, mettermi in macchina, anche se mi sposto da un silenzio a un altro. I movimenti vanno sempre programmati con giorni di anticipo, pensati, valutati. Tentati. Sperimento la distanza dalla tana, lo strappo d’un cordone ombelicale che mi ingrassa come una scrofa. Mi nutro degli escrementi del mondo, prodotti di scarto che nella mia bocca brillano come denti d’oro.
Il movimento diventa ineluttabile quando il laccio delle emozioni comincia a stringere la gola, come peli di gatto. Allora esco, mi porto o mi faccio portare, chiudo il gas e tiro le tende.
Mi sembra un enorme utero, Andreis. Confortevole come ogni caldo uterino, fino a quando non si cresce. Il feto prende forma, si allarga come un cimitero, grasso urlante, i nervi tesi e la testa al soffitto, un corpo grande grandissimo, una sagoma d’uomo che ha tanta fame che si mangerebbe il mondo ma non si può, il mondo non si fa mica mangiare così facilmente e allora fuma e beve caffè, di continuo, e divora cioccolato. E quando la pancia diventa tonda come una mongolfiera, l’utero sputa, si contrae in uno sforzo ferale e rigetta a tutta velocità, come uno spruzzo di vapore bollente, partorisce al mondo un uomo che grida tutto il suo dolore.
Forse Andreis non sa che farsene di quel corpo sudicio appena nato, così diverso, così poco conterraneo. I piccoli mondi non accolgono mai, è la legge ineluttabile della cosmogonia.
E i corpi non conformi fanno schifo a tutti, anche questo è un dato di fatto. Ma se non si può espellere, cosa si fa? Si incista, si nasconde, si fa proprio senza metabolizzare. Una gobba in un prato, una cicala a febbraio, un albero senza rami. Si diventa veduta, orizzonte che un turista ammira senza accorgersi di quell’anomalia che confonde il tramonto. Andreis soffoca in una specie di abbraccio sudato.
Quatre cjases in crous
Se no tu fai ad ora a scjampâ
Uchì tu devente vecje e tu mour
Un po’ de prâtz
Dos tre montz
Se non tu scjampe
No tu scjampe pì
Tu devente Andreis
[Andreis. Quattro case in croce. Se non fuggi in tempo, qui diventi vecchio e muori. Qualche prato, due o tre montagne. Se non fuggi, non fuggi più: diventi Andreis.]
Mi fa paura andare ad Andreis. Perché per arrivarci bisogna attraversare un budello di galleria che si incunea nella montagna e prima, prima di scivolare lungo la galleria, si percorre a quella che mi sembra una velocità inconsueta un ponte altissimo che sovrasta uno specchio d’acqua verde chiaro. E io vorrei fermarmi a fare almeno una foto di quell’acqua che sembra la lacrima di un gigante, ma non mi fermo su quel ponte, non mi sporgo da quel parapetto. Fisso la linea dell’asfalto e se solo alzo lo sguardo mi formicolano le mani e i piedi e la testa diventa ovatta.
Vorrei solo strisciare lungo quel ponte, a quattro zampe faccia a terra sangue dal naso pur di non guardare giù.
Non si abbandona la tana se non per un validissimo motivo e non si va ad Andreis, con quell’imbuto in mezzo alla montagna e quel ponte sulle pertiche se non si ama davvero Federico.
Fine
Dei vecjes
Splendours
De la me famea
Soi restat nome jo:
Un’urtìa
[Fine Dei vecchi/ splendori/ della mia famiglia/ sono rimasto solo io/ un’ortica]
E in un pomeriggio di gennaio che sembra quasi primavera capisco che ad Andreis ci sono andata per due motivi: guardare i rapaci recuperati che si trovano nelle gabbie gigantesche in cima al paese, quegli uccelli maestosi e selvatici che per un motivo o per un altro (e spesso la mano dell’uomo è questo motivo), non possono più vivere nella natura. Ho visto l’aquila per la prima volta, le zampe enormi, gli artigli e quello sguardo contornato da sopracciglia foltissime. Mi ha guardato dalla rete, appollaiata su una trave di legno. Uno sguardo così fiero e malinconico, che di quel paese e di quelle montagne mi sembra mi abbia raccontato tutto, in un infinitesimo di secondo. E un pochino, anche, di come vanno a finire le cose.

E poi per andare al cimitero. Ho cercato la tomba di Tavan e mi sono ripromessa di tornarci con un fiore e un biglietto.
È importante per me farlo, perché in questi giorni attorno a Federico si condensa parte della mia vita, come un simulacro, come un ex voto, in uno scambio ininterrotto tra i miei pensieri, le sue parole, luoghi e tempi e persone, poche.
Perché mio nonno la tomba non l’ha voluta, ha chiesto la cremazione e la dispersione delle ceneri in una fossa comune. E quel giorno di febbraio di tre anni fa in una giornata lattiginosa che non lasciava scampo all’inverno, un ragazzo di colore dai guanti troppo grandi ha svuotato mio nonno in una specie di pozzo senza fondo, la buca delle ceneri. E mentre io pensavo ancora a lui in un frigorifero dell’obitorio e mi chiedevo che cosa stavamo facendo là a guardare della polvere scivolare chissà dove, mia nonna mi guardava e mi diceva allora è finito tutto così, come se ci aspettassimo un colpo di scena, un segno che tutto quello stava succedendo sul serio.
E ancora mi domando perché ha scelto quella fossa comune, perché era un uomo pratico mio nonno e l’ho molto ammirato per questo. Ma oggi vorrei tanto andarci, su una tomba, a portargli dei fiori di stagione e a dire cose a voce bassa, nel giorno dei morti e anche in altri giorni ci andrei e mi sembrerebbe un buon modo per mantenere vivo il suo ricordo nella mia mente che mi sembra si appanni con il tempo e lo so che non è possibile, ma avrei ancora un rito da seguire, qualcosa da fare invece di stare solo a contare i mesi e gli anni che sono passati da quel sedici gennaio.
Ti è piaciuto questo articolo? La copertina? La redazione? Tutti e tre?

