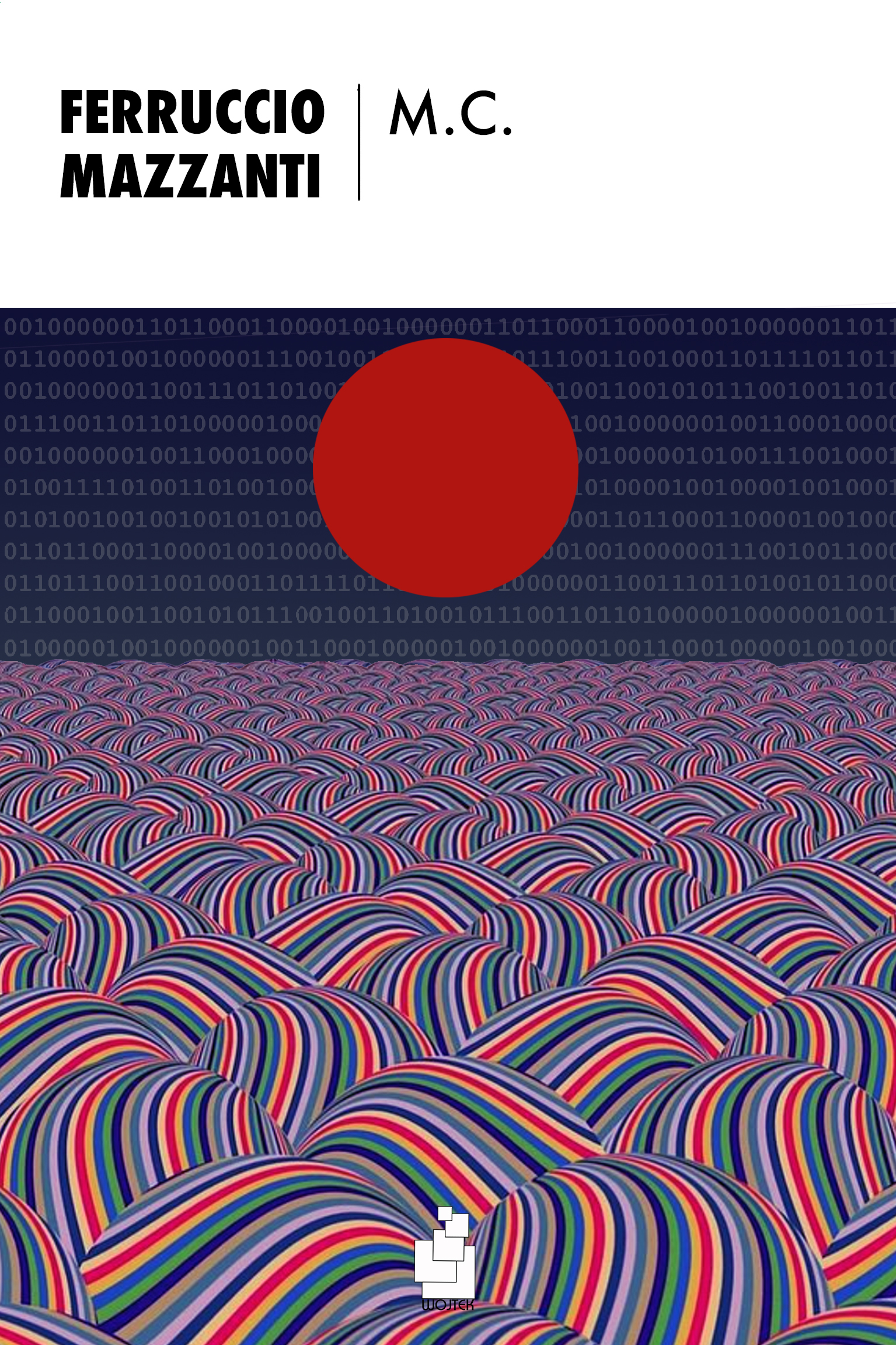di Ferruccio Mazzanti (risposte) e Carlo Martello (domande)
Copertina di Antonio Bobo Corduas per Wojtek
Ferruccio Mazzanti, autore di M.C., che è il suo secondo romanzo, uscito sempre per Wojtek dopo Timidi messaggi per ragazze cifrate, ha accettato di parlarci del libro attraverso una breve serie di domande, che vogliono essere in realtà delle suggestioni, dei canali verso la complessità del romanzo, che è un testo accessibile a chiunque eppure consapevolmente stratificato. Sempre di M.C. è possibile leggere un breve estratto qui.
Carlo Martello: Per provare a dare un quadro d’insieme, partirei dalla struttura del romanzo e da alcune caratteristiche evidenti: è un romanzo che mescola fantascienza, filosofia, storia del capitale, elementi classici della forma romanzo, sperimentazioni linguistiche, metariferimenti a una quantità di altri testi considerevole, altro che mi sto perdendo e che ti invito a menzionare, se vuoi, se credi che possa giovare alla lettura. Tutto questo in una struttura fatta di capitoli autoconclusivi, che possono essere letti autonomamente o come romanzo classico, dalla prima all’ultima pagina. Ogni capitolo rappresenta poi una fase di lavorazione. Come mai queste scelte?
Ferruccio Mazzanti: M.C. è costituito da sedici capitoli che possono essere letti sia consecutivamente, in questo caso sarà come leggere un romanzo vero e proprio, oppure seguendo un ordine a caso, come se i capitoli fossero dei racconti. In realtà non si chiamano capitoli, ma fasi, cioè momenti della catena di montaggio (del significato del libro). Ogni fase è autoconclusiva, ma al contempo è inserita in un concatenamento. Il vero senso del libro è proprio il concatenamento prodotto dalle varie storie che vengono raccontate in ogni fase. A spiegarlo è più complicato che a leggerlo.
Il tema è quello del lavoro nell’epoca neoliberale. Non volevo scrivere un libro che avesse il lavoro come sfondo. Spesso mi capita di leggere romanzi dove le vicende di un personaggio si svolgono in situazioni lavorative di vario genere, ma il conflitto poi ruota intorno ad altre problematiche (l’amore, la droga, l’emancipazione dai genitori, il matrimonio, ecc…). Quel che volevo fare era invece porre il lavoro come conflitto principale e vedere quali conseguenze esistenziali produceva nei vari personaggi che affollano il libro, fino a inghiottire il libro stesso nel concatenamento lavorativo del neoliberismo.
Quindi ho scelto questa struttura per vari motivi, il primo era perché la frammentazione della vita lavorativa di oggi poteva essere descritto solo attraverso la frammentazione dei punti di vista di una persona che entra nel mondo del lavoro. Volevo essere mimetico con l’esperienza di dover fare tante cose differenti per raggiungere la fine del mese, ma anche per mostrare le svariate sfaccettature della mancanza di diritti e tutele nei confronti del lavoratore. Inoltre, devo confessare, c’è anche una motivazione più intima: è che le cose semplici forse mi hanno un po’ annoiato, oltre a ritenerle offensive. Mi hanno annoiato perché sono sempre uguali a se stesse, dei pattern che vengono ripetuti incessantemente e che solo in un paese tradizionalista come l’Italia possono essere visti come narrativamente interessanti. Questi pattern vengono insegnati nelle scuole di scrittura e vengono applicati in modo scolastico. Niente contro i corsi di scrittura, ma molto contro la loro applicazione scolastica. Chi si prende il rischio di giocare, cambiare, azzardare? Spesso un libro che vuole porsi come artistico è più imperfetto e sbagliato proprio perché si sta creando le sue regole mentre viene scritto. Con M.C. volevo giocare, divertirmi e trovare la regola della sua forma attraverso la pratica della scrittura, una forma che voleva essere mimetica alla catena di produzione di una grande industria. Quando leggo un libro non pretendo la perfezione, voglio che l’artista sia un filtro da cui passa roba, a volte roba sbagliata, ma che sia in grado di trasmettere un messaggio nel modo più devastante possibile. Una volta una ragazza mi ha detto che l’arte deve lasciarla devastata, un’apocalisse emotiva. Con M.C. io volevo provocare questa sensazione a qualsiasi costo, una sensazione di fine del mondo, volevo che penetrasse nelle ossa del lettore, volevo scuoterlo. Inoltre credo che la semplicità di alcune strutture narrative sia offensiva, perché di base l’autore sta dicendo al lettore che non è capace di capire cose più complesse. Dunque da una parte volevo sorprendermi mentre scrivevo e mi rileggevo, sperando di riuscire a fare lo stesso con chi mi avrebbe letto, dall’altra volevo dire al lettore che io ho una fiducia cieca nei confronti della sua intelligenza. In questo senso M.C. è un libro strutturalmente elogiativo verso il lettore.
C. M.: La lettrice, il lettore, viene coinvolt* già nel breve testo che anticipa il romanzo vero e proprio e viene esplicitamente chiamat* a prendere posizione, a scegliere, a non essere passivo. Mi piacerebbe conoscere in maniera più approfondita le convinzioni che ti hanno spinto a questo approccio.
F. M.: Uno dei più drammatici problemi della contemporaneità è la nostra passività, una passività che impariamo dalla tecnologia che usiamo e che, una volta introiettata, riproponiamo in tutte le cose che ci accadono nella vita. Dunque tale passività ha delle implicazioni etiche, perché non siamo più in grado di agire, intrappolati in un intrattenimento che ci anestetizza di fronte agli eventi della vita e della storia in cui siamo inscritti. Sia il mio primo romanzo, Timidi messaggi per ragazze cifrate, che M.C. sono una dichiarazione di intenti contro la passività dei nostri giorni. In questo senso definirei i due romanzi come inattuali, col significato che ne dava Nietzsche, ovvero che non seguono lo spirito del tempo in cui viviamo. Dunque chiamare all’azione il lettore è per me un modo per prendere una posizione etica nei confronti del mondo di oggi, che invece è indifferente e passivo, per chiedere al lettore di fare lo stesso, di scegliere in modo attivo.
C. M.: Nel romanzo ci sono, secondo me, due MacGuffin – il MacGuffin è quel pretesto narrativo, di solito in forma di oggetto ma non necessariamente, che muove il testo e che resta però un puro pretesto. Vale a dire che se cambiassimo il MacGuffin non cambierebbe il testo narrativo, cinematografico, eccetera. C’è quello che chiamerò “il piccolo MacGuffin”, ovvero il coltellino che accompagna la lettura dal principio alla fine e che rispetta tutte le regole del MacGuffin classico. E poi c’è “il grande MacGuffin”, che però allo stesso tempo non è un MacGuffin; o meglio, mi sembra che siamo di fronte al super MacGuffin, al MacGuffin supremo: il potere, in questo caso (riferendosi al romanzo ma anche alla cosiddetta realtà) incarnato dal capitale. Questa è la mia impressione. Qual è stata invece la tua volontà? Ho provato a semplificare molto, ma immagino che dietro alla decisione finale di questo immane Mago di Oz ci sia una riflessione più complessa.
F. M.: C’è un capitolo esplicitamente dedicato al MacGuffin. In quel capitolo una ragazza deve produrre MacGuffin usando le macerie scaturite dai capitoli precedenti. Questo è il suo lavoro. Per me rappresenta una metafora di molti lavori di oggi, che sono ormai dei meri espedienti narrativi per far andare avanti la storia. Ma quale storia? La nostra storia personale, cioè quella narrazione che ci raccontiamo a noi stessi su chi siamo davvero, quindi una narrazione psicologica che avviene solo nella nostra mente. Noi abbiamo bisogno di raccontarci che il lavoro che stiamo facendo è utile. Dobbiamo raccontarci che senza quel lavoro la vita nostra o di qualcun altro perde di significato. Oscar Wilde diceva: Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare. Certo, è un’affermazione molto snob, detta da un ricco dandy irlandese, tuttavia rivela qualcosa di profondamente vero, cioè il nulla intorno a cui ruota la vita contemporanea che deve essere riempito di significato attraverso il lavoro. Noi lo facciamo tutti i giorni quando andiamo in ufficio, perché se accettassimo che invece il lavoro non ha alcun significato, che è solo un espediente narrativo, allora col cazzo che ci alzeremmo la mattina alle sette per stare seduti a una scrivania per otto ore, invece che amare le persone che amiamo, essere felici con loro, fare di tutto per conoscerle il più possibile, passeggiare, leggere, fare l’amore, correre, dormire e via dicendo, ma il tutto per il solo piacere di farlo. Quel capitolo di M.C. è un biasimo dell’inutile, ricorsiva follia del lavoro che ci sottrae tempo alle cose davvero importanti, biasimo portato avanti attraverso la metafora del MacGuffin, che a suo modo caratterizza tutto il libro, dato che il protagonista stesso del romanzo non è altro che un MacGuffin intorno a cui ruotano tutti gli altri personaggi. Dunque lavoro e potere sono due dei poli intorno a cui gravitiamo maggiormente, ma se solo fossimo capaci di cambiare prospettiva, come dire cambiare narrazione, forse li vedremmo per quel che sono, ovvero MacGuffin, cioè espedienti narrativi. In quel capitolo cerco di mostrare in modo esplicito la trappola psicologica soggiacente alla nostra idea di potere e lavoro per smascherarla. Se vuoi tutto il libro mira a questo fine.
C. M.: Questa è una mia fissazione da romantico. Senza svelare troppo della trama di M.C., che è appassionante e con momenti molto lirici, altri molto dolorosi, altri stranianti, un ruolo è stato assegnato alle dinamiche d’amore, pure in questo universo completamente inglobato dal lavoro e dal capitale. Trovo che sia paradossalmente realistico, addirittura saggio, inserire elementi amorosi in un romanzo concepito come M.C. Qual è la tua opinione?
F. M.: Non ho un’opinione in particolare, però ho pensato che l’amore potesse essere un modo per rimarcare quanto sia terribile la contemporaneità. In questo mi sento di citare una scena straziante di Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini. Un ragazzo e una ragazza vengo scelti per fare sesso tra loro. I loro torturatori li stanno osservando con la lascivia tipica dei mostri che sperimentano la violenza sadicamente. I due ragazzi si lasciano andare a un momento di amore. Li vedi che si guardano, si toccano, si sorridono, si desiderano. Allora i loro aguzzini intervengono disgustati, perché nella logica di Pasolini il capitalismo concepisce solo la violenza, lo stupro come metafora, quindi l’amore, la tenerezza, il desiderio diventano per definizione il male. Quella di Pasolini è una critica senza pietà che io condivido in pieno. In M.C. ho voluto usare l’amore per far vedere come venga trattato dai nostri contemporanei, ovvero male, molto male.
C. M.: Il romanzo presenta diversi elementi di fantascienza (e chi legge potrà divertirsi anche a trovare alcuni riferimenti ai classici), tuttavia è importante dire che non si tratta di una distopia; M.C. è un libro che parla di oggi. Di più, in un certo senso, è un romanzo che si augura di non essere profetico, che chiede alla profezia di non auto-avverarsi. Sei d’accordo, cosa ne pensi?
F. M.: Tutto quello che ho detto fino ad adesso conferma le tue parole, anche se per me è più una descrizione che una profezia, cioè sta tutto già accadendo, solo che non siamo capaci di vederlo perché siamo accecati dalla narrazione che ci stiamo raccontando, ovvero di essere utili, di dover fare a tutti i costi e via dicendo. Questa incapacità di vedere cosa ci sta accedendo è forse il vero tema di M.C., perché tutti i personaggi sono incapaci di vedere qualcosa. Nel primo capitolo la società non vede la violenza di chi cerca lavoro, nel secondo il protagonista non vede in cosa consista il suo lavoro, nel terzo il fatto che le nostre vicende personali non ci fanno vedere il valore dei nostri collaboratori, nel quarto che il piacere derivante dall’essere accettati in un posto di lavoro ci cela che stiamo svendendo le nostre vite, e così via fino alla presa di coscienza della nostra stessa cecità. Una volta mi hai chiesto se ogni capitolo corrispondesse alla descrizione dei differenti effetti dei differenti stupefacenti. Ti rispondo adesso dicendoti che ogni capitolo corrisponde a un tipo di cecità di cui siamo affetti, cecità come metafora della mancanza di consapevolezza.
C. M.: Una questione formale (ma sappiamo bene che la forma è sostanza, eccetera), anzi due: ogni capitolo, ogni fase di lavorazione del prodotto ha uno stile diverso, coincidente con il protagonista o la protagonista. In questa varietà stilistica è sempre riconoscibile l’autore Mazzanti, eppure sono davvero stili anche molto diversi.
E poi, ma non in secondo luogo, gli elementi grafici, non dirò di più per non svelare nulla, non solo concorrono all’andamento del romanzo, ma almeno in un caso raccontano una storia parallela, quella del “piccolo MacGuffin”. Quanto sono importanti questi formalismi? Da dove vengono nella tua esperienza? E dove vogliono arrivare?
F. M.: Per quanto riguarda la questione formale, io sono un sostenitore della tesi anti kantiana espressa nei primi del novecento dal circolo di Vienna, ovvero che se il fenomeno condivide la stessa struttura del noumeno, uno dei due è di troppo (sto tagliando con l’accetta), che trasposto in termini estetici, se il contenuto condivide la stessa struttura della forma, allora sono la stessa cosa. M.C. vuole essere anche questo, un gioco sulla forma. Se vogliamo è il tentativo di vedere come al cambiare della forma cambi il significato, che nel caso di M.C. potrebbe essere sintetizzato nell’affermazione: nell’epoca del neoliberismo lavorare fa schifo. Ogni capitolo ripete questo messaggio con forme differenti. Quando si scrive qualcosa, prima si decide di cosa si vuole parlare (una principessa che viene rapita da un drago cattivo) e in relazione al messaggio che si vuole veicolare tramite la trama (che i draghi sono cattivi, oppure che le bambine devono imparare a difendersi da sole, o quel che volete voi) emerge la forma, perché forma e contenuto sono la stessa cosa. Se in un racconto vuoi dire un ciao amoroso, dovrai usare una determinata forma, se vuoi dire un ciao pieno di odio, allora userai una forma adeguata all’odio che vuoi esprimere. Dunque forma è contenuto, fenomeno è noumeno.
Per quanto riguarda gli elementi grafici, in realtà i romanzi già nel seicento e settecento avevano inserti grafici, come immagini, disegni e altro. Però la questione è più su quale sia il procedimento romanzesco. A mio giudizio è un procedimento che fin da subito ruba a qualsiasi altra arte per inglobare tecniche diverse all’interno della propria forma. All’inizio ruba dal teatro, poi dalla poesia, dal cinema, da internet, insomma il romanzo per definizione è un medium che ingurgita, è una specie di globulo bianco idrovoro che assimila tutto quello che gli capita a tiro. In questo senso io non credo nel concetto di genere letterario, perché per definizione il romanzo prende pezzi ovunque, cambiandogli di segno o posizione fino a trovare una nuova forma. Per me la letteratura rimarrà per sempre la piattaforma per eccellenza di sperimentazione nell’arte della narrazione, molto più che il cinema o altre arti basate sulle storie, anche se questa mia posizione può sembrare ancora una volta inattuale. Comunque sia, se accettiamo questa idea, allora il procedimento romanzesco può divorare anche gli elementi grafici più disparati e in questo senso ci sono moltissimi esempi nella storia della letteratura. A me non sembra che l’uso della grafica in un romanzo sia una cosa così strana, ma se lo fosse, allora M.C. sarebbe senza dubbio un libro innovativo.
C. M.: Ultima suggestione. In tutto il romanzo, ma in alcuni capitoli è particolarmente evidente, si ha l’impressione che i punti di vista dell* protagonist* derivino non solo dalle condizioni ambientali e dal loro proprio carattere, come è usuale, ma anche da specifiche alterazioni dovute a forme patologiche di ansia, paranoia, mitomania, eccetera, e allo stesso tempo da specifiche alterazioni provocate dalle specifiche fasi di lavorazioni, cosa riscontrabile peraltro anche nel cosiddetto mondo reale (una persona alla catena di montaggio sviluppa particolari patologie, una al computer ne sviluppa altre, una persona al lavoro con il pubblico altre ancora e così via). Infine, sempre allo stesso tempo, per cui questi punti di vista sono sempre stratificati, alcune altre specifiche alterazioni sembrano rimandare ad altrettanto specifiche droghe. Tutto questo per dire però una cosa solo apparentemente diversa e che mi sembra una delle chiavi di M.C.: quanto è importante avere, offrire, pretendere e ottenere altri sguardi? La domanda è in chiave letteraria (quanto è importante per descrivere o provare almeno a farlo la complessità del mondo e dei mondi) e politica (quanto è importante la pluralità degli sguardi per immaginare almeno un altro mondo).
F. M.: Il romanzo per me è per definizione la forma d’arte della democrazia, perché ti costringe a guardare un mondo con gli occhi di qualcun altro. È un esercizio all’empatia. Dunque leggere è per me un atto politico attivo, una forma di eticità proprio in nome della pluralità di sguardi che implica. Il che non vuol dire che la lettura ci salverà, leggere è necessario ma non sufficiente, piuttosto che chi non si esercita a praticare lo sguardo altrui attraverso l’arte in generale e la lettura in particolare, avrà più difficoltà a cambiare prospettiva quando per esempio dovrà capire la posizione di chi non è d’accordo con te. Se non ti eserciti in questa attitudine psicologica, farai più fatica a stare dentro al meccanismo della democrazia. La lettura può essere un bellissimo esercizio per salvarsi da quelle narrazioni bidimensionali tipiche dei totalitarismi, della propaganda, della pubblicità, del capitalismo più bieco, è un ottimo modo per ragionare, per essere persone attivamente consapevoli e in grado di ascoltare, anche se, purtroppo, è necessaria ma non sufficiente.
Grazie mille a Ferruccio Mazzanti e a Wojtek.
Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?