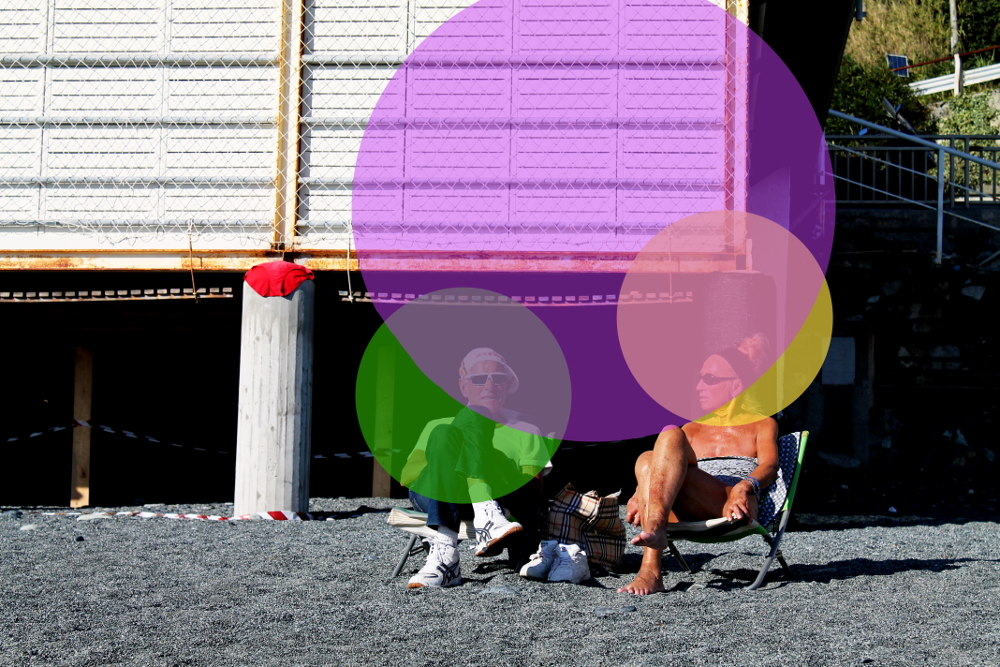di Silvia Guberti
Copertina: Senza titolo – Daria Pesce
È il 1993, Prost ha corso la sua ultima gara, Totò Riina è stato arrestato dopo ventiquattro anni di latitanza e io Gioacchino, sessantatré anni e il veleno che mi scoppia in corpo, la mia latitanza invece non l’ho ancora iniziata.
Vi chiederete cosa ci faccia in una drogheria piena di polvere e ottusità, a scrivere le mie memorie dietro questi pannelli di perline color rovere, prima di attaccarli uno a uno a pareti che non vedono un pittore dal 1934. Le ragioni si chiamano Adelina, mia moglie, e donna Amabile Caruso, sua madre, vedova di guerra che la solitudine ha fatto avvizzire nei sentimenti, ma non negli appetiti.
Con Adelina divido l’appartamento al secondo piano di questo fetido palazzo da ormai quarant’anni. “È una ragazza piena di amor cristiano” mi dicevano, donna Amabile in testa; e io fesso mi sono fatto abbindolare da quel faccino da suora mancata: dopo sette mesi dal nostro matrimonio è nato Gianmarco, “prematuro” di più di quattro chili.
Subito dopo il matrimonio, donna Amabile mi ha convinto ad affidare a lei i miei risparmi di giovane ragioniere, a lei che per tutta la vita aveva saputo moltiplicare ricchezze come una cornucopia. Mi sono trovato così a dipendere dalla megera per comprarmi anche le mutande, ma amavo Adelina, allora.
Eppure, cosa potevo mai aspettarmi da quella famiglia? I genitori di donna Amabile hanno rilevato questo bugigattolo nel 1929, strappandolo per pochi soldi a un poveraccio che si era giocato tutto ai dadi. Il ricavato non gli era bastato a coprire i debiti, e lo avevano ripescano nel fiume alcuni mesi dopo. I Caruso non se n’erano fatti un cruccio: quando uno è tanto stupido da vendere un negozio zona stazione per due lire allora se si ammazza fa un favore all’umanità.
Ma mi sto dilungando e il tempo stringe. Tre giorni: è quanto sono riuscito a spuntare per rinfrescare questo posto che meriterebbe solo di essere bruciato. E son già tanti, visto che donna Amabile non chiudeva il negozio dal 24 aprile 1945, quando le era giunta la notizia della morte del marito.
Fatto sta che ora pure il suo tempo è arrivato: la vecchia ci sta lasciando, e le cose non saranno più le stesse. Per cinquant’anni, ogni sera dopo la chiusura, si è seduta dietro la cassa a fare i conti (gli incassi sono l’unica cosa per cui prova un sentimento!) in un rituale tutto suo. Apre il libro mastro e con la stilografica che era di suo padre si mette a far l’amore con le cifre: si abbassa fino a sfiorare con la guancia le pagine, poi inizia a far di conto con le dita artrosiche; si alza solo quando le cifre sono scritte con le dovute grazie.
Una seria di dieci giorni fa, io e Adelina eravamo nel retro a fare l’inventario quando abbiamo sentito una specie di urlo da gufo. Ci siamo guardati e siamo corsi in negozio. Donna Amabile era stesa per terra e una sbavatura di inchiostro si allungava fino alla fine della pagina.
Adelina, che a malapena sa fare due più due, in lacrime ha subito telefonato a Gianmarco, perché senza donna Amabile si deve trovare un rimpiazzo per la contabilità, ma un rimpiazzo costa, e i soldi bisogna portarseli nella tomba.
Per anni aveva coltivato la speranza che potessi essere io il sostituto, ma un brutto esaurimento mi ha privato della capacità di ragionare di grosse cifre. Da quel giorno Adelina ha smesso di dormire nel mio letto, ma non si è fatta mancare quello del notaio che ha assunto il suo Gianmarco.
Tornando a noi, quando Gianmarco è arrivato in negozio l’ambulanza aveva già portato via donna Amabile.
«Non ci resta che pregare» ha detto. Sì, che muoia ho pensato io, e ho dovuto mascherare la risata con un accesso di tosse.
«In ogni caso, mamma, devi parlare con nonna» ha continuato Gianmarco «è ora che vada in pensione.»
Ad Adelina sono venuti i brividi, ma non è tipo da farsi scoraggiare, e così tra un pianto e una crisi di nervi è riuscita a convincere Gianmarco a parlare lui con la vecchia, e prima che potesse riprendersi del tutto.
La sera, mentre seduti in silenzio stavamo consumando la solita cena di erbe amare, è suonato il telefono. Adelina è corsa all’apparecchio e ho sentito la conversazione farsi concitata, poi i soliti lamenti, forse qualche lacrima. Quando è tornata a tavola, poco meno che raggiante, mi ha comunicato che Gianmarco avrebbe lasciato il suo lavoro per badare al negozio. Lo aveva convinto.
Sono riuscito a dire: «Non credo sia una buona idea».
«Può darsi, comunque era l’unica soluzione» ha risposto lei.
«E lui… lui come l’ha presa?»
«E come doveva prenderla? Lo farà e basta.»
Gianmarco mi ha fatto quasi pena.
«Dice però che bisogna rinfrescare il negozio, ma hai presente quanto costano le maestranze?» ha continuato.
Ho fatto finta di rifletterci, poi ho calato l’asso: «Potrei pensarci io».
E dunque ho tre giorni di libertà, tre giorni per scrivere la mia storia, per riorganizzare le idee, come mi ha consigliato tante volte il dottore. Ma dove lo scrivi un diario in una casa in cui di tuo non c’è neanche l’aria che respiri?
Se le cose andranno come devono andare, quando leggerete queste righe io non sarò più. Ma la mia storia è sincera, perché so che nessuna di queste bestie che sono la mia famiglia potrà mai leggerla. A voi posso confessarlo: le scannerò – lo giuro – una a una. Quando sarà tempo dei prossimi lavori, staranno tutti marcendo all’inferno.