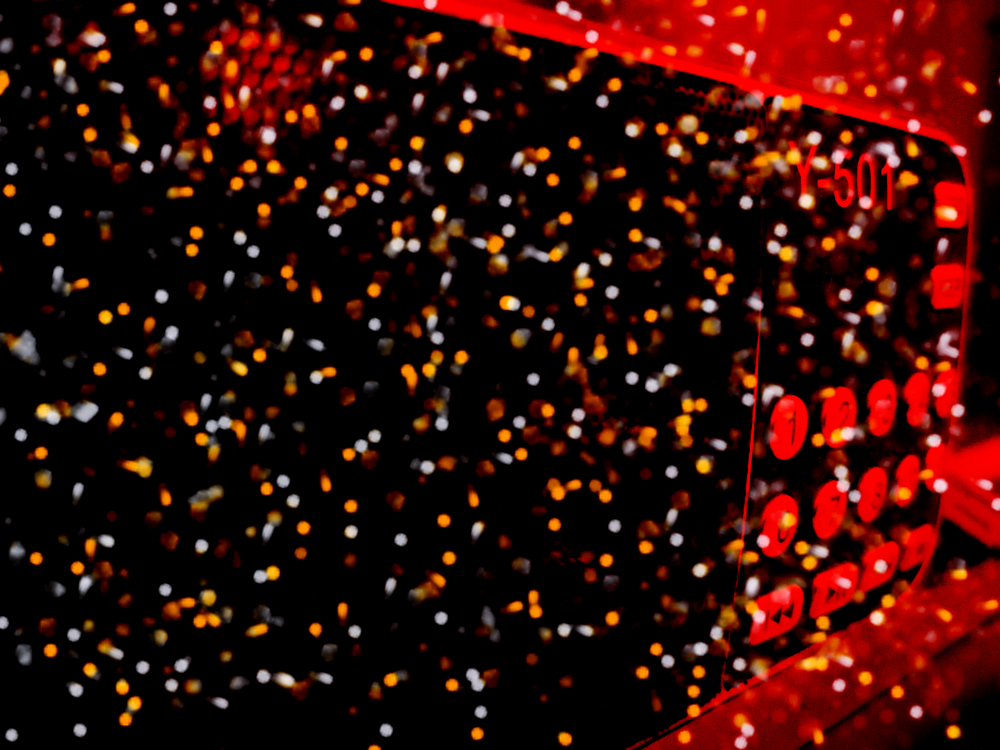di Gian Marco Griffi
Copertina: Communist Carnival – Antimonio
Alle politiche dell’ottantasette disse che avevo un vestito bellissimo e la pelle che profumava di buono. Ci eravamo incontrati all’uscita della scuola elementare e aveva cominciato a piovere, gli dissi grazie tante, mi lavo regolarmente, lui disse no, non è questione di lavarsi, la tua pelle profumerebbe anche dopo una giornata a vendemmiare o a spargere letame, io gli dissi che non avevo mai vendemmiato né sparso letame in vita mia, lui disse lo so, era un esempio.
Faceva sempre esempi. A sette anni faceva già esempi; mi parlava di trattori e di ragni grossi come topi nascosti nelle bigonce tra grappoli di uva nera, io dicevo che non esistevano ragni tanto grandi, lui diceva lo so, era un esempio. Si faceva bocciare in seconda media, veniva sotto casa mia a pregarmi di perdere l’anno anch’io, gli dicevo sei pazzo, lui diceva che non poteva vivere un anno a scuola senza di me, io gli dicevo dovevi studiare, lui diceva non ti vedrò più, io gli dicevo ci vedremo nell’intervallo, lui diceva che era un esempio, tre mesi dopo si ritirava da scuola. Il quattordici giugno millenovecentoottantasette avevamo diciannove anni, faceva esempi.
Mi invitò a bere qualcosa, gli dissi che ci sarei andata se mi avesse giurato che non aveva votato comunista, lui giurò di non aver votato comunista, andammo a al bar.
Ordinai un’aranciata, lui ordinò una birra e mi disse che aveva votato comunista. Gli dissi che era uno stronzo e feci per alzarmi dal tavolo, lui disse aspetta, mi afferrò un braccio, io lo guardai storto come per fargli capire che doveva lasciarmi andare, che mi faceva male, ma nella sua presa non c’era alcuna aggressività, c’era piuttosto dolcezza, oppure c’erano aggressività e dolcezza insieme.
Disse siediti, Anna, per favore, e io inaspettatamente tornai a sedermi, avevo caldo e la canottiera bianca appiccicata alla schiena, lui mi lambì la pelle con tre polpastrelli per accompagnare il mio corpo sulla sedia, io mi sedetti e gli dissi che era un bugiardo e un comunista, lui disse che era innamorato di me da quando avevamo sei anni, come se fosse una cosa di poco conto, come se si potesse dire una cosa del genere mentre il fumo di cento sigarette mi bruciava la gola e gli occhi, e soprattutto come se non lo sapessi già.
Gli dissi lo so che sei innamorato di me, lui disse che sua madre era una fascista pazza, io dissi che sapevo anche quello, tutti sapevamo che sua madre era fascista e pazza, lui mi chiese se poteva guardarmi per un po’, io dissi come guardarmi per un po’, lui disse sì, restare a osservarti in silenzio, io gli dissi che poteva fare quello che voleva, e restammo in silenzio a bere un’aranciata e una birra, lui accese cinque sigarette, tirava un paio di boccate e le spegneva in un portacenere della Campari dal quale traboccavano tremila mozziconi, mi guardava, io lo guardavo. Era bello, anche se aveva le unghie poco curate e le mani sporche, il viso leggermente butterato sulla guancia sinistra, ma aveva capelli bellissimi che nessuno avrebbe detto essere i capelli di un agricoltore e denti magnifici, incredibilmente ben fatti e bianchissimi.
Mentre eravamo in silenzio a guardarci (più che altro lui osservava me, io ero imbarazzata e cercavo ogni scusa possibile per voltare gli occhi da una parte o dall’altra) cominciò a canticchiare Amore che vieni, amore vai, dapprima silenziosamente, a denti stretti, poi sempre più forte, cantava bene, gli dissi smettila che ci guardano, lui cantava, io dicevo smettila o me ne vado, lui cantava e io dicevo che me ne andavo, ma non me ne andavo.
*
Alle politiche del novantadue mi chiese di sposarlo. Eravamo entrati al seggio mano nella mano, lui diede la carta d’identità al Giovanni, prese la scheda in mano e disse Anna, vuoi sposarmi? Il Giovanni e la Manola applaudirono, quello che c’era in fila dietro di lui gli strinse la mano, io mi precipitai nella cabina e ci rimasi un quarto d’ora a fissare i simboli, qualcuno bussò, iniziai a piangere, misi una croce, uscii e vidi Fausto sull’uscio della classe nella quale mi diede un bacio sulla guancia in quarta elementare (io gli diedi uno schiaffo, ma piano), si accorse che piangevo, o che avevo appena finito di farlo, disse che votare DC poteva fare quell’effetto, io gli dissi no, lui disse cosa no, io dissi no, non ti sposo.
Camminai un po’, non sapevo cosa fare, lui mi cercava in automobile, imboccai la prima stradina di campagna e cercai di ragionare, non ci riuscivo, mi venivano in mente cose grottesche e stupide, baci sul collo nel bagno del bar, viaggi in motorino senza meta, quando si fermava accanto a un cascina diroccata e diceva guarda che bello, io non ci trovavo niente di bello, gli diceva mah, lui strappava una foglia di qualcosa e me la porgeva, ripartivamo per vagabondare tra le colline, era innamorato delle case abbandonate, degli alberi secchi, delle strade spaccate dal sole, mi diceva che tutti i miei poeti greci avrebbero potuto scrivere un milione di versi senza riuscire a cogliere neppure un centesimo di quel magnifico abbandono, che era l’abbandono dell’uomo senza poesia e senza bellezza, io dicevo che i greci avevano scritto tutto, lui indicava un fienile bruciato da sessant’anni e mi diceva questo no, io gli dicevo anche quello, lui indicava una lepre nascosta in un cespuglio e diceva questo no, io gli dicevo quello sì, migliaia di volte, lui si spogliava nudo e cantava Mio fratello è figlio unico, mi lanciava la maglietta, i pantaloni, le mutande, le Espadrillas, diceva questo no, io gli dicevo smettila, scemo, lui cantava Mio fratello è figlio unico, cantava bene, io dicevo che i greci non avrebbero mai scritto di stupidi monferrini nudi in una cascina diroccata, lui rincorreva la lepre continuando a cantare, non smetteva mai di cantare, adesso la prendo, diceva, la lepre correva come una pazza nel cortile della cascina diroccata, io ridevo, stasera mi cucini la lepre, diceva, io gli dicevo scemo, la lepre fuggiva, non avevo dubbi e non avevo dubbi che l’avrebbe lasciata libera anche se fosse riuscito ad acchiapparla, lui si coricava sull’erba bruciacchiata e raccontava di suo padre, andavamo a caccia, diceva, sparava che faceva schifo, non aveva mai sparato un colpo neppure in guerra, il cane si lanciava e un fagiano si levava in volo con quella innaturale fatica propria dei fagiani e dei monferrini, mio padre prendeva la mira, io chiudevo gli occhi e sentivo lo sparo, quando li riaprivo il fagiano era lontano e mio padre bestemmiava, accarezzava il cane, l’ho fatto apposta, mi diceva, io gli volevo bene.
Pensavo cose di questo genere quando lo vidi in lontananza, ero quasi al campo da calcio, mi venne incontro e mi disse che non aveva votato comunista, io gli dissi per forza, lui disse non fa niente, io dissi cosa non fa niente, lui disse che non mi sposi.
*
Alle politiche del novantaquattro ero scrutatrice e quando lo vidi entrare mi prese quella sensazione che mi prendeva quando avevo tredici anni, ero in spiaggia, arrivava il ragazzo più bello che avessi mai visto e io mi giravo a guardare il mare, lui si avvicinava e mi diceva ciao, Anna, io mi sentivo impacciata e stupida, lo guardavo e dicevo ciao, anche se adesso non mi ricordo neppure più come si chiamava.
Disse ciao Anna, e mi diede la carta d’identità, io gli dissi ti conosco, non serve la carta d’identità, lui disse be’, magari ti sei dimenticata di me, io gli dissi no, non mi sono dimenticata di te, e gli diedi la scheda elettorale, lui disse grazie, entrò nella cabina e iniziò a cantare La guerra di Piero, cantava sempre, cantava bene, il Giovanni si voltò per capire quello che stava succedendo, il Giovanni è sempre stato un po’ sordo, mi guardò, io non sapevo cosa dire, guardò quelli che si sporgevano dalle loro cabine per chiedere spiegazioni e un paio che stavano attendendo il proprio turno sghignazzando, Fausto cantava sparagli Piero, sparagli ora, io ascoltavo il suo modo di pronunciare la ‘r’ e ridevo, il Giovanni mi disse che dovevo dirgli di smettere, io mi strinsi nelle spalle, Fausto cantava e dopo un colpo sparagli ancora, il Giovanni si avvicinò alla cabina, bussò piano, disse Fausto, lui disse non è la rosa non è il tulipano, il Giovanni gli disse Fausto, stai disturbando, Fausto uscì con la scheda piegata e disse no, Giovanni, sei tu che stai disturbando me, gli diede una carezza, infilò la scheda nell’urna (anche se non era proprio un’urna) e disse ma sono mille papaveri rossi, io lo guardai sorridendo, lui disse ciao, Anna, e io mi sentii come se avessi avuto tredici anni, in spiaggia, e quel ragazzo bellissimo di cui non ricordavo il nome mi avesse baciato sulle labbra.
*
Alle politiche del novantasei lui non venne a votare ma incontrai sua madre scombinata come al solito, si presentò e disse mi chiamo Tilde e sono la figlia del Podestà, io dissi buongiorno signora Tilde, sono Anna, si ricorda di me, lei disse chi sei, io dissi sono Anna, l’amica di Fausto, lei disse no, io pensai alla volta che ci sorprese sul divano nel salotto e Fausto disse mamma, non stai bene, lei disse sto benissimo, Fausto disse sono le tre del mattino, lei lo fissò e gli disse tu non sei figlio di tuo padre, Fausto le disse ancora con questa storia, mamma, basta, lei si sedette accanto a me sul divano e mi raccontò che i partigiani l’avevano stuprata, erano entrati in casa, avevano riempito di botte Steno, suo marito, e il Tec-Tec le aveva detto di scegliere tra i fascisti e una notte d’amore con lui, lei aveva scelto i fascisti, il Tec-Tec l’aveva presa con la forza e l’aveva scopata di fronte a suo marito, quel poveraccio, io le dissi mi dispiace, Fausto disse ma va, sono tutte balle, non è mai stata stuprata da nessuno se non nella testa, lei gli diede uno schiaffo, lui disse smettila, mamma, nel sessantotto non c’era nessun partigiano che stuprava le donne, lei disse lo dici tu, che sei figlio bastardo di un partigiano bastardo, e anche se sapevo benissimo che non era vero, quel racconto mi aveva colpita e ogni volta che la incrociavo non potevo fare a meno di ricordarlo.
Quando uscì dalla cabina il Giovanni si premurò di infilarle la pelliccia (era fine aprile, ma si era presentata con una pelliccia di visone), lei infilò la scheda nell’urna e io avrei tanto desiderato chiederle di Fausto, dov’era, cosa faceva, dirle che non lo vedevo da due anni, confidarle di quando mi raccontava che certe sere saliva le scale in punta di piedi per confondere i passi con la pioggia, saltava come una cavalletta sulla moquette, ladresco, rapinoso, entrava nella sua camera da letto e si facevo in un attimo serio in volto (un po’ buffo, presumo) e le toccava una spalla per appurare che fosse presente, che fosse viva (a volte gli bastava notare il lenzuolo sollevarsi appena, per via del respiro).
Le dissi buonasera, signora Tilde, lei non disse niente e uscì.
Quella sera al bar vidi gli amici di Fausto, lui non c’era, Bruno mi guardò di sfuggita, mentre prendevo il caffè si avvicinò e mi disse che Fausto era in Patagonia, io gli chiesi a far cosa, lui disse a far fotografie, io mi misi a ridere (non lo avevo mai visto con una macchina fotografica in mano), lui anche, torna tra un mese, disse, e si mise a ridere anche lui.
*
Alle politiche del duemilauno ci incontrammo sul viale che porta alla scuola elementare, camminammo insieme, lui disse che ero bellissima, io arrossii e gli dissi che ero fidanzata, lui disse lo so, dopo che votammo mi invitò a bere qualcosa, io non sapevo se accettare, accettai, lui mi propose di fare una passeggiata in campagna, era una giornata bellissima, dissi di sì, mentre camminavamo tirò fuori dalla tasca dietro dei jeans una radiolina a transistor perché c’era la partita, disse, ascoltava le partite alla radio da quando era piccolo, le ascoltava alla radio anche allo stadio o guardandole in televisione, lui amava le radiocronache, diceva la vita dovrebbe essere raccontata con una radiocronaca di Ameri, Ciotti, Dotto e Cucchi, io non avevo idea di chi fossero, lui disse ascolta, io ascoltai la voce di un uomo provenire dalla radio, lui disse mi piacerebbe che Riccardo Cucchi facesse la radiocronaca di questi momenti, io e te in campagna, i comunisti che prendono il cinque percento e Riccardo Cucchi che ce lo racconta, che dice amici all’ascolto, buongiorno, nonostante il mondo sia un posto di merda – lo sapete da soli, non c’è bisogno che ve lo ricordi il vostro Riccardo Cucchi –, posso garantirvi che tra le vigne del Monferrato è una bellissima giornata di maggio, io gli dissi di smetterla, lui prese in mano una foglia (non so per quale motivo), io feci per dire qualcosa ma lui disse no, ascolta la voce di Cucchi e ricorda che noi non vediamo niente, siamo in balia delle sue parole e delle sue emozioni, della sua pronuncia e dei termini che decide di utilizzare, io dissi sì, e iniziai ad ascoltare la voce che proveniva dalla radio, raccontava di una partita di calcio, io dissi che di calcio non capivo niente, lui disse di concentrarmi meglio, che se mi fossi concentrata avrei sentito Riccardo Cucchi raccontare dei pennuti del Monferrato, delle pietre sotto le suole delle scarpe, di un pozzo, di una foglia, di un animale appena nato, di Fausto che vota comunista ed è innamorato di Anna da quando aveva sei anni, di Anna che dice dai, sono fidanzata, di Fausto che dice lo so, di Anna che vorrebbe baciarlo e non lo fa, di Fausto che canta una canzone di Battiato, Anna che dice no, Fausto che attacca E ti vengo a cercare (attaccò a cantare E ti vengo a cercare), Anna che si commuove, e infine dice è davvero tutto, e ci lascia ciechi, senza sapere cosa fare, poi segnò la Reggina, o la Reggiana, il radiocronista disse che era stato un gol bellissimo, io dissi che dovevo andare, lui mi accompagnò a casa.
*
Alle politiche del duemilasei gli dissi che avevo abortito e che mio marito era uno stronzo, come ogni volta in cui non si ha più niente da perdere facemmo l’amore. Mi raccontò di suo cugino che era un neofascista, io gli dissi che avevo sbagliato ramo della famiglia, lui disse che suo cugino era un fascista strano, io gli chiesi strano come, lui disse che era gentile con tutti, io gli dissi che i fascisti potevano anche essere brave persone, lui disse no, impossibile, e aggiunse che suo cugino lo faceva infuriare proprio perché era impossibile che al mondo fosse nato un fascista buono, uno che teneva il busto di Mussolini in camera e che aiutava un barbone in strada, uno che odiava i comunisti e aveva adottato un bambino africano, io dissi che era possibilissimo, lui disse forse, ma mi fa incazzare lo stesso.
*
Alle politiche del duemilaotto entrammo nella scuola elementare insieme, ci eravamo dati appuntamento la sera prima, quando mi vide lui disse che ero bellissima, diceva sempre che ero bellissima, io gli chiesi se si ricordava la prima volta che avevamo votato, lui disse certo, avevi la pelle che profumava come oggi, attaccò a cantare Mi sono innamorato di te, nel seggio c’erano cinque persone e lo guardarono storto, lui disse perché non avevo niente da fare, io gli dissi di smetterla, votammo e finimmo in un bar a ubriacarci. Come ogni volta quando ero ubriaca gli parlai dei lirici greci e recitai un’ode di Anacreonte, lui la ascoltò in silenzio, mi avrebbe ascoltata in silenzio qualsiasi cosa avessi detto, alla fine applaudì e mi portò in un campo incolto, era un campo abbandonato sulla strada oltre il cimitero, restammo un po’ in silenzio a guardaci intorno, poi lui disse che quello era l’oltretomba degli eroi monferrini, io gli chiesi di spiegarsi, lui disse che ogni pietra di quel campo era un monferrino dimenticato dalla storia come un re minore, un maggiordomo di palazzo o un cavaliere errante impazzito per amore, mi mostrò le pietre (erano delle banalissime pietre incise con un nomignolo) e disse che se non lo sapevo in Monferrato non c’era neppure una pietra d’inciampo, io dissi no, non lo so, dissi che non avevo mai sentito nominare le pietre d’inciampo, lui disse che servivano a ricordare i cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti, ce n’erano in tutta Europa tranne in Italia, mi indicò le pietre nel campo e disse ecco, queste sono le mie pietre d’inciampo per ricordare gli eroi monferrini dimenticati da tutti, guardai con attenzione, nel campo c’erano centinaia di pietre, gli chiesi se tutti quei monferrini erano stati deportati nei campi di sterminio, lui disse no, i nostri eroi sono diversi, e mi mostrò la pietra di Lito che morì per troppa immaginazione, quella di Velio che morì per troppo dolore, quella di Luigi che morì per troppa ingenuità, quella di suo padre, morto per troppa stanchezza un giorno in cui sua madre era una principessa russa, e quella di Arturo che morì per troppe partenze e per troppi ritorni, che navigò i mari del mondo su un peschereccio e annegò nel Pacifico sognando di tenere una vigna, che odiava il mare e fu rifiutato dalla terra, i cui figli erano tritoni e sirene, le cui ossa furono spolpate dal sussurro sottomarino.
Restammo più di un’ora in quel campo incolto circondato dai castelli e dalle torri dei villaggi sfilacciati sullo sfondo delle Alpi, io gli chiesi se avessimo dovuto pronunciare una preghiera, lui disse no, questo oltretomba non ha divinità, e canticchiò una canzone di Brassens, anche se il suo francese faceva schifo.
*
Alle politiche del duemilatredici pensai che saremmo potuti morire prima, in qualsiasi momento, e nessuno avrebbe sentito la nostra mancanza, ma eravamo ancora lì, pronti a scegliere qualcuno o qualcosa, uscimmo dal seggio e andammo al bar, e mentre camminavamo tenevo la mano infilata nella tasca dietro dei suoi pantaloni, anche se forse non avrei dovuto.