di Maria Natoli
Copertina: Città notturne – Berlino – Julio Armenante
Agosto
Uscendo dall’ultimo vagone so che il gruppo di persone davanti a me deve svoltare a destra, perché non c’è altro modo per raggiungere l’uscita. E invece un uomo piccolo e magro, che cammina con movimenti scattanti e coordinati, a braccia e gambe larghe, prosegue dritto e io vedo, io da sola perché le porte si sono chiuse subito dietro di me e il treno è ripartito, che stampa un bacio sul manifesto retroilluminato dell’IGP Decaux.
«Ti amo. Teng’ sul a te!».
L’uomo ha baciato la bocca di Gesù nel Compianto sul Cristo Morto di Botticelli, in mostra a Palazzo Zevallos. Lo so perché l’ho letto mentre aspettavo il treno all’andata. Ma lui, mi chiedo, come ha fatto a riconoscere Gesù? L’uomo vende mini block-notes e penne di pessima qualità nei vagoni della metropolitana e forse per questo, o perché ha baciato con lo schiocco il vetro sporco di un manifesto pubblicitario, o perché quel quadro non lo conoscevo nemmeno io prima di questa mattina, mi sono fatta l’idea che non può saperne nulla di Botticelli e di quell’opera in particolare dove Gesù non ha nemmeno la barba.
Più che anche lui abbia letto la stessa didascalia che ho letto io, mi sembra più probabile che quel tizio sia così intimamente connesso a Gesù da percepirne subito la presenza, ovunque si trovi. Così rallento e lo osservo incuriosita. Lui si volta e mi fissa e io, per far sì che non sospetti che lo ritenga più sensitivo che capace di riconoscere un Gesù così poco iconografico, faccio una cosa precisa: lo guardo con benevolenza. Allora lui mi si affianca e dice:
«Anche a te… Ti piace… Gesù?».
Ma io me la sono mai fatta questa domanda, mi chiedo, e intanto sorrido e comincio ad allontanarmi impercettibilmente. Siccome ho la frangetta, la maglietta e righe e soprattutto non parlo, lui mi scambia per una turista e mi incalza da dietro:
«Comm’ sì bell… Ma si’ è Napul’? Vuò venì cu’mme? Te port a mangià ‘na pizz…».
Per un attimo, per un brevissimo istante, penso a questa eventualità. Il tono diventa sempre più suadente:
«Comm’ a vuò a pizza? Comm’ te piace?».
Penso anche a questo. Che pizza mi piace e comunque quale sceglierei se dovessi andare a pranzo con questo sconosciuto a cui chiederei di parlarmi ancora di Gesù?
«Te piace ‘a margherita? ‘A vuò ‘na bella margherita? O vulisse ‘na marinara?».
A questo punto il tono diventa abbastanza osceno da alludere, con margherita e marinara, a due posizioni sessuali. Così ho paura e accelero.
Il corridoio che unisce le stazioni di Museo e di Cavour del passaggio metropolitano di Napoli è molto lungo e intervallato da due serie di tappeti mobili. La prima volta che l’ho percorso ero con mia madre e avevo uno zainetto di peluche a forma di leone di cui andavo molto fiera. Mia madre mi intimò di indossarlo al contrario, sul petto anziché sulle spalle. Lei si riferiva certamente al pericolo che qualcuno potesse derubarmi; io invece pensai alla necessità di difendere lo zainetto in sé, il peluche del leone, così feci quello che mi aveva ordinato e una volta a casa riposi lo zainetto al sicuro e non me lo misi mai più. È ancora intatto da qualche parte. Ecco, su questo stesso corridoio mi sta seguendo il tizio continuando a elencare le pizze pornografiche mentre un signore anziano, affaticato, cammina davanti a me. Anche se molto distante, so che potrei raggiungerlo in un tempo brevissimo perché è molto anziano e molto affaticato. Oltrepassarlo mi sembra irrispettoso, quindi vado avanti con passi cadenzati e lenti ma finisco per raggiungerlo lo stesso. Lui si volta infastidito e allora cerco di assumere un’espressione che dica: “è vero, sono riuscita a spostarmi in breve tempo su un tratto che lei ha percorso con difficoltà, ma a questa difficoltà io porto un enorme rispetto, non faccio parte di quella generazione che supera la precedente senza voltarsi indietro ed è perciò con grande umiltà che sono costretta a dirle:”
«Permesso, mi scusi…»
Il signore anziano sembra raddolcirsi e mi fa:
«Mi sembri una cavalla da monta».
Sulle prime non capisco, poi realizzo: l’acciaio del tappeto mobile, i passi cadenzati e lenti, il rumore che fanno gli stivaletti alti senza sotto-tacchi.
Ripenso a questo episodio mentre il tizio delle pizze pornografiche si stufa e se ne va – penso pure alla prossima pizzeria del centro storico in cui finirò e a un cameriere qualsiasi con un mini block-notes che prenderà la mia ordinazione – ma una parte di me continua a chiedersi se me lo ritroverò alle spalle a piazza Cavour, se continuerà a seguirmi su via Foria e fino a casa. Il motivo per cui me lo chiedo, cioè il motivo per cui ho paura, ha molto poco a che fare con le probabilità e molto di più col fatto che a casa Pessoa non tornerà più. O almeno non tornerà stasera. O almeno non fino a quando non avremo deciso che cosa fare e allora lui tornerà per prendere le sue cose o per restare dopo che io avrò preso le mie cose. Giro la chiave nella serratura e la prima cosa che vedo è il pothos. L’ho sistemato su un vaso pensile e ho lasciato che le foglie rampicassero attorno all’orologio a muro. Rivolgo lo sguardo a tutte le disposizioni di cose che ho messo a punto io. Sono tante e mi sono costate fatica. Il motivo per cui non vorrei essere io ad andare via sta tutto qui, nelle cose, nelle disposizioni delle cose a cui mi sono affezionata, e nella fatica contenuta nell’idea di doverle portare via.
Quando torno da mia madre, lì dove Pessoa mi rinfacciava di dire ancora “a casa mia”, mi accorgo delle sue disposizioni, alla mancanza delle quali credevo di non riuscire ad abituarmi mai. La sera in cui io e Pessoa andammo ad abitare insieme mi abbandonai a un pianto disperato pensando alle mie abitudini, al mio letto, alle prime cose che vedevo al risveglio, al mattino, da anni. Ma soprattutto piangevo per mia madre, perché lei era triste e io non potevo farci nulla. Per questo motivo, adesso, mentre pranziamo e mi chiede di Pessoa, dov’è e cosa sta facendo, quando torna dal viaggio di lavoro, la detesto, vorrei rovesciare il piatto e rompere un sacco di altre disposizioni. Invece dico solo:
«Il 26».
«Che hai deciso? Non vai più a trovarlo?».
«Mò vediamo».
«Se vai col treno ti posso accompagnare fino a Torino, così vado a trovare zia Maria».
«Mò vediamo».
«Stai secca secca. Una volta tenevi delle belle zizzelle».
«Nun dicer strunzat, sono sempre state piccole, pure quando ero più chiatta».
«Ma statt’ zitt’».
«Ma statt’ zitt’ tu».
Mia madre vuole bene a Pessoa, ha intuito qualcosa ma non riesce a capire cosa sta succedendo. Un po’ la detesto e un po’ mi dispiace per lei. Ogni volta che vado a trovarla cerco di godermi il tempo passato insieme perché so che quando non ci sarà più, il dolore che proverò sarà atroce, violentissimo. So che ci saranno fiumi e fiumi di cose, vestiti, scarpe, paracalli, buste per la spesa, pillole per la pressione, divise da lavoro, salvadanai, borselli, catenine, santini, appunti che mi devasteranno. So che avvertirò la terribile mancanza di ogni giudizio, di ogni recriminazione, di ogni frase fuori luogo. So che mi sentirò sola e terrorizzata, so che il vuoto che avvertirò dentro sarà il doppio, il triplo, il quadruplo, rispetto a quello che provo adesso a causa di Pessoa e che lo sentirò per un sacco di tempo, forse per il resto dei miei giorni. So tutto questo eppure finisco sempre per alzare la voce e risponderle male.
«Comunque non vado più a Procida. Alla fine andiamo a Gaeta, a casa di Gobetti…»
«Come ci vai?».
«Col treno».
«Ma tu sola a Procida?».
«A Procida? ».
«Tu he ‘itt a Procida, andiamo a casa di Gobetti…».
«Allora hai sentito che andiamo a casa di Gobetti, perché mi chiedi se sto da sola?».
«Ahé, tu hai detto “vado da sola col treno”. No?».
«…Sì».
«Statt’ accort che ad agosto in giro sui treni ce stann’ ‘e pazz’».
Mia madre ha lavorato in ferrovia. Mi sta dicendo che è sicuro che domani sul treno ci saranno dei pazzi.
Al mare, il mio amico Gobetti mi dice una di quelle frasi che sanno essere agghiaccianti e rassicuranti insieme.
«Le relazioni, soprattutto le relazioni sentimentali, non sono meritocratiche».
«Che è come dire che non è colpa mia se ci siamo lasciati… ».
«Esatto».
«… e nello stesso tempo che non è per le mie qualità se ci siamo messi insieme».
«Appunto».
«E ora qualsiasi tattica, ogni strategia, è di fatto inutile…» .
«Sì».
«Nemmeno i consigli degli altri in questa fase hanno molto senso?».
«Nessuno».
Pessoa, nelle ultime fasi del nostro rapporto, senza farlo davvero apposta, qualche colpa me l’ha elencata. Mi ha detto:
1. che sono costantemente depressa;
2. che non sono mai riuscita a distaccarmi dalla mia famiglia;
3. che non coltivo nessun interesse al di fuori della relazione;
4. che si sente quotidianamente responsabile nei confronti del mio tempo libero;
5. che tendo a frenare ogni entusiasmo;
6. che il mio stile di vita ha reso la relazione solo abitudine;
7. che non ho nessun senso pratico;
8. che non prendo mai l’iniziativa;
9. che ho una concezione decisamente adolescenziale dell’amore;
10. che sono troppo gelosa.
Non ho molto da obiettare, a parte quello che ha detto la mia amica Tamara de Lempicka al sentire questo elenco: «Sì, è vero che tu sei un dito al culo, ma sei sempre stata un dito al culo».
È un episodio di qualche tempo fa. Io e Pessoa siamo a casa del nostro amico Jiménez. A un certo punto Pessoa e Jiménez se ne vanno fuori a fumare. Io resto in cucina, sul tavolo c’è il telefono di Jiménez. Mi avvicino al tavolo, prendo il telefono. Non ha nessun blocco schermo. So esattamente che cosa voglio fare. Riconosco la sensazione, è quella che mi prende tutte le volte che provo a spiare Pessoa. Trovo la chat di WhatsApp tra Pessoa e Jimènez e la apro. C’è uno scambio in particolare che colpisce la mia attenzione.
Jiménez: Ma la vuoi finire di fare il rattuso con @winnie_cupcake?
Jiménez: Bona…
Jiménez: Ma chi è?
Pessoa: Hahaha
Pessoa: Era un mipiace-mangiacazzo quello
Pessoa: È una a cui ho dato un palo al liceo.
Ora, c’è una cosa che mi tormenta, una cosa che non riesco a togliermi dalla testa, e riguarda Pessoa e Jiménez. Mi sembra che l’uno serva all’altro per provare di riflesso uno stimolo sessuale, che i loro desideri si eccitino a vicenda e si concentrino su un oggetto che però è uno solo. Visualizzo l’immagine di due uomini e una ragazza. Di due uomini sopra a una ragazza. Di un uomo sopra e un uomo sotto una ragazza. Di un uomo dietro e un altro davanti a una ragazza. Le immagini che mi si formano nella mente sono molteplici, sono tutte tratte dalla pornografia o dalla cronaca nera e trasfigurano Pessoa con una forza incredibile, Pessoa che si mangia il cazzo, che si pente, per aver dato un palo a una che è diventata bona e che comunica tutto questo pubblicamente, con un’evidenza che ha colpito subito Jiménez e quindi tutti gli altri.
«Esistono degli stimoli esterni alla relazione, esiste la possibilità che a me possa piacere qualcun altro e tu non hai nessun modo per controllarlo, anche se spii le mie conversazioni private. Per cui o ammetti questa possibilità, come l’ammetto io, e ti concentri sul nostro stare insieme ora, nel presente, o decidiamo di lasciarci perché tu non riesci ad accettare questo pensiero».
Non è questo pensiero che non riesco ad accettare; o meglio, è questo pensiero e insieme il fatto che Pessoa non sia l’incarnazione di un risarcimento totale, assoluto, per me, rispetto a tutto quanto di ingiusto, di doloroso, c’è nel mondo. Un peso terribile da sopportare, me ne rendo conto.
Il mio amico Anacleto ha fatto un post su Facebook. È una foto dove sta molto bene, con un suo commento dove dice di stare molto bene. Tra i commenti c’è quello di Pessoa. Sono tre goccioline rivolte verso l’alto, come un piccolo spruzzo. Pensavo fosse una cosa nostra per indicare l’orgasmo, per manifestare entusiastica ammirazione con una punta di malizia. Mi chiedo dunque se il mio amico Anacleto ne sappia qualcosa o se le tre goccioline non siano sdoganate a livello internazionale come icona dello sperma. Dopo un po’ il commento di Pessoa riceve un mi piace. Questo mi piace gliel’ha messo qualcuno che io sono convinta piaccia a Pessoa, come sanno piacere tutti quelli che sono in grado di lusingare la vanità. Io ho conosciuto un sacco di persone che hanno lusingato la mia vanità, e almeno un po’ mi sono piaciute tutte. Perciò mi fa un po’ male.
Stasera la mia amica Fedora mi racconta di quando ha fronteggiato un’invasione di formiche che, muovendosi in file compatte, sono arrivate al piano cottura e hanno finito per espugnare la macchinetta automatica per il caffè Lavazza A modo mio.
Succede che, dopo aver percepito la tipica afflizione delle persone ossessivo-compulsive e maniache del controllo in generale, Fedora, cercando su internet, trova il modo per disinfettare la macchinetta del caffè. Spruzza uno spray disinfestante all’esterno e all’interno dell’elettrodomestico, dopodiché ripone il tutto in una busta di plastica che annoda e lascia fuori al balcone tutto il giorno. Più tardi, Gobetti la raggiunge. Cenano, guardano un film insieme, Fedora si addormenta e, cercando Gobetti di non svegliarla del tutto, al momento di salutarsi tra i due pare essersi svolto all’incirca questo dialogo:
«Aspetta, scendo con te, devo buttare la spazzatura».
«Dalla a me, la butto io».
«No, devo prendere la busta che sta nel bidoncino fuori al balcone e poi non sai dove sono i bidoni dell’immondizia…».
«Dai, vado io, dove sono i bidoni?».
«Affianco al garage».
«E la busta della spazzatura?».
«Fuori, nel bidone…».
«I bidoni vicino al garage, spazzatura fuori, capito. Ciao Ciuciù…».
«Ghn-ghn…».
La mattina dopo Fedora va ad annaffiare le piante e nota subito qualcosa di strano, ma fatica a comprendere cosa. A un certo punto guarda il bidoncino dell’indifferenziata, istintivamente lo apre e scopre che la spazzatura è ancora lì; allora si gira verso il tavolo da esterni dove aveva appoggiato la macchinetta e si accorge della mancanza della busta di plastica. Essendo una persona ossessivo-compulsiva e maniaca del controllo in generale, quando prende il telefono per chiamare Gobetti, non lo so con certezza, ma deve avergli detto più o meno questo:
«Sei un cretino! Non posso chiederti di fare nulla, non sai fare nulla, sei un idiota! Hai buttato la macchinetta del caffè! Ma come hai fatto a non accorgertene, come si fa essere così stupidi! Vaffanculo!».
Dopodiché Fedora attacca e chiama i genitori in vacanza i quali, al sentire tutta la storia, non riescono a smettere di ridere e si passano il telefono a vicenda per farsi raccontare la storia da capo, e Fedora la racconta a l’uno e all’altra almeno un paio di volte, e quello che ascolta la storia ride e la commenta con l’altra che non riesce a trattenere le lacrime dalle risate, e a Fedora questa cosa che lei si era preoccupata di fare tutta ‘sta fatica per disinfestare la macchinetta e che quello l’aveva buttata e che questi ora si schiattano dalle risate la fa proprio incazzare, ma in qualche modo la calma pure e allora richiama Gobetti e, non lo so con certezza, ma deve avergli detto più o meno: «Gobetti, scusami se ti ho urlato addosso in quel modo, però mi sono proprio incazzata perché questa storia delle formiche mi ha esaurita e per disinfettare la macchinetta ho fatto una faticata, poi te l’avevo pure detto di prendere il sacchetto dal bidoncino…».
A questo punto però Gobetti, che è una persona mite e premurosa in generale ma anche dotata di amor proprio nella giusta misura, si arrabbia a sua volta; il suo monologo non lo posso improvvisare, un po’ perché Gobetti lo conosco meno di Fedora e un po’ perché questa storia io l’ho sentita raccontare un paio di volte, ma sempre da Fedora. In sostanza deve averle detto che lui sa di aver sbagliato ma che lei, che lo conosce, dovrebbe sapere che lui è ben capace di mortificarsi da solo. Inoltre, lui non si sognerebbe mai di chiamarla urlando e insultandola, nonostante ci siano state delle volte in cui se lo sarebbe meritato, perché lui l’ama e la rispetta. Così ricominciano a litigare.
Dopo qualche ora, Gobetti telefona a Fedora e le dice «Ho la tua macchinetta del caffè». Fedora pensa che sia andato a comprare un modello identico, come lui aveva giurato di voler fare, nonostante le proteste di Fedora perché non era quello il punto; invece Gobetti aveva proprio la macchinetta del caffè di Fedora, quella della sera prima.
Era successo questo: quando Gobetti è sceso da casa di Fedora, il camion dell’immondizia aveva già ritirato la spazzatura, allora lui si è messo la busta con la macchinetta del caffè nel cofano dell’auto e se l’è portata a casa, dove l’ha buttata nel suo bidone dell’indifferenziata. Fatto sta che, poco dopo, la madre di Gobetti, sapendo che il camion dell’immondizia in realtà era già passato anche a casa loro, è scesa per rimettere il bidone dentro il cortile e si è accorta che non era vuoto; allora l’ha aperto e ci ha trovato una macchinetta automatica per il caffè Lavazza A modo mio che sbucava da una busta di plastica. Incredula e indignata dal fatto che un estraneo fosse venuto a buttare l’immondizia nel suo bidone, l’ha tirata fuori e l’ha lasciata sul muretto dalla parte esterna del cortile. E così, quando Gobetti è sceso per andare a comprare la macchinetta del caffè nuova, ha trovato quella vecchia incredibilmente lì.
Il punto è che Fedora e Gobetti nel frattempo se ne erano dette davvero di tutti i colori e non potevano fingere di non essersi detti tutte quelle cose brutte, di essersi svelati tutte quelle verità l’uno sul conto dell’altra. Non potevano nemmeno fingere però che il ritrovamento della macchinetta del caffè non azzerasse in qualche modo tutto quanto, oltre alla difficoltà riscontrata nel tralasciare l’aspetto comico della cosa – i genitori di Fedora, al sentire il seguito della vicenda, avevano rischiato di sentirsi male tanto gli veniva da ridere e il padre di Fedora si era pure un po’ dispiaciuto perché era da tempo che avrebbe voluto cambiare la macchinetta del caffè.
Io so solo che Fedora e Gobetti hanno trascorso il giorno successivo ancora arrabbiati l’uno con l’altra, che non si sono parlati anche quando, a Ferragosto, sono andati fuori a pranzo con la famiglia di Gobetti; so che Fedora, per la prima volta dopo aver smesso da qualche anno, in quei giorni si è comprata un pacchetto di sigarette; e poi so che in qualche modo la cosa è rientrata, e questo non perché Fedora me l’abbia detto esplicitamente, ma perché è passato più di un anno e loro sono ancora insieme.
Mi viene in mente lo sguardo di Pessoa prima di andare via. Penso che un giorno potrei scendere di casa e trovarlo sul muretto dalla parte esterna del cortile, come la macchinetta del caffè di Fedora; penso alla possibilità, a quel punto, di dover decidere se dare peso a tutto quello che è successo tra la sua sparizione e il suo ritrovamento o abbandonarmi all’ilarità della cosa.
D’altra parte però penso pure che Pessoa potrebbe fare in tempo a finirci davvero nel camion dell’immondizia.
Fuori piove e domani dovrò tornare al lavoro. So che non è giusto scambiare l’amore con il bisogno di protezione e allora mi dico di cogliere l’occasione per fare un pezzo di strada in più sul cammino dell’evoluzione. Mi sa che a questo punto dovrò prendere la metropolitana.
Settembre
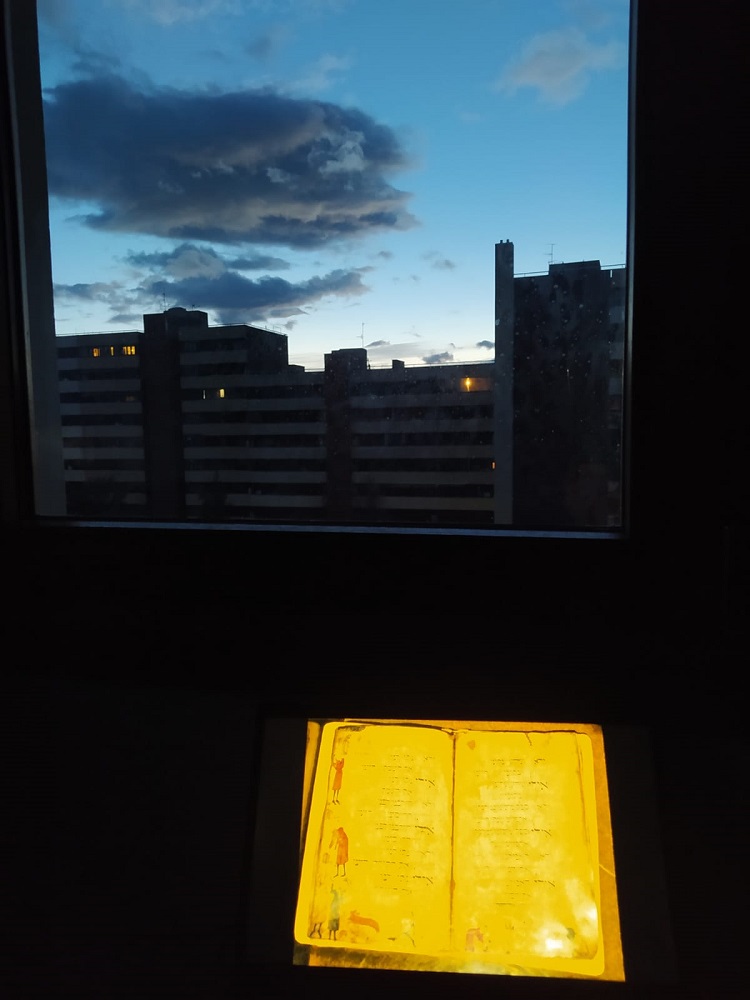
Era di giugno, il tredici, di mattina. Ho visto i camion delle attrezzature cinematografiche, erano in città da un po’ di tempo per le riprese di Martin Eden, quindi non mi è sembrata una cosa particolarmente sorprendente. Però chissà, mi sono detta, magari se mi guardo bene attorno vedo Luca Marinelli e la frase mentale finisce mentre lui sta scendendo il gradino di un bar alla mia destra. Si ferma, è in attesa. È questione di secondi, lo guardo, sto per superarlo, faccio un passo indietro, lui mi guarda, io:
«Scusa, ma ti devo abbracciare…»
Un po’ interdetto, lui:
«Oh… Grazie.»
È un abbraccio velocissimo – ma ricordo di aver sentito distintamente sotto le mani, in un rapido strofinio, il tessuto della sua giacca di scena -, così, contemporaneamente al suo grazie io dico il mio:
«Grazie mille… Ciao!»
Mi volto e proseguo dritta per la mia strada con in faccia un sorriso che faticherà ad andare via per almeno un minuto e mezzo e farà innervosire più di un passante.
Ora, dopo un fatto del genere (e cioè l’incontro con un attore famoso e, tra gli attori famosi, quello su cui hai avuto fantasie del genere «Io nella mia vita di attore famoso non avevo mai conosciuto nessuno come te, Maria; adesso posso dire di essermi finalmente innamorato: ti prego seguimi ovunque la mia vita da attore famoso mi costringa ad andare ma senza complessi perché in questa zona a-temporale della tua fantasia in cui ci siamo incontrati tu sei una donna completamente realizzata e noi ritardiamo il momento del nostro primo bacio fino a quando non avremo trovato quello perfetto») sono tante le cose che ti possono venire in mente, cose che avresti potuto fare e non hai fatto.
Nel mio caso, sono cose del tipo 1. avrei potuto stringerlo più forte, per una frazione di secondo in più o 2. avrei potuto fargli i complimenti per il suo lavoro, dirgli che non ho visto mica solo Lo chiamavano Jeeg Robot, così da fargli capire che sono capace di riconoscere un talento quando lo vedo.
Tutto sommato però, mi dico alla fine, è stato meglio così. In questo modo si ricorderà per sempre di quella ragazza che non ha tirato fuori lo smartphone, non gli ha chiesto un autografo e non gli ha detto nemmeno il suo nome: voleva solo un abbraccio.
Non potevo fare di meglio, mi sto dicendo, quando mi rendo conto di indossare gli occhiali da sole. Sono occhiali da sole ancora alla moda ma hanno le lenti consumate, il che significa che quando sono anche un po’ sporchi io ormai non ci faccio più caso perché mi sono abituata a sopportare le piccole opacità dei graffi.
Me li tolgo d’istinto e controllo le lenti. Ci sono i soliti graffi e ci sono i segni di piccole gocce d’acqua rapprese, come se in casa gli occhiali fossero stati esposti a un rubinetto aperto a pochi centimetri da loro o se ne fossero rimasti sopra la mia testa, inutili se non per trattenermi i capelli, durante un acquazzone improvviso.
E così le cose che avrei voluto fare e non ho fatto diventano 3. togliermi gli occhiali da sole; ripenso poi a quell’espressione interdetta di Luca Marinelli e non mi sembra più l’espressione di uno che resta un po’ così perché una sconosciuta sta chiedendogli un abbraccio e lui, che magari non ci è ancora tanto abituato, ne è profondamente riconoscente, ma mi sembra piuttosto l’espressione un po’ schifata di uno che vede arrivargli un faccione con gli occhiali sporchi pericolosamente vicino e davvero, lo giuro, ancora oggi gli occhiali sporchi mi sembrano l’unico motivo per cui Luca Marinelli un po’ di tempo fa non mi è corso dietro gridando «Aspetta!» per dar inizio alla nostra storia d’amore.
Del resto, la cosa, e cioè l’insistenza di Marinelli nei miei confronti, mi avrebbe creato ben più di un dilemma morale perché all’epoca stavo con Pessoa, al quale, una volta a casa, confessai tutte le emozioni che quell’incontro aveva suscitato e gli dissi, credendoci davvero, che le sensazioni liberatesi incrociando lo sguardo di Marinelli erano la cosa più vicina al tradimento che avessi mai sperimentato. Lui socchiuse le palpebre in modo da poter dare a vedere che la cosa lo stesse toccando e nello stesso tempo formulare pensieri del tipo: «QUESTA è la cosa più vicina al tradimento che lei abbia mai sperimentato? Sul serio?». Io, pensando che quelle palpebre socchiuse mi stessero chiedendo di dirgli la verità fui fiera di quella confessione, ma tenni per me quella terza cosa che avrei voluto fare e non ho fatto.
E così, quando l’altra sera sono andata a vedere Martin Eden al cinema ed è comparso Luca Marinelli, bellissimo, con indosso gli abiti di scena di quella mattina in cui ci siamo abbracciati, io gliel’avrei proprio voluto dire a Pessoa che se io e Marinelli non ci siamo messi insieme quella volta è stato solo perché avevo indosso gli occhiali da sole.
Gliel’avrei voluto dire, ma non l’ho fatto.
Quando la scuola ricomincia, a settembre, l’estate sta finendo e a volte, anche se l’autunno non è ancora iniziato, piove, e piove proprio forte, poi smette subito. Ora io ho un paio di decolleté di cuoio, alti abbastanza ma non troppo, che sono adatti a questo tipo di giornate. In più mi slanciano e sono comodi. L’altra mattina volevo mettere questo pantalone blu che stava benissimo con una blusa azzurrina molto elegante e il tutto si abbinava perfettamente con i decolleté. Il risultato, nel complesso, era sobrio, ma il pantalone aderente abbinato alle scarpe alte richiedeva comunque un certo coraggio, un certo «Mbeh?» da impostare con tutta la figura.
C’è da dire che io l’altra mattina mi sentivo molto coraggiosa perché vivo da sola in un appartamento nel cuore di Napoli già da due mesi e pur soffrendo terribilmente per amore non tralascio di assumermi le mie responsabilità andando a lavoro.
Così mi sono messa il pantalone aderente, la blusa azzurrina e le scarpe col tacco e ho camminato fino a scuola dicendo «Mbeh?» con tutta la figura. Ho detto «Mbeh?» al tabaccaio dove ho fatto l’abbonamento Anm di settembre, ho detto «Mbeh?» ai turisti tedeschi, ho detto «Mbeh?» alle bidelle e agli alunni venuti a fare gli esami di recupero e ho detto «Mbeh?» anche alle mie colleghe Pia Serbelloni-Mazzanti e Gloriana quando, incrociandole sulle scale, le ho salutate con cordialità. Pia Serbelloni-Mazzanti mi ha salutato come fa di solito, ovvero non dicendo nulla ma allungandosi sulle labbra strette un sorriso che le fa chiudere quasi completamente gli occhi. Fatto sta che non appena le supero, la sento distintamente sussurrare con sarcasmo a Gloriana «… Miss Italia».
C’è da dire una cosa: io lo sapevo di essere Miss Italia. Cioè, non decidi di metterti a fare la fatica di dire tutti quei «Mbeh?» a tutti quelli che incontri se non con la consapevolezza che la cosa riassuma una conversazione del tipo:
«Ma chi ti credi di essere? Miss Italia?»
«Eh, so’ Miss Italia, embeh? Che cazz’ vuo’?»
Per l’appunto, io volevo proprio essere Miss Italia l’altra mattina. Magari di queste del nuovo millennio che devono dimostrare di essere intelligenti e forti oltre che belle, ma che comunque stanno lì per diventare Miss Italia, e cioè per ricordare a tutte quelle che sono forti e intelligenti che loro sono anche belle. E però quando Pia Serbelloni-Mazzanti ha detto «… Miss Italia», pure se lo so che è una grandissima stronza che dice sempre un sacco di cattiverie, io ho incurvato le spalle e ho capito che neanche quella volta ero bella, intelligente e forte abbastanza.
A casa del mio amico Esenin, l’altra sera, abbiamo fatto un gioco che è partito dal nostro amico Bojack che a un certo punto ha detto: «Facciamo che ognuno di noi, a turno, racconta una storia triste e una divertente». Ha iniziato lui e ha raccontato una storia veramente triste, la storia di un ragazzo che frequentava il suo stesso liceo e che dopo un litigio col padre si è lanciato dal balcone ma è riuscito ad afferrare la ringhiera con la mano per un tempo sufficiente a permettere al padre di raggiungerlo e afferrarlo a sua volta.
Ma poi al padre il ragazzo è scappato.
A nessuno riesce a venire in mente una storia divertente e dopo un po’ il nostro amico Gončarov ha raccontato la storia di un pazzo che opponeva resistenza al personale del T.S.O. perché prima di lasciarsi portare via voleva accarezzare un cane. I paramedici hanno bussato alla porta della vicina e le hanno chiesto il favore di prestargli un attimo il cane. La vicina ha detto che andava bene, quelli lo hanno portato al pazzo, il pazzo lo ha preso in braccio, si è calmato, lo ha accarezzato con dolcezza e poi ha buttato il cane dal balcone.
Io ho raccontato la storia di Semola.
Semola ha fatto con me le elementari e io ne sono sempre stata un po’ innamorata perché era carino ma soprattutto perché era divertente – più che divertente era esilarante, comico, rocambolesco – ed era gentile con me. Una sera di qualche anno fa, mia madre mi è venuta a prendere alla stazione al ritorno dall’università e mi ha detto:
«Ti devo dire una cosa un po’ brutta…»
«Che cosa?»
«Il figlio di quello dei detersivi, quello che stava a scuola con te, come si chiamava?»
«Ma chi, Semola?»
«Prima ho letto un manifesto…»
Qualche tempo dopo, in metropolitana, ho incontrato un altro mio compagno delle elementari e abbiamo parlato della morte di Semola:
«Tu ti ricordi che lui abitava al secondo piano, no?»
«Sì»
«In pratica, lui si è buttato dal secondo piano e non è morto… E allora si è alzato ed è risalito…»
«Per buttarsi di nuovo dal secondo piano?»
«No, dal tetto.»
«Ma come si fa a sapere questa cosa, scusa?»
«C’erano delle macchie di sangue a terra in un punto diverso da dove l’hanno trovato e c’era una scia di sangue fino alle scale che portavano al terrazzo…»
Achille è uno dei ragazzi più popolari del liceo.
Da qualche tempo, mentre faccio lezione, mi accorgo che mi guarda con intensità. Ha occhi neri, molto profondi. Provo un lieve disagio, ma reggo lo sguardo con disinvoltura, come farebbe un adulto, e a volte, mentre continuo a spiegare, gli faccio addirittura segno di togliersi il cappello o mimo il gesto dello scrivere con la mano per intimargli di prendere appunti. Lui esegue, senza mai battere ciglio – è un ragazzo molto educato.
Cerco di sforzare la memoria dello scorso anno, ma mi sembra di ricordare uno sguardo più ingenuo, leggermente intontito e comunque, il più delle volte, distratto. Cosa è successo, mi chiedo. Ammettiamo pure che Achille stia fantasticando di sedurre la sua professoressa di italiano, perché un alunno dovrebbe decidere di punto in bianco di mettere a disagio un’insegnante la cui presenza e le cui lezioni l’anno prima lo avevano lasciato del tutto indifferente? La risposta, improvvisamente, arriva.
Alla fine dell’anno scorso ad Achille ho messo il debito. L’ho costretto a studiare tutta l’estate, a interrompere le sue vacanze prima del tempo e a tornare a settembre. Come se non bastasse, all’esame di riparazione gli ho fatto anche tanti complimenti, del tipo «Si vede che hai lavorato, si sente che sei molto cresciuto», complimenti che un ragazzo non registra mai come «Lo vedi che il debito è una cosa che serve, che ti può far bene?» – che è esattamente la storia che l’insegnante si vuole raccontare – ma che respinge mentalmente con un «E allora che cazzo me l’hai messo a fare il debito, bucchina?». E così adesso Achille sta recitando una parte, la parte del ragazzo profondo che ha capito che studiare è importante, ed è il senso di questa sfida ad essere intenso nei suoi occhi, la coscienza di questa provocazione a provocarmi disagio. Questa, la forma nuova che ha assunto la nostra relazione.
Decisi di ignorare la Carfagna tanto tempo fa, quando la vidi per la prima volta, al primo anno di università. Da allora sono passati più di dieci anni e lei resta la ragazza più bella che io abbia mai visto dal vivo, talmente bella da essere intollerabile.
Ignorare una persona che frequenta l’università con te e con la tua stessa frequenza è difficilissimo, ma io sono stata bravissima: l’ho ignorata quando ci incrociavamo nei corridoi dei dipartimenti, l’ho ignorata quando si sedeva vicino a me durante i corsi, l’ho ignorata quando ci incontravamo allo stesso appello d’esame, l’ho ignorata durante i seminari, ho ignorato la notizia che avesse passato il concorso per l’abilitazione all’insegnamento, ho ignorato che avesse un dottorato, ho ignorato che fosse di ruolo in un importante liceo statale cittadino.
Così, quando l’altra sera me la sono ritrovata a cena in una compagnia piccola abbastanza da rendere la decisione di ignorarla evidente a tutti, ho dovuto scegliere tra il difendere me e il difendere l’immagine che voglio le persone abbiano di me. Così ho scoperto che la Carfagna aveva letto gli stessi libri, aveva visto gli stessi film e aveva conosciuto le stesse persone che hanno riempito il mio curriculum in questi anni.
«La cosa più dolorosa», dico al mio amico Socrate «è fare i conti col fatto di aver deciso che la Carfagna era stupida solo perché bellissima.»
«La cosa più dolorosa», mi dice il mio amico Socrate «è non aver risolto i problemi che anni fa ti hanno fatto fare questa equazione anche adesso che ne hai coscienza.»
Mio fratello sta chiedendo a zio Vanja se gli piace il nome che ha scelto per sua figlia. Zio Vanja è in un letto d’ospedale, debole, magrissimo, lucido ma tremendamente in difficoltà ogni volta che prova a parlare, e tuttavia la tentazione di stimolarlo è fortissima. Zio Vanja prova a rispondere ma una smorfia di dolore gli impedisce di continuare, mia zia e mio padre accorrono, lui fa capire di voler essere tirato su con la schiena. Mi viene in mente che quando ho raccontato la storia di Semola a casa di Esenin e sono arrivata al punto in cui Semola, dopo essersi buttato dal secondo piano, si è rialzato per andare a buttarsi dal tetto, sono scoppiata a ridere. E dopo tutti sono scoppiati a ridere insieme a me.
«Che dici Marì, ce ne vogliamo andare?»
«Eh, mò ce ne andiamo…»
«Tutto sommato…», sentiamo dire a zio Vanja
«Ue zio…»
«Oh zio, dici, ti sentiamo…»
«Tutto sommato… Può anche andare bene.»
Ottobre

La mamma di Fedora, prima di partire, aveva preparato i cavolfiori al gratin e li aveva lasciati in forno. Nelle sue intenzioni le figlie avrebbero dovuto mangiarli mentre lei e il papà di Fedora erano via, fatto sta che dimentica di dire alle ragazze che dentro il forno ci sono dei cavolfiori al gratin. Lo dimentica e dimentica di averlo dimenticato. Quando i genitori di Fedora tornano a casa, la sorella di Fedora era rimasta da sola già da qualche giorno. Siccome sentono una puzza strana e sconosciuta, la mamma di Fedora pensa: «Dev’essere questo il famoso odore di canna!» – più o meno – e tutti e due, la mamma di Fedora e suo padre, avviano un consulto molto preoccupato sul da farsi.
Dopo averne parlato a lungo, decidono di non aggredire la sorella di Fedora. La convocano in sala da pranzo, la fanno sedere, e la mamma di Fedora comincia a chiederle pacatamente:
«C’è qualche problema?»
«No, mamma, perché?»
«Non devi dirci nulla?»
La sorella di Fedora si sforza di ricordare che cosa ha rotto, chi doveva telefonare, che cosa ha fatto quando è uscita, se è tornata troppo tardi e chi ha potuto riferirlo ai genitori.
«No, mamma, perché?»
«Tu lo sai che se c’è qualcosa che non va puoi venirne a parlare con noi, che ci siamo sempre, ma sai anche che non ci piace che approfitti della nostra assenza per fare cose che in questa casa non sono tollerate…»
«Lo so, mamma, ma perché?»
La cosa va avanti così per un po’, fino a quando la mamma di Fedora, spazientita, non accusa chiaramente la sorella di Fedora di farsi le canne e fino a quando questa non le risponde tipo ma-che-cazzo-vuoi-sei-pazza (e dentro di sé tira un sospiro di sollievo) e a quando non scoprono i cavolfiori dentro il forno e a quando la mamma di Fedora non rilancia con «Ma che cazzo, ma quando te ne accorgi dei cavolfiori dentro il forno, ma non lo vedi come puzzano?» e quindi alla fine discutono davvero, ma questa volta è tutto chiaro, è tutto evidente, è tutto fuori e si sentono tutte e due molto meglio.
L’altra sera sono uscita con un ragazzo di nome Turgenev ed è stato bello, è stato come quando dicono che non ti importa dove sei, come quando questo dove ti sembra irrilevante, perché tutte le cose, le persone, gli oggetti tutto attorno in qualche modo arretrano, si dissolvono, si riducono a macchie di colore e vedi solo l’altro e ascolti solo quello che dice lui e pure se non succede niente, pure se non vi baciate tu torni a casa e dici al telefono all’amico tuo Esenin «Hai presente quando non succede niente, hai presente quando non vi baciate perché tutte e due sapete che state solo rimandando quel momento?» e siccome Esenin risponde di sì, siccome dice «Ua sì» allora tu ti convinci che era una cosa vera, che era proprio così, che stavate solo rimandando, che lui dentro di sé sapeva esattamente quello che sapevi tu.
E invece da quella sera non l’ho più sentito, nel senso che ho aspettato un giorno tutto intero e lui niente e il giorno dopo allora, anche se la mia amica La Figlia del Capitano diceva «Ma Maria, ma perché, ma che fretta hai?», gli ho scritto io, gli ho chiesto se aveva letto un certo libro fondamentale e lui mi ha detto, come Esenin, «Ua sì», ma poi non mi ha detto più niente e allora io gli ho detto una cosina da nulla e lui mi ha risposto con una cosina da nulla e ogni tanto lo ricontatto e continuiamo a dirci cosine da nulla e quindi è come la mamma e la sorella di Fedora, come loro prima di scoprire i cavolfiori dentro il forno, come se uno di noi due sentisse puzza di qualcosa e l’altro non sapesse di che cazzo stiamo parlando.
E io non so chi è l’uno e chi è l’altro.
Briseide è una mia alunna molto bella, molto popolare e molto triste. Non riesce ad andare oltre la sufficienza, quando la interrogo balbetta, quando le faccio i discorsi motivazionali annuisce, abbassa gli occhi e si tira le maniche della felpa. L’altro giorno, nel brusio del cambio dell’ora, mentre sistemavo le mie cose nella borsa prima di lasciare l’aula, Briseide si è accostata alla cattedra e mi ha detto «Arrivederci prof!» e io le ho detto «Ciao Briseide, a domani!» ma lei è rimasta lì e poi mi ha detto «Come sta prof?» e io l’ho guardata e l’ho vista in attesa di una risposta e ho sentito una sensazione di dolcezza, qualcosa di vago e indefinito dentro di me ma poi ho capito di non sapere bene come gestire questo particolare tipo di situazione.
Con un sorriso pieno di riconoscenza ho risposto a Briseide:
«Bene», e non era vero, e «Grazie», ed era vero, e poi «E tu?» e lei mi ha detto:
«Tutto bene» e mi è rimasto il dubbio che non fosse vero.
Così mi è venuta in mente una cosa che mi ha raccontato una volta il mio amico Angelo Mozzillo, di un pomeriggio in cui la sua dermatologa gli aveva aperto la porta del suo studio e lui quel pomeriggio era talmente confuso che si era andato a sedere dalla parte della scrivania occupata dalla dottoressa senza rendersene conto fino a quando quella non si era messa a ridere e gli aveva detto: «Si segga pure lì. E auguri».
Col mio amico Angelo Mozzillo, nel periodo in cui ho lavorato a Milano, che è la città dove ancora abita lui, è successa una cosa che ha dell’incredibile. Io ero lì già da un paio di mesi e da un paio di mesi andavamo avanti a dirci che prima o poi avremmo dovuto vederci, che prima o poi avremmo dovuto prendere un appuntamento. Un pomeriggio di dicembre (che a Milano è come dire che faceva freddo, era umido ed era già buio) sono andata a vedere una stanza nella zona di Villapizzone, che era vicino alla scuola dove insegnavo io, perché avevo deciso che da mia zia non ci potevo più stare. Era una stanza in un appartamento nuovo e molto pulito con una coinquilina sobria e molto gentile. Mentre me ne sto andando, uscendo dall’ascensore, oltre la porta a vetri dell’ingresso del palazzo, vedo il mio amico Angelo Mozzillo e per un attimo la cosa mi sembra molto ovvia perché in fondo io lo sapevo che Angelo Mozzillo era a Milano e Milano nella mia coscienza doveva essere diventata una specie di mega appartamento dove se io stavo in soggiorno e il mio amico Angelo Mozzillo nella sala da pranzo e quindi prima o poi doveva succedere di incontrarsi nel corridoio.
Ora sarebbe davvero bello se questa storia finisse col mio trasferimento in quell’appartamento molto pulito e nuovo, quantomeno sarebbe stimolante provare a tracciare un legame simbolico tra l’incontro casuale col mio amico Angelo Mozzillo – che, ho scoperto dopo, in un appartamento dello stesso palazzo di quella stessa zona periferica guarda un po’ in quel periodo stava seguendo un workshop molto interessante – e il concetto di casa.
Ma le cose andarono diversamente.
In quello stesso pomeriggio andai a vedere un’altra stanza, al pian terreno, in un appartamento non molto distante da lì e qualcosa che stava nei colori e nell’odore dell’appartamento, pure se più vecchio e meno pulito, mi convinse che quello doveva essere il posto, e così io e mia zia ci abbracciammo a lungo, feci la valigia e raggiunsi l’appartamento un lunedì mattina in cui scoprii che degli operai stavano montando le impalcature fuori la finestra di quella mia stanza al pian terreno, che a breve sarebbero iniziati dei lavori di ristrutturazione, che quelle impalcature sarebbero rimaste lì per i successivi sei mesi, durante i quali avrei dovuto tenere la finestra sempre chiusa. Così scrissi a quella coinquilina sobria e molto gentile dell’appartamento di Villapizzone e quella non mi rispose. Allora ripresi la valigia, tornai da mia zia e ci rimasi fino alla fine del contratto.
Prima di trasferirsi a Milano, il mio amico Angelo Mozzillo abitava in un paesino che è nemico giurato del paesino in cui sono cresciuta io, rispetto al quale il paesino dove è cresciuta la mia amica La Figlia del Capitano credo abbia qualcosa da ridire. La cittadina poco distante dove è cresciuta la mia amica Fedora, piscia addosso a tutti e tre questi paesini più i paesi dove sono cresciuti il mio amico Esenin e la mia amica Tamara de Lempicka. Napoli, che è la città dove abito adesso, non ci vede proprio.
L’altro giorno, tornando da scuola, vedo passare Marco o’ foll’, che è il pazzo del mio paesino da quando ero piccola, e penso «Uh, guarda là, Marco o’ foll’» e penso pure che il fatto che il soprannome di un pazzo del mio paese sia il folle, e non o’ pazz, dice qualcosa, qualcosina lo dice, sul mio paese. Penso questo quindi, e non penso, non subito, «Che ci fa Marco ‘o foll a via Duomo?».
Quando quell’appartamento non lontano da Villapizzone mi convinse più di quello di Villapizzone che il mio posto doveva essere lì, fui molto felice. Mi ricordo che immaginai come sarebbe stata quella stanza spoglia e vuota una volta arredata da me, come sarebbe stato più semplice arrivare a scuola e quindi dormire un po’ di più e poi decidere da sola cosa mangiare e a che ora e uscire senza dare spiegazioni eccetera. Questi pensieri riempirono di senso i miei bagagli, fecero bellissimo il tram numero 12, resero entusiasmante il tragitto verso quella che pensavo sarebbe stata la mia casa. Non so se glielo direi, alla me stessa di allora, mi chiedo. Se ne è valsa la pena comunque, dico, di essere felice per un po’.
Novembre

Sono uscita per vedere uno spettacolo con la mia classe, l’appuntamento è fuori dal teatro, il Mercadante. Da due giorni piove ininterrottamente, così ho pensato a quanto sarebbe stato fastidioso camminare a piedi sotto la pioggia, a quanto la mia nuova frangetta si sarebbe inumidita e a quanto si sarebbero bagnati i miei pantaloni nuovi. E invece improvvisamente ha smesso, l’aria è diventata fresca e pulita ed io sono diventata proprio contenta, proprio felice di fare quella passeggiata a piedi insieme a pochi altri passanti increduli come me. A un certo punto, a Port’Alba, ho visto una testa con una leggera stempiatura e mi sono detta “Quella potrebbe essere la testa di Turgenev, ma faccio così, adesso non la guardo, la guardo dopo, quando sarà più vicina, così se non è lui non ci resto male e se è lui non mi creo aspettative e sollevando gli occhi all’ultimo momento posso sorprendermi e rendere il mio saluto più naturale”. Quando mi rendo conto di stare per incrociare la testa, alzo gli occhi e mi accorgo che è proprio la testa di Turgenev e non sono per niente sorpresa, quindi è una fortuna che lui non mi noti pure se ci sfioriamo quasi.
Al Mercadante abbiamo visto La Tempesta. All’uscita penso che non mi rimarrà niente, che non mi ricorderò nulla di questo spettacolo. Non lo dico ai ragazzi, chiedo solo se gli è piaciuto, dicono tutti sì. Che bravi ragazzi sono.
Per tornare a casa faccio la via più lunga. Mi piace camminare e poi l’aria è ancora più limpida e fresca. E poi magari incontro di nuovo Turgenev. Mi fermo a piazza Dante per controllarmi la frangetta nello specchio dello smartphone: si è un po’ inumidita ma non mi sta malissimo. Mi viene in mente Alcesti, una mia alunna che si è diplomata l’anno scorso e a cui la frangetta ogni tanto veniva un po’ storta e io pensavo “Ma com’è bella Alcesti, pure con la frangetta storta” e mi dicevo che forse Alcesti non si sentiva così bella e che gli altri forse ci vedono sempre un po’ più belli di come ci vediamo noi e così a piazza Dante metto via il telefono e spero che Turgenev, se lo incontro, mi veda un po’ più bella di come mi vedo e alla fine lo vedo, all’incrocio tra Port’Alba e piazza Bellini. Vedo che ha lo sguardo fisso davanti a sé e penso “Cazzo, com’è bello” e sento una fitta allo stomaco e abbasso lo sguardo e cammino con lo sguardo abbassato e le braccia incrociate cercando di apparire persa nei miei pensieri e sperando di sembrare bellissima e alla fine arrivo in quel punto in cui i paletti dissuasori ti costringono o a seguire una specie di corridoio o a scavalcare la catena e io non posso seguire il corridoio perché un gruppo di gente si è fermato davanti a me e lui è oltre la catena e quindi devo alzare gli occhi e credo, mi sembra, che lui mi stia già osservando da un po’ e faccio «Ohi» e lui fa «Ue cia’ Mari’, comme staj?», cordiale, ma pure un po’ freddo e distante, come, mi viene da dire, come uno che non vuole problemi. E poi mi attraversa. Cioè, subito dopo avermi salutata, scavalca la catena, come a dire “Guarda che io stavo per proseguire e proseguirò nonostante questo incontro” e la stessa cosa fa Raskolnikov, che sta con lui, e che è il migliore amico suo e che quasi faccio fatica a salutare e che mi sembra mi reputi un’idiota e che mi dice una frase di circostanza alla quale io rispondo con una battuta idiota e lui non fa la faccia che si fa di solito alle battute idiote, quella faccia che dice “Vabbeh, me ne vado, questa battuta era troppo idiota”, lui veramente fa la faccia di uno che se ne vuole andare perché la battuta era troppo idiota, questo Raskolnikov; Turgenev non lo so che sta facendo, non lo riesco nemmeno a guardare da quando mi ha attraversata.
«Come sei dura… Ma non ti interessa anche solo come oggetto di studio?»
Chiedo alla mia amica Melanie Klein.
«No, non mi interessa. Ho capito che ti piace questo suo modo di fare. Cerco, sapendo che non ci riuscirò, di farti desistere. Penso che ti farebbe soffrire.»
«Ma è lo stesso che con Pessoa. È lo stesso motivo per cui adesso non sono arrabbiata con lui. Se resto cosciente quel tanto che basta a non farmi manipolare, sono capace di vederlo per quello che è realmente e mi difendo come posso.»
«Non lo so. Mi dispiacerebbe se dovessi farne le spese. Sembri molto sicura di gestire il suo essere evanescente, quindi se la cosa andrà in porto mi interesserà sicuramente ma non me la sento di spingerti tra le sue braccia.»
«Ma che deve andare in porto?! Questo mi ha pisciata dai…»
«Voglio dire, adesso sai come funziona. E se la prima cosa a cui pensi è che sapresti come difenderti mi chiedo come mai sei attratta da persone che implicano un doversi organizzare per difendersi da loro.»
«Mmh… Papà?»
«… E allora se non contatti prima la rabbia o il dolore che provi, prima per tuo padre e poi per Pessoa, rischi di fare la fine di quelle donne che si mettono esclusivamente con uomini che le pestano a sangue…»
«E jaaa! Maronna mia!»
«Non dico che ti metterai con uomini che ti picchiano ma con uomini dai quali devi difenderti e dai quali hai imparato molto bene a difenderti.»
«Ma…»
«Il che è anche comodo, perché è una strada che conosci e sapresti percorrere a occhi chiusi ma che ti consente anche di impedire loro di conoscerti realmente e a fondo…»
«Ma come sto in questa foto?»
«Mmmh…»
«Forse non è il mio profilo migliore…»
«Non è il tuo profilo peggiore… Di base non stai male. Il problema è che stai un po’ troppo impostata.»
«Che faccio, la tolgo?»
«Non stai male… Puoi aspettare fino a fine settimana. Ti ho detto, il problema è solo che stai un po’ troppo impostata…»
Ho paura che i ragazzi di prima capiscano che non mi piace fare grammatica e che si rendano conto che non mi piace fare grammatica soprattutto perché ho paura che capiscano che la grammatica italiana io non la capisco. Non memorizzo le regole, mi sfugge il nesso tra le varie applicazioni, non riesco a incasellare le eccezioni. In pratica provo un senso di rifiuto nei confronti del tradizionale metodo di insegnamento della grammatica ma non ho sviluppato un mio metodo di insegnamento della stessa. Credo basti farli leggere e farli esercitare a scrivere, o meglio, con me è bastato, ma questo non dice necessariamente qualcosa sul fatto che basterà col resto del mondo. Così, quando la mia alunna Nausicaa mi chiede «Prof, ma non facciamo grammatica?», io le dico «Dopo» – che è una cosa che non ha nessun senso visto che manca un quarto d’ora al suono della campanella – e quando la mia alunna Calipso mi chiede «Prof, ma non possiamo offrirci in grammatica?», io le dico «Decido io. E comunque se ne parla venerdì!», tirando fuori un autoritarismo del tutto illogico.
Esco dalla classe con quel tipico senso di angoscia che si trascinano dietro le relazioni che si basano sui non detti. Mi piacerebbe confessare tutto, dire ai miei alunni «Guardate ragazzi, anche oggi ho finto che l’antologia ci stesse occupando troppo tempo perché non ho nessuna voglia di fare grammatica e perché ho dimenticato il libro con le soluzioni degli esercizi. Cercate di capirmi, la grammatica, di nessuna lingua, non mi è mai piaciuta, eppure vedete, sono qui davanti a voi, ce l’ho fatta, mi faccio capire. Fidatevi di me: continuando a leggere, finirete per interiorizzare per osmosi le strutture logico-sintattiche più appropriate della nostra lingua», ma non sarebbe giusto far pagare ai miei alunni le conseguenze di questo tipo di confessione. Se rivelassi loro cosa c’è alla base dei tratti reazionari che il timore della grammatica fa venire fuori, diventerei un’insegnante meno affidabile. Insomma, non posso lasciare che loro sperimentino l’ennesima insicurezza solo perché invece di mettermi a studiare seriamente la grammatica, magari su testi aggiornati, magari trovando una maniera per sentirla mia e per renderla trasferibile, ho deciso di fare dei tentativi a ogni nuova lezione.
Poi ci ragiono ancora un po’ nel corso della giornata e mi rendo conto di una cosa. Quando gli ho sistemato l’orario interno, ho stabilito, il lunedì avendo due ore, di fare sia grammatica che antologia. Questo per loro significa più compiti e più libri in cartella, motivo per cui, quando Nausicaa mi ha chiesto «Prof, ma non facciamo grammatica?» è probabile volesse dire «E allora che sfaccimma me l’hai fatto portare a fare il libro, né stronza?», che è un messaggio un po’ duro, ma comunque diverso da «Crede non ci siamo accorti che sta procrastinando apposta il tempo per la grammatica perché in realtà non ha alcuna intenzione di farla?», e quando Calipso mi ha chiesto «Prof, ma non possiamo offrirci in grammatica?» forse voleva dire semplicemente «Ho studiato i verbi transitivi e intransitivi e l’ho trovato anche molto appagante e vorrei condividere questa cosa con lei».
Insomma, io devo imparare sul serio ad ascoltare i miei alunni. E i miei alunni stanno dicendo «Prof, ma chi cazzo se ne fotte della sua foto del profilo?»
Dopo che Pessoa è passato a riprendersi le ultime cose, vedere l’armadio e i cassetti svuotati mi ha fatto un po’ male. Mi è sembrato il risveglio da uno di quei sogni dove, pure se lo so che nonna è morta da anni, a me sembra normale vederla e parlarle e pure parlarle del fatto che è morta, dirle tipo «Ue, guarda che sei morta, lo sai?» e di sentirmi rispondere «Eh, o sacce che so’ morta, me l’aviva dicere tu…» e penso che questa cosa un pochino mi prepari al risveglio e invece al risveglio ci resto di merda comunque.
Oggi, in metropolitana, intendo proprio nel treno della metropolitana, faceva un caldo tremendo. Io avevo addosso un maglione e mi sono ricordata di una cosa che ho imparato alle scuole medie e cioè che le fibre di lana impediscono di sudare. Mi ricordo che questa cosa mi colpì talmente tanto che al test di fine quadrimestre risposi falso a un’affermazione che sembrava del tutto logica, e cioè «Indossando in estate un maglione di lana si suda». Da allora sono passati più di quindici anni e non ho mai approfondito la questione, almeno non più di quanto sia bastato a farmi passare quel test. Voglio dire che non ho mai capito perché le fibre di lana impediscano di sudare. Mi ricordo la scheda di approfondimento del libro dove c’era scritta questa cosa e la foto di un tizio con un maglione di lana e subito dopo mi ricordo della professoressa che spiega la scheda di approfondimento e io che colgo solo questa cosa stupefacente, e cioè che la lana non fa sudare, e lo stupore che colpisce tutta la classe tranne quelli che sbagliarono la risposta al test e che presero un voto più basso rispetto al mio che comunque dopo più di quindici anni non lo so perché la lana non faccia sudare e che oggi sudavo lo stesso perché il mio maglione era 80% acrilico e 20% poliestere.
Sono passata davanti al mio amico Lermontov (che non mi ha vista) senza salutarlo e poi gliel’ho pure detto e lui si è dispiaciuto perché non ci riusciamo a vedere mai e perché tra poco lui avrà un bambino e sarà ancora più difficile incontrarlo per caso, così, fuori da un bar. Io, passando passando, ho pure cercato di incrociare il suo sguardo mai poi ho visto che non mi aveva vista e ho tirato dritto e l’ho fatto perché lui stava fuori da un bar dove ogni tanto va Pessoa e dove di solito ci sono gli amici di Pessoa e io temevo di incontrare Pessoa o gli amici di Pessoa. Allora ho pensato che, se per timore di incontrare Pessoa o i suoi amici passo davanti al mio amico Lermontov che non vedo quasi mai senza salutarlo, forse ho ancora un problema con Pessoa.
Adesso La Fornarina è un po’ più di una collega. Io e lei siamo persone molto diverse, con due storie molto diverse, con dei gusti diversi (anche se non molto diversi), ma abbiamo le stesse apprensioni, le stesse paure, gli stessi picchi/barra/crolli emotivi: insomma ci crediamo tutte e due, e allo stesso modo, il cazzo di centro dell’universo del collegio docenti. Ce ne siamo accorte, ce lo siamo dette, e da allora io e La Fornarina siamo diventate amiche, il che vuol dire che passiamo del tempo insieme fuori dall’orario di lavoro e che durante quel tempo tendiamo a dirci vicendevolmente alcune verità. Però una cosa io non l’ho ancora detta a La Fornarina, una cosa che riguarda la nostra collega La Duse.
Io e La Duse ci conosciamo dai tempi dell’università e da allora ci guardiamo con sospetto e questo per un modo diverso che abbiamo di intendere la materia – la stessa – che insegniamo, o almeno io sono convinta che sia per questo, che lei si ritenga migliore di me, o meglio che ritenga di avere un punto di vista superiore al mio rispetto alla materia che insegniamo, e lei penserà lo stesso di me (del resto io penso davvero di avere un punto di vista superiore al suo rispetto alla materia – la stessa – che insegniamo). Insomma, a scuola ci evitiamo il più possibile ed è un fatto che se tentassi di stabilire un contatto con La Duse, se provassi ad andare oltre il mio pregiudizio nei suoi confronti forse il mondo, almeno quello lavorativo, sarebbe un posto migliore perché avrei contribuito ad abbattere certe barriere che impediscono una sincera e profonda collaborazione tra colleghi che poi nel nostro caso è la premessa necessaria per la formazione dei cittadini del domani. Ma io e La Duse ci detestiamo, e questo non è meno un fatto.
Ora, La Duse e la mia amica La Fornarina ogni tanto si frequentano e quando hanno cominciato a frequentarsi la mia amica La Fornarina mi ha chiesto se mi stava bene e io le ho detto che mi stava bene (perché poi alla fine che cazzo le vuoi dire, “Non mi sta bene”?), però c’è una cosa che mi tormenta ed è se si può essere amici davvero di qualcuno che un qualche piacere lo deve pur ricavare dal frequentare La Duse mentre a me, quando mi capita di incontrarla in metropolitana e di doverci fare un pezzetto di strada insieme, succede che me ne torno a casa con un senso di morte nel cuore.
Ho paura che se usassi un po’ del tempo che passiamo insieme fuori dall’orario di lavoro per dire questa cosa che ho pensato alla mia amica La Fornarina, è probabile che per farla sentire meglio, per farla contenta, camufferei il giudizio nei suoi confronti («Se frequenti La Duse, un po’ sei scema») in gelosia; passerei dall’omettere un pensiero al mentirle esplicitamente e finiremo per non essere più amiche.
«Sai, credo che il pensiero ossessivo sia sparito.», dico alla mia amica Melanie Klein.
«Quale? Quello in cui eri oggetto di sbeffeggiamenti da parte sua?»
«Nnnho. Quello in cui io devo scavalcare a tutti i costi il muro di indifferenza.»
«Ah! È una cosa che credono di poter fare tutti quelli ai quali da piccoli è stato fatto credere di essere speciali… Riapparirà.»
«Non ho capito niente…»
«L’ossessione di voler abbattere a ogni costo l’indifferenza da parte degli altri è un “difetto” che hanno tutti quelli ai quali è stato detto: “Tu non sei come gli altri bambini, sei speciale”. Se poi quel bambino cresce e diventa una persona in grado di ottenere quasi sempre l’attenzione che desidera da parte di quelli che sceglie, se anche una sola persona ignora quei tentativi di ottenere l’attenzione desiderata, ne risponde l’autostima. Per questo è importante fare i conti anche con la propria mediocrità.»
«Mh.»
«Ho preso la taglia più grande, così se lo può mettere quando si fa un po’ più grande» e «Poi se non va bene potete cambiarlo e prendere qualche altra cosina che vi serve di più», con pochissime variazioni, sono le due frasi che mio fratello e sua moglie si stanno sentendo ripetere di più da quando sono diventati genitori.
Quando sabato sera sono uscita per andare a prendere Fedora erano già quasi le undici e prima di arrivare a casa sua sono rimasta ferma mezz’ora nel traffico. Così, quando lei è scesa, tutta assonnata, non sapevamo più cosa fare. «Hai voglia di dolce?», le faccio io, e lei mi propone di andare a una Bakery che ha aperto non lontano da casa sua. Quando arriviamo in questo posto, che è rosa, rosso, verde acqua, azzurro, viola, un po’ shabby chic e un po’ serie tv (americane) anni novanta, è quasi mezzanotte, ci sono pochi tavoli occupati e su tutti c’è il peluche di un unicorno, luci soffuse e il solo proprietario a prendere e a servire le ordinazioni. Questo proprietario è gay, ed è un dato che mi serve a marcarne in un modo preciso i movimenti festosi e il tono confidenziale. Io e Fedora ci prendiamo un french toast diviso in due che non riusciamo a finire perché il sapore del burro fuso a un certo punto ci disgusta. Nel ripulire il nostro tavolo, il proprietario ci chiede:
«Domani che fate ragazze?»
«Eh?», domandiamo entrambe.
«Domani che fate?»
Non capiamo lo stesso.
«Vabbeh, ho capito, nun’ facit’ nient!»
«Eeeeeh…!»
«Maronn, io sto un’altra volta qua, dalle nove a mezzanotte!»
«Ah! Siete aperti pure di mattina!», dice Fedora.
«Eh, per forza, quelli vengono gli americani a fare colazione…»
«Ah!», faccio io, «Ma posso chiederti a cosa ti sei ispirato per aprire il locale?»
«Io so’ americano, ragazze!»
«Veramente?», facciamo noi.
«Si-iì! Quella la gente – non voi eh, per carità – si pensa che io mi sono aperto la “Bakery”», fa le virgolette con le dita, «così, pcché nun tenev nient a fa! Questo era un progetto dei miei genitori…»
«Ah, e di dove siete?», faccio io.
«I miei genitori sono nati qua, i miei nonni venivano dalla Louisiana…»
Quando ci ho ripensato, il giorno dopo, sarà stato il sonno, le luci, gli unicorni, ma sul serio, mi è sembrato tutto un sogno. È stato strano, mi ha preso pure un po’ di paura e gliel’ho detto a Fedora, l’ho contattata per dirle: «Fedo’, io non sono sicura di averlo vissuto davvero» e quando lei mi ha risposto «Ahahahah», io ho aggiunto un altro significato all’amicizia.
Io ho deciso che non voglio attribuire significati a tutto ciò che riguarda Turgenev. Che l’altro giorno l’appuntamento fosse tra i lupi di Rouwang a Piazza Municipio, che la pioggia scendesse senza dare troppo fastidio e che un attimo prima di arrivare mi abbia scritto «Ti vedo», sono solo fatti.
E poi i miei amici Melanie Klein e Esenin mi hanno voluta mettere in guardia. Mi hanno detto di stare attenta perché, non molto tempo fa, Turgenev ha provato a riprendersi la sua ex-ragazza. Io penso che è carino, che è veramente dolce, quello che stanno facendo i miei amici per me e glielo rimando commuovendomi quando rispondo loro che è carino, che è dolce, quello che Turgenev ha fatto per la sua ex-ragazza.
La mia amica Melanie Klein stringe i denti, socchiude gli occhi e scuote la testa e io ho voglia di prenderle le mani e farmi capire e ci provo:
«E daii, voglio dire che in quello che ha fatto c’è del coraggio e c’è pure un po’ di romanticismo!»
«Io invece penso che se fai una cosa del genere corri il rischio di fare una grossa cazzata…»
«Ma è proprio correre il rischio di fare una cazzata, di affrontare un rifiuto, tentando il tutto per il tutto, che è coraggioso e romantico. Lo dico anche un po’ come un’auto-critica… Io non ho avuto il coraggio di andarmi a riprendere Pessoa.»
«Tu non ti sei andata a riprendere Pessoa perché probabilmente sei più lucida. Il rischio di fare una cazzata sta nel promettere una cosa che in realtà non hai nessuna intenzione di fare pur di ottenere quello di cui credi di aver bisogno in quel momento.»
A me questa frase di Melanie Klein fa venire in mente una storia di me da piccola che mia zia mi racconta ogni tanto.
Era estate, faceva caldo, io dormivo nella culla con addosso soltanto il pannolino. Quando mia zia, che badava da sola a me e doveva avere meno dell’età che ho io adesso, venne a controllare se stessi dormendo, mi trovò che ero tutta sporca di cacca e piangevo disperata.
Era successo che mi ero tolta il pannolino e avevo fatto cacca. Lì, nella culla. Poi avevo provato ad alzarmi più volte, ma oltre a imprimere a fondo la cacca nel materassino con i piedi e a sporcarmi anche le mani nel tentativo di rialzarmi non riuscivo a far altro che a rotolarmi nella cacca.
Ora, ogni volta che mia zia racconta questa storia, premette sempre che i miei avevano da poco cominciato a farmi togliere il pannolino per fare pipì, quindi io avevo in qualche modo assimilato il concetto che quando si prova l’impulso a espellere qualcosa bisogna togliersi il pannolino; quindi, se la supposizione di mia zia è corretta, vuol dire che prima di ritrovarmi a rotolare nella cacca io ero convinta che quella di togliermi il pannolino fosse la cosa giusta da fare e che quindi in quasi tutte le cose che decidiamo di fare c’è questa percentuale di rischio, quella di ritrovarci nostro malgrado a rotolare nella nostra stessa cacca.
«Questa è una città piena di perdigiorno, nessuno va mai di fretta, oh ma quando piove, i perdigiorno stanno a casa e quelli che escono sono tutti maleducati».
Ha detto così La Duse.
E poi si è fermata a fare una foto a un cumulo di immondizia.
Qualche sera fa, mi sono accorta che dal soffitto del bagno, attraverso le fessure di uno dei faretti della luce applicati alla controsoffittatura, cadevano gocce d’acqua a intervalli regolari. Dopo essermi detta che era necessario andare a vedere cosa ci fosse sul tetto, ho messo un secchio all’altezza del faretto, mi sono preparata e sono uscita.
Sono andata a un concerto nell’auditorium di un centro sociale di questa città coi miei amici Esenin e Melanie Klein. Sapevo ci fosse anche un ragazzo amico di Esenin del quale Esenin mi aveva detto che una sera, dopo avermi vista, l’aveva contattato per chiedergli di me e l’aveva fatto con un tono particolarmente entusiasta. È un ragazzo carino, gentile e simpatico, quindi io mi sono detta «Ma sì». Fatto sta che quando il concerto è finito e siamo rimasti in pochi a gironzolare vicino al palco e tra questi pochi c’era anche il ragazzo carino, gentile e simpatico ma lui, dopo avermi vista e avermi aggirata, se ne è uscito dall’auditorium ed è sparito. Io, che alla fine mi ero detta soltanto un «Ma sì», ho reagito con un «Vabbeh» e me ne sono tornata a casa, dove dal soffitto del bagno le gocce continuavano a scendere.
La mattina dopo salgo sul tetto per vedere cosa stesse facendo piovere nel mio bagno e mi rendo conto che dalla parete di una specie di rudere abbandonato e sopraelevato abusivamente, fuoriesce un tubo che perde acqua a fiotti. Allora telefono subito al mio proprietario, che mi dice di telefonare all’amministratore. Quando chiamo l’amministratore, questo mi dice che avrebbe preso contatti con un operaio. Siccome l’operaio non viene, io richiamo l’amministratore, il quale mi passa il numero dell’operaio. Così io chiamo l’operaio, il quale si fa spiegare da capo tutta la situazione e mi dice che su quel rudere lui non può intervenire perché non appartiene al condominio. Perciò io chiamo l’amministratore e gli spiego quello che mi ha detto l’operaio e l’amministratore mi dice di contattare il mio proprietario per dirgli di accordarsi con il proprietario del rudere. Il mio proprietario allora si incazza e mi dice che l’amministratore è pagato per fare l’amministratore e per scoprire lui di chi è il rudere abbandonato. Dopo ciò, io chiedo aiuto alla mia portinaia e lei mi dice che il rudere è del proprietario del condominio e che quindi spetta all’amministratore provvedere, dunque io chiamo l’amministratore e glielo dico e lui mi passa il numero del proprietario del condominio. Nel frattempo trascorre tutto il fine settimana e domenica sera una macchia d’umidità bella grande si forma pure in camera da letto: quindi io mi preparo il letto nel soggiorno. Quando il giorno dopo chiamo il proprietario del condominio lui mi dice che non crede che gli operai interverranno subito perché nei prossimi giorni è prevista pioggia e che lui vorrebbe venire a vedere com’è la situazione ma è impegnato fuori tutto il pomeriggio, ma mi promette che non sottovaluterà la questione. Intanto cominciano a piovere gocce anche in camera da letto, così io sposto il letto e metto un secchio anche lì e intanto chiamo l’amministratore e gli dico di fare pressioni sul proprietario del condominio e allora lui mi consiglia di dirgli di venire comunque a vedere che tipo di situazione si è creata tra il bagno e la camera da letto, indipendentemente dall’orario in cui sarebbe tornato a casa. Dunque io chiamo il proprietario del condominio e gli dico di venire a vedere le gocce che scendono dal soffitto, indipendentemente dall’orario in cui sarebbe tornato a casa. Quando quello viene sono le nove di sera. È un signore anziano che, mentre gli parlo, ogni tanto sgrana gli occhi e cambia luce nello sguardo e che, in sostanza, mi ripete quello che mi ha detto al telefono.
Qualche ora dopo, mentre mi preparo per passare un’altra notte in soggiorno, sento aumentare d’intensità il rumore delle gocce, lo sento farsi sempre più forte e non so che fare, davvero non so che fare, resto lì a guardare l’acqua che scende dal soffitto, rimbalza dai secchi e si allarga sul pavimento. È tardi, busso alla portinaia, lei mi dice di chiamare i vigili del fuoco e allora io li chiamo e in un attimo mi ritrovo in pigiama a casa mia con cinque uomini nella mia camera da letto che mi bucano il soffitto come se fosse una cosa qualunque e non il soffitto della mia camera da letto e io finisco per pensare a tutta una serie di ovvietà, produco simbologie – mentre favorisco i documenti ai vigili – faccio tutta una serie di rimandi alle volte in cui l’incuria, il disinteresse, il perdere il controllo sugli eventi fa crollare, rompere, cambiare l’aspetto delle cose a cui tieni, e a quel punto succede, comincio ad autocommiserarmi, non mi riesco a dire più «Vabbeh», mi dico «Ma che cazzo, ma veramente, ma che cazzo».
Attraverso il buco s’intravede quello che doveva essere una volta il soffitto della camera da letto. C’è della vernice verde scrostata e un fascio di fili della corrente che indicano il punto dove doveva esserci il lampadario.
Il proprietario del condominio, quando ha saputo che cosa era successo, mi ha assicurato che gli operai sarebbero venuti l’indomani mattina. Io non volevo prendere un giorno di festa a scuola, così ho chiamato mia madre, le ho chiesto se poteva esserci lei, qui, in casa, l’indomani mattina. Mia madre ha voluto venire subito, ché era notte, ero da sola e con un buco nel soffitto. Io ho lasciato fare. Ho preparato un altro letto nel soggiorno.
Sento i rumori di mia madre che si prepara per andare a dormire provenire dal bagno. Faccio caso alla costa di un libro su uno degli scaffali del soggiorno. Leo Spitzer, L’armonia del mondo. È un libro che Pessoa consultava spesso. Mi chiedo quante volte mi sarà capitato di stare in una stanza, sentire la presenza di Pessoa in un’altra e contemporaneamente coprire con lo sguardo una visuale che comprendeva quel libro di Spitzer.
Non riesco a dormire. Penso a come doveva essere questa casa prima dei lavori, prima che la controsoffittatura si chiudesse su quella vernice scrostata e su quel fascio di fili della corrente e prima ancora, quando su quel soffitto verde c’era un lampadario. Poi penso al mio proprietario, il mio amico Zolla, e alla vita che ha fatto qui, prima da solo, poi con la sua compagna, poi di nuovo da solo. Poi penso a Zolla che va a Barcellona e che lascia la casa ai vecchi inquilini e a loro che vivono qui per due anni prima di comprare casa. Poi penso alle cose vissute qui insieme con Pessoa. Penso a questo svolgersi del tempo e al trascorrere di tutte queste persone in qualche maniera legate alla mia, la sola di cui percepisco la presenza. Tendo la mano per cercare quella di mia madre. Dorme già.
Questo è stato il mese più piovoso degli ultimi trent’anni. Non è una mia impressione: l’ho letto sul giornale di questa mattina, lo hanno detto i climatologi. Sto andando alla stazione, cammino sotto la pioggia su via della Maddalena facendo attenzione a dove metto piedi per non perdere l’equilibrio a causa dell’asfalto bagnato e degli stivaletti alti. Mi accorgo troppo tardi che il mio ombrello e quello di un signore di mezza età stanno per andare in rotta di collisione. Lui, seccato, mi urla:
«Alza la testa!»
Tutto sommato è un buon consiglio.
Dicembre

Da piccola mi mangiavo le caccole del naso. Ci provavo proprio gusto, mi piacevano.
In seconda elementare ero seduta vicina a questo mio compagno di classe biondo con gli occhi azzurri. Era carino, ma da quando la maestra ci aveva fatti sedere vicino avevo scoperto che il suo alito mi dava la nausea: sapeva di acido. Lo sopportavo però, perché era carino ed era ben voluto e stare seduta accanto a lui era una sorta di privilegio.
Una mattina, sulla pagina bianca del quaderno, noto una caccola appallottolata. Che strano, mi dico, io non le appallottolo mai le caccole, di solito e le raccolgo direttamente con la punta della lingua dalla punta dell’indice dopo essermele staccate con l’unghia dalla narice. Dev’essersi ridotta così perché mi è caduta senza che me ne accorgessi e magari ci ho poggiato sopra il braccio. Così la prendo e me la metto in bocca. In quel momento, il mio compagno di banco, che aveva appallottolato una sua caccola, me l’aveva lanciata sul quaderno senza che io me ne rendessi conto e poi era rimasto a osservare la mia reazione, si mette a gridare:
«Che schif’! Ma faj propr’ schif’!?»
Sento l’odore del suo alito e mi viene da vomitare. Mentre il mio compagno di banco racconta quello che ha visto a tutti i miei compagni di classe, l’unica cosa che provo a dire per difendermi è: «Non avete capito, pensavo fosse la mia!».
Ogni volta che vado a buttare il vetro nelle campane del vetro e poi metto la busta di plastica dove stava il vetro nella campana di plastica che sta vicino alla campana del vetro, penso con sollievo “Ogni cosa al posto giusto”.
Quando io e Pessoa ci siamo lasciati, in piena estate, io ho cercato di riempire le mie giornate in città come ho potuto e spesso sono uscita di casa per fare lunghe passeggiate. C’è stato un pomeriggio in cui sono andata sul lungomare e mi sono seduta sul molo di Castel dell’Ovo e ho ascoltato un po’ di musica dal telefono. Tirava un vento molto piacevole e il cielo in quella parte della città si era fatto più limpido. A un certo punto, dalla riproduzione casuale di Spotify è venuta fuori Un giorno dopo l’altro e Luigi Tenco ha cantato «La nave ha già salpato il porto e dalla riva sembra un punto lontano» e io ho guardato le barche in lontananza e mi sono detta «Toh, però!» e poi subito dopo Luigi Tenco ha cantato «Qualcuno anche questa sera torna deluso a casa piano piano» e io ho creduto di aver avuto ragione ad autocommiserarmi. Poi mi sono allontanata dal molo, ho cominciato a passeggiare sul lungomare e ho fatto partire Un giorno dopo l’altro, una volta, due, e mi sono messa a girare questo videoclip nella testa di me sul lungomare in un pomeriggio d’estate con un po’ di freddo nel cuore.
Ecco, l’altro pomeriggio, io e Turgenev stavamo ridendo e io ero felice quando a un tratto mi sono ricordata che «gli occhi intorno cercano quell’avvenire che avevano sognato, ma che i sogni sono ancora sogni e l’avvenire è ormai quasi passato», e me ne sono ricordata perché, anche se il cielo era torbido, il mare era in tempesta e il vento quasi ci impediva di camminare, siamo passati proprio in quel punto della città dove avevo girato quel videoclip nella testa ed è per colpa di quel videoclip che adesso il ricordo di un pomeriggio brutto contiene una promessa di felicità e quello di un pomeriggio bello un presagio di sventura.
Ho detto al mio amico Bojack che ogni Capodanno penso a lui, ed è vero. Mi ricordo che tanto tempo fa mi inviò un racconto che aveva scritto sulla notte in cui lui e Son’ja si erano innamorati e quella notte era proprio la notte di Capodanno. Bojack e Son’ja si sono lasciati sette anni fa e tutti quanti ancora crediamo di poter attribuire a questo fatto tutto quello che non ci piace vedere in Bojack. Il modo in cui strabuzza gli occhi quando beve, il modo in cui infama le persone quando beve, il modo in cui barcolla e si appoggia alle serrande quando beve, il fatto che beve.
L’altro giorno, il mio amico Bojack mi ha detto che sono ossessionata dall’idea di dover stare in coppia perché dentro di me covo la paura di restare sola. Nemmeno mi è sembrata una rivelazione all’inizio però poi ho capito che il punto non era tanto la paura di restare sola ma l’ossessione di stare in coppia. Il mio amico Bojack, da quando si è lasciato con Son’ja, non è più ossessionato dall’idea di stare in coppia.
Io ogni Capodanno penso a lui perché quel racconto era proprio bello.
Al cenone di Capodanno stiamo tutti a casa di mia nonna morta. Mia zia ha visto una falena girare intorno al lampadario del salone e ha detto a mia madre: «Che dici Rosa’… ‘Sta palummella putess essere mammà?».
Mamma ha detto di no.
Dopo il brindisi di mezzanotte penso alle cose dell’anno appena finito che non avrei potuto sapere l’anno scorso: Pessoa che dopo l’ennesimo rimprovero su come ne sfilava via uno quando gli serviva, avrebbe bestemmiato e scaraventato per terra dal mobile l’intera pila di panni da cucina puliti, stirati e piegati da me; mamma che avrebbe detto «Guarda che io sono più intelligente di te» e che poi avrebbe aggiunto un argomento: «Tu sei mia figlia»; io che in un momento di distrazione avrei detto a una delle mie alunne: «Ma sei scema?»; io che avrei deciso di ignorare i messaggi di un mio amico perché convinta mi portasse sfortuna; Turgenev che, dopo aver definitivamente chiarito la sua posizione, prima di andarsene, mi avrebbe strofinato la spalla augurandomi «Buona giornata!»; venticinque diciottenni che mi avrebbero fatto arrabbiare e io che per dispetto non li avrei salutati e non gli avrei fatto gli auguri di Natale; il mio amico Gončarov che mi avrebbe raccontato di suo padre con l’Alzheimer che lo sveglia ogni mattina con lo strascichio dei suoi piedi e un «Che bello!»; io che avrei usato ancora un sacco di volte le vite degli altri per fare conversazione.
Il mio amico Lermontov sta camminando per una strada del Vomero e ascolta una signora dire: «Se tu sapessi, quando riesco a captare quello che dice sotto i baffi! Rimango sconvolta!».
È una storia che non conosceremo mai.
Gennaio
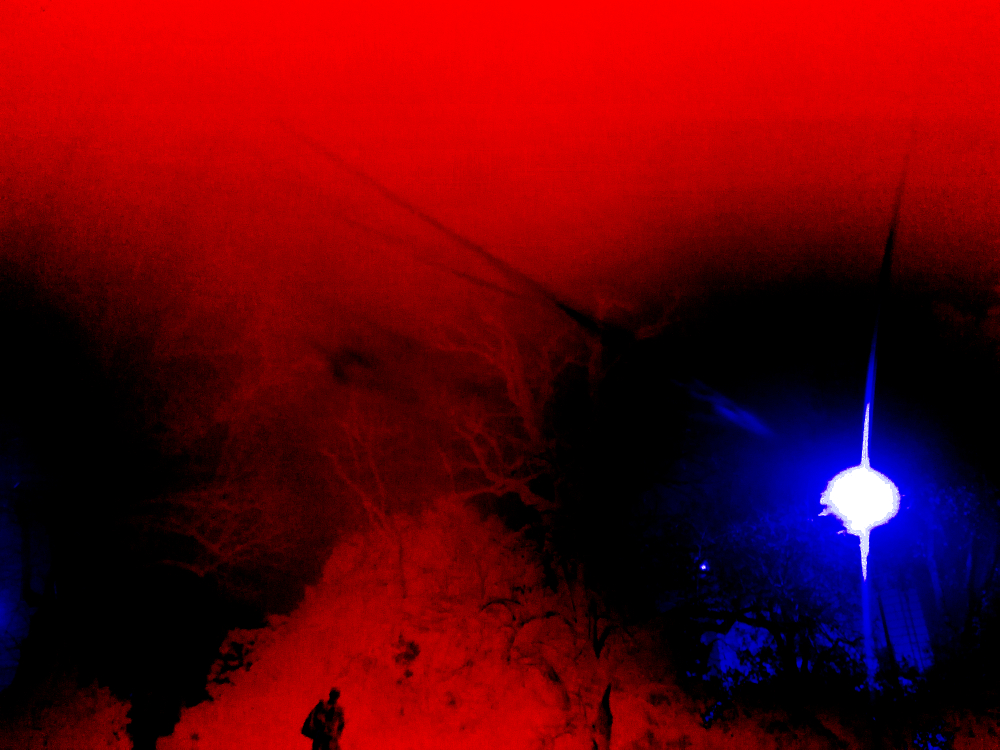
Voglio iniziare l’anno facendo qualcosa di speciale. Mi alzo presto, l’aria è fredda ma il cielo è terso e splende il sole. Scendo di casa e vado verso il mare. Arrivo fino a Castel Dell’Ovo, mi fermo e lascio che il mio sguardo si perda verso l’orizzonte. Poi sento i passi frettolosi di una donna e l’inizio di una frase che sta dicendo al telefono: «Siccome è il due gennaio, e gli insegnanti non stanno a fare un cazzo…»
Il mio collega Averroè mi dice che i pensieri negativi non possono essere evitati (dalle persone estremamente sensibili, aggiunge), ma che vanno lasciati passare, che non bisogna pensarci perché la maggior parte delle volte non è possibile sapere se quel pensiero abbia una reale ragion d’essere oppure no. Siccome io gli dico che mica è facile, lui mi spiega che ci sono alcune tecniche per lasciar passare i pensieri negativi e che una di queste consiste nel sedersi, picchiettarsi il dorso di una mano con l’indice dell’altra e concentrarsi solo su quel tocco.
«Ma bisogna concentrarsi sulla sensazione del dorso o su quella dell’indice?»
«Su tutt’e due», mi dice lui.
Ora che Gobetti è ripartito, Fedora è di nuovo triste. Glielo vorrebbe dire, vorrebbe telefonargli e dirgli le solite cose, che lei non lo sa, che con la distanza è tutto troppo complicato, che sente che le manca qualcosa. Fa questi pensieri mentre si prepara una fetta di pane e gorgonzola. Quando ha finito si lecca il coltello e un pezzetto di carta stagnola le va di traverso. Mentre sente di stare per affogare pensa “Gobetti! Devo chiamare Gobetti!”. Una volta in salvo, Fedora sa che è bello che il primo pensiero fatto in punto di morte sia stato per Gobetti. Alla fine lo chiama e gli dice solo questo.
Io, Turgenev, l’ho visto la prima volta una sera di fine settembre. Il mio amico Esenin mi aveva chiesto se volevo andare con lui a sentire due tizi della formazione originale dei Good Speed You Black Emperor e quando io gli ho detto «Mah sì, perché no», lui non ci voleva credere – ché io al mio amico Esenin su questa cosa della musica non gli do mai troppa soddisfazione – e non ci voleva credere così tanto che per essere sicuro che sarei andata con lui al concerto mi ha detto che mi avrebbe presentato Raskolnikov.
«Guardati le foto, vedi se ti piace», mi ha detto.
Io ero appena uscita dalla stazione di Cavour ed ero ferma al semaforo quando ho cercato le foto di Raskolnikov. Le ho guardate e poi è uscito il verde per i pedoni.
Quella sera, dopo il concerto, Raskolinkov si avvicina a me e al mio amico Esenin e comincia raccontare tutta una serie di fatterelli che mi fanno ridere e ogni tanto fa lampeggiare gli occhi nella mia direzione e più tardi, quando mi saluta, sento la pressione della sua barba sotto i miei zigomi ed è piacevole. Lo vedo andar via con un tizio alto, di cui guardo la schiena lunga e le spalle in cui si è stretto ed ecco, è stata questa la prima volta che ho visto Turgenev.
La seconda volta, ho visto Turgenev a casa di Raskolnikov. Quando Turgenev arriva, io mi sto alzando per andare a prendere una cosa nella borsa, perciò quando fa il giro dei saluti io sono già in piedi e quando gli capito davanti mi sembra di essere in piedi di fronte a un’ombra che nel salutarmi oscilla una volta una destra e a sinistra. Gli poggio una mano sulla spalla e gli dico «Ci siamo visti l’altra sera, non so se ti ricordi…» mentre lui già mi risponde in fretta «Sisisisì» ed ecco, è stata quella la prima volta che ho toccato e parlato a Turgenev. La volta in cui ho sentito il bisogno di giustificarmi per toccarlo e parlargli.
La settima volta che ho visto Turgenev avevo una lettera nella borsa. Sono andata con questa lettera nella borsa a una sua lettura pubblica dicendomi “Vediamo che succede”. Quello che succede è che Turgenev mi mette completamente a mio agio. Quello che succede è che traccia un cerchio per terra e dice tipo “Tu qui puoi entrare”. Ed è alla distanza in cui possono stare due persone in un cerchio tracciato intorno a una sola che parliamo tutta la sera. Gli do la lettera, mi sembra normale.
L’ottava volta in cui l’ho visto, Turgenev mi ha parlato a lungo della sua condizione.
Comprendo, trovo la maniera di tenere insieme le nostre due istanze e in qualche modo ci riesco perché mi accorgo che Turgenev mi sta guardando fisso, ha disteso la fronte e ha smesso di ascoltarmi. Fa freddo, siamo seduti fianco a fianco con le mani nelle tasche del giubbotto e restiamo così pure quando il collo di Turgenev si tende, pure quando il suo naso finisce nella giuntura tra la mascella e il mio orecchio sinistro, pure quando risale lungo la guancia e struscia il mio di naso. Le due dorsali si toccano e poi scivolano di lato mentre le nostre labbra cercano un contatto e intrappolano una ciocca di capelli che il vento mi ha buttato in faccia. Io ritardo di un attimo un gesto che dovrebbe essere subitaneo, un attimo solo, poi arretro un po’ per togliermi i capelli dalla faccia. Resto con gli occhi chiusi mentre lo faccio.
Dopo quella, io e Turgenev ci siamo visti solo un’altra volta, quando mi ha detto che in questo periodo non può, che non c’è proprio, che si deve riformare, e che quindi qualsiasi cosa fosse quella cosa che era iniziata lui voleva finisse lì e che poteva benissimo finire lì, proprio in quel momento, perché in fondo eravamo due sconosciuti.
L’altra sera, il mio amico Bojack ha portato me e le mie amiche Veronica Mars e Melanie Klein in questo posto a Banchi Nuovi. Il nostro tavolo è circolare, dalla mia posizione io non vedo la porta di ingresso. Mentre mi guarda oltre, sento Bojack dire «Sta per succedere qualcosa di straordinario». Mi giro e vedo arrivare Pessoa, mi viene incontro con un sorriso sicuro. Sono un po’ ubriaca, lo abbraccio con affetto, anche lui mi abbraccia con grande affetto, dopodiché ci sediamo ognuno con la sua compagnia e passiamo un’ora e mezza nello stesso posto, a due tavoli differenti, io dandogli le spalle. A Turgenev, vorrei mostrare questa cosa qui e dire che è una cosa che sappiamo da sempre, che l’uomo che amiamo è uno straniero.
La mia amica Fanny dice che tutta questa cosa di Turgenev si spiega col fatto che mi è capitato di incontrare una persona vagamente interessante che mi ha fatto provare delle emozioni che non provavo da tanto tempo, il che si lega a quello che dice la mia amica La Figlia del Capitano, e cioè che ho proiettato in lui una serie inimmaginabile di energie e aspettative, cosa che ha in qualche modo a che fare con quello che dice il mio amico Bojack, e cioè che a me Turgenev in realtà non piace così tanto come credo. Il tutto toccherebbe in maniera tangenziale quello che dice la mia amica Fedora, e cioè che in realtà lo sto utilizzando per non pensare. «A che cosa?», le ho chiesto io. «A Pessoa, al fatto che stai da sola», mi ha risposto lei.
Il mio amico Lermontov mi sgrida su WhatsApp perché la sera prima ho rivelato un non detto tra lui e la mia amica Veronica Mars di fronte a tutti e due e li ho messi in imbarazzo. Io gli rispondo con un non detto che ha rivelato lui e che ha ferito il nostro amico Gončarov. Lui mi dà ragione e io gli dico:
«Lo vedi, siamo tutti un po’ delle merde».
«Sì, ma questo non ci assolve tutti».
«Lo so», gli dico io.
Ma non era vero che lo sapevo.
Sto tornando a casa da scuola dopo l’Open Day. Sono stanca, è tardi, mi fanno male i piedi ma è una bella serata di gennaio e voglio essere presente a me stessa, a ogni passo, per ogni cosa che mi passa davanti. Osservo una coppia, un signore anziano e un ragazzo più giovane. Il signore anziano tiene tra l’indice e il pollice un nastro che chiude un pacchetto da pasticceria, il ragazzo accanto a lui, che avrà più o meno la mia età, tiene sotto al braccio un Super Santos. Io gli sorrido, sorrido alla coppia, a quello che esprimono. Il ragazzo sta ascoltando il signore anziano dire qualcosa, incrocia il mio sguardo e quando mi passa accanto lo sento sussurrare: «… O cess’ ‘e Napule».
Quando arrivo a casa mi siedo e comincio a picchiettarmi il dorso della mano destra con l’indice della sinistra.
Febbraio

Lo studio della mia psicologa è una stanza in un appartamento del Vomero dove ci sono altri studi di altri psicologi in altre stanze dello stesso appartamento. Dopo l’ingresso, sulla destra, prima di un lungo corridoio, c’è un divano. Di fronte al divano ci sono quattro sedie e una stufetta alogena che in estate viene sostituita da un ventilatore. La stufetta è a posto. Il ventilatore invece fa un rumore strano.
Alla mia psicologa ho parlato della sua sala d’attesa.
«… Metti che qualche volta incontro un genitore di qualche mio alunno…»
«Cosa penserebbe?»
«“Questa è pazza”?»
«Perché non dovrebbe invece sentirsi rassicurato dal fatto che l’insegnante dei loro figli stia facendo un percorso terapeutico?»
«Mh.»
Oggi pomeriggio sono arrivata un po’ in anticipo e mi sono seduta sul divano. Dopo un po’ hanno suonato al campanello. Ho sentito una porta aprirsi nel corridoio e il suono di un paio di tacchi farsi sempre più intenso prima di veder comparire una donna alta, a cui il tailleur e gli occhiali davano un’aria professionale. Ci siamo dette contemporaneamente «Buonasera» e «Salve», poi lei ha aperto la porta d’ingresso e ha detto «Buonasera…» e ha coperto ciò che seguiva il «Bu…» di qualcuno con «… Due minuti e siamo pronti», dopodiché un tizio è venuto a sedersi di fronte a me con gli occhi bassi sul cellulare. Io ho tirato fuori un libro dalla borsa e ho cominciato a leggerlo. All’improvviso questo tizio si è schiarito la gola e ha emesso un lungo sospiro. L’ho guardato di sottecchi, stava ancora fissando il cellulare.
La mia psicologa mi ha detto che la proprietaria dello studio è una signora anziana che è ancora molto legata all’appartamento del Vomero perché è stata la casa in cui è andata ad abitare da sposata, dove ha cresciuto tre figli ed è stata felice con suo marito fino alla morte di lui, quando se ne è andata a vivere a Bergamo con una sorella. Mi ha anche detto che la signora anziana ogni tanto torna a Napoli e che ogni volta chiede di visitare la sua vecchia casa. Mentre fa il giro, si ferma un po’ di tempo in tutte le stanze, si guarda intorno, chiarisce ai presenti la funzione esercitata da questo o quel particolare che la stanza racchiude, mette insieme i pezzi della sua vita lì. Per questo non vuole che l’appartamento subisca modifiche. Per questo nello studio della mia psicologa non c’è il doppio ingresso. Per questo, quando quel tizio si è schiarito la gola all’improvviso, ho pensato “Questo è pazzo”.
Quando l’aereo con cui sto andando a Parigi con la scuola si alza in volo, io guardo Napoli dal finestrino e non riesco a controllare il pensiero che da qualche parte, lì sotto, ci sia Turgenev.
Una cosa che mi piace del mio alunno Aiace è l’anello che porta al dito, che si capisce che è l’anello di suo nonno, perché è uno di quegli anelli d’oro da uomo, che si portavano cinquant’anni fa. Suo nonno poi si capisce che è morto, perché sennò non lo so se Aiace, oltre alle sue felpe, indosserebbe quell’anello.
«A te sarebbe piaciuta molto la storia d’amore dei miei genitori». A dirmelo è la mia collega Petunia Dursley. Siamo a tavola con altri due colleghi, è l’ultimo giorno del viaggio e siamo tutti esausti, ma Petunia Dursley comincia a raccontare lo stesso la storia che ciascuno di noi ha già sentito molte altre volte e almeno un’altra volta da quando siamo lì. «Mio padre era un operaio, mia madre una ricca borghese. Si sono incontrati a Piazza Dante, alla fermata del tram. Lei andava a scuola, lui al lavoro. Mio padre era un uomo bellissimo. Mio figlio è identico al nonno, gli stessi occhi, la stessa attaccatura dei capelli…». Petunia Dursley e suo figlio non si parlano da quando lei e suo marito hanno divorziato. Il padre di Petunia Dursley è morto che lei non aveva ancora vent’anni. Penso che Petunia Dursley continuerà a raccontare ad alta voce questa storia tutte le volte che potrà.
A Parigi è finita l’amicizia tra me e la mia collega La Fornarina. Qualche giorno prima che accadesse, avevo parlato al mio amico Bojack dell’insofferenza che La Fornarina mi stava procurando da un po’ di tempo e del dilemma morale provocato dalla convinzione di non poter provare insofferenza nei confronti di un’amica. Allora lui mi ha chiesto «Ma tu come decidi che una persona è tua amica?» ed era chiaramente insofferente, era come se mi avesse detto “Ma sei scema che consideri le persone amici, così?” e allora io gli ho risposto che tendo a considerare amiche tutte le persone con cui scelgo di passare del tempo libero prestando loro attenzione e parlando loro di me, ma a quel punto il mio amico Bojack aveva già smesso di ascoltarmi.
«Vabbe’, abbiamo capito… Come faccio faccio ti infastidisci sempre!»
L’ho seguita in camera sua e, anche se non ne sopportavo l’odore, siamo rimaste lì a lungo, sedute sul suo letto a parlare:
«Ascolta, La Fornari’, io in questo periodo sto male: la rabbia che ti ho scaricato addosso… Mi fa paura», le ho detto proprio così.
«Non dobbiamo essere d’accordo su tutto! Tu mi puoi dire quello che vuoi, è solo che non capisco perché tu debba avere un tono così aggressivo, mi fai pensare ci sia qualcosa sotto…»
«Non so, forse è una questione di proiezioni, vedo in te quello che mi spaventa vedere in me…»
«Per esempio?»
«Vuoi che ti faccia l’elenco?»
«Se cred…»
«Sei viziata, superficiale, borghese, dipendi dagli altri, ti ci aggrappi senza badare alle loro esigenze…»
«…»
«…»
«Che vuoi che ti dica adesso? Sono confusa. Ero felice di aver incontrato qualcuno con cui potermi aprire, mi sentivo capita…»
«Non lo so, La Fornari’, probabilmente non sono pronta per questo tipo di rapporto…»
«Adesso credo sia tu a essere molto confusa…»
«… Ho bisogno di stare da sola, devo mettere in discussione un po’ tutto, altrimenti rischio di ripetere sempre gli stessi errori con le persone che provano ad avvicinarsi a me, come ho fatto con te, come ho fatto con Pessoa…», le ho detto proprio così.
«Non so che dirti…»
«È mezzanotte, andiamo a controllare i ragazzi…»
Così abbiamo fatto il giro delle stanze e siamo partiti dalla camera attigua a quella di La Fornarina, abbiamo bussato e c’erano le nostre alunne Fedra e Medea sedute sul loro letto e io mi sono ricordata di quanto fossero sottili le pareti dell’albergo e mi sono chiesta se Fedra e Medea avessero ascoltato tutta la nostra conversazione.
Qualche giorno fa, ai colloqui con i genitori, la mamma di Medea mi ha detto che sua figlia le aveva detto: «Sai mamma? In gita ho scoperto la professoressa Natoli».
Una volta tornati a scuola, chiedo ai miei alunni di scrivere un tema. Gli chiedo di individuare un momento del viaggio d’istruzione per loro significativo e di descriverlo. Molti di loro si mantengono sul generico, mi parlano delle emozioni suscitate dalla sensazione di essere indipendenti, delle strade in cui hanno rischiato di perdersi, qualcuno anche delle impressioni prodotte dalle opere d’arte dei musei che hanno visitato. Ma è Polidoro a fare qualcosa di straordinario. Resta ai margini di qualcosa che aveva fatto e ne descrive solo la conseguenza, un terribile senso di colpa con cui è andato a coricarsi una notte, poi prosegue raccontando di come all’indomani si sia svegliato molto presto e, uscito dall’albergo, sia andato a comprare caffè e ciambelle e si sia fermato a consumare questa colazione seduto su una panchina. Ha scritto: … L’aria era fredda, attorno a me tutte persone che andavano a lavorare. Forse può sembrare stupido, ma in quel momento mi sono sentito grande, mi sono sentito un adulto che stava cominciando anche lui la sua giornata.
Quando restituisco il tema a Polidoro, non nascondo il mio entusiasmo, e siccome Polidoro nei mesi scorsi mi ha consegnato due compiti in bianco, ha fatto scena muta a un’interrogazione e al primo quadrimestre non è riuscito ad andare oltre il cinque, lo investo con i rinforzi positivi, gli dico che no, non è affatto stupido quello che racconta e infarcisco tutto il mio discorso di «Bravo Polidoro! … Vedi, Polidoro? … Ecco, Polidoro!», e dal modo, in verità piuttosto impercettibile, in cui ha storto un angolo della bocca, forse posso presumere che Polidoro ne sia stato contento.
Quando racconto alla mia psicologa quello che è successo con La Fornarina, lei mi dice «Non puoi pretendere di educare le persone». Io sulle prime non capisco e lei allora chiarisce: «A volte è come se tu ti aspettassi che le persone, una volta entrate in contatto con te, modifichino i lati caratteriali che disapprovi. Sarebbe molto più semplice, per te, rinunciare a passare del tempo con qualcuno che non stimi…».
Io e la mia collega La Donna Cannone ogni tanto andiamo a pranzo insieme e oggi le racconto del tema di Polidoro e me ne vergogno, mi vergogno di star implicitamente vantando un merito. Alla mia collega La Donna Cannone racconto anche di questa vergogna.
«Ma che ne sai che glielo hai tirato fuori tu e che invece lui non ci aveva già pensato prima di mettersi a scrivere il tema?»
«Può darsi, ma restano problematici tutti i complimenti che gli ho fatto…»
«In che senso?»
«Se non dovesse accadergli più? Se gli capitasse di non fare più niente del genere?»
«Mah, dipende da tu cosa ti aspetti esattamente…»
«… Non li voglio confondere.»
«Facendo cosa?»
«Sentendomi delusa.»
«Nascondiglielo.»
La mia amica Fedora mi racconta di quando i suoi genitori portarono lei e le sue sorelle da Spizzico, a Roma, per la prima volta.
«Le cameriere erano sui pattini!», mi dice, «La cosa ci meravigliò tanto che io e mia sorella giocammo un’estate intera a Spizzico.»
«Cioè?»
«Ci mettevamo sui pattini e facevamo finta di stare da Spizzico.»
Poi, tutt’e due nello stesso momento, ci mettiamo a cantare: «Spizzi-cò, Spizzi-cò, il fast-food dove tutto è very good!».
Alla mia amica Fedora devo chiedere qualche particolare sull’ultima gita scolastica che abbiamo fatto insieme perché non mi ricordo quasi niente. Per esempio, mi ricordo di Zack Morris. Stava seduto dietro di me sull’autobus e mi disse che somigliavo a Camila Raznovich, che avevamo in comune la fronte alta e i capelli fini, il che era vero ma era anche un modo per essere allusivo, perché all’epoca Camila Raznovich conduceva Loveline, una trasmissione in seconda serata di Mtv dove si parlava liberamente di sesso. Zack Morris continuò a prendermi in giro per tutto il viaggio e anche dopo, una volta tornati a scuola, quando mi resi conto che tutti ammiccavano alla mia esperienza in fatto di sesso. Solo una volta in cui alcuni di noi erano stati invitati a cena a casa di questa nostra professoressa e io mi sedetti comodamente sul sofà e la nostra professoressa mi disse «Sembri Paolina Bonaparte», riferendosi alla scultura che sta a Capodimonte e al modo in cui mi ero seduta, mi sembrò che Zack Morris non mi stesse sfottendo, cioè quando aggiunse «Anche per la dolcezza del viso». Zack Morris mi è tornato in mente qualche giorno fa, quando la mia collega Ornella Vanoni mi ha detto: «Senti, la frangetta non ti sta bene… Tu hai la fronte bassa!»
Tre mesi fa, io e Turgenev stiamo risalendo via Santa Brigida verso via Toledo. Muovo le spalle per far aderire meglio lo zaino alla schiena, metto le mani nel giaccone, le tiro fuori per far fare alla sciarpa due giri intorno al collo e me l’annodo alla gola, poi mi giro a guardarlo affondando il naso nel poliestere: gli ho appena detto qualcosa sul timore del giudizio. Non dice niente, inspira affondando leggermente la testa nelle spalle, con lo sguardo dritto davanti a sé e le labbra un po’ contratte.
Quando ho detto ai ragazzi di comporre quel tema, avevo dato loro questa indicazione: «Dovete tornare in quel tempo e rimanerci per un po’». Ci ripenso mentre dalla finestra alle spalle della mia psicologa intravedo il via vai di gente su una delle strade più antiche del Vomero. “Era febbraio pure quando questa era la stanza di un figlio”, penso.
Alla mia psicologa racconto che la notte scorsa ho sognato di essere nella piazza di una città italiana e di essere circondata dai lupi di Rouwang.
«Però non era Napoli, era una di queste città-focolaio del Coronavirus, su al nord…»
«Quali sono le tue sensazioni a proposito del Coronavirus?»
«Ho paura che se scatta una quarantena anche qui non potrò avere più contatti sociali, per un bel po’…»
«…»
«Ho paura che certe cose non mi ricapitino più».
«Mia nonna ha una demenza senile per cui usa il sintagma “mamma mia” come contenuto linguistico generico. Tipo “Mamma mia mamma mia” uguale “Ho sete”, ecc… L’altro giorno, per calmarla, mi sono messa a cantare Reginella, e quella si è messa a dire “mamma mia” a tempo di musica…». Ripenso a questa storia che mi aveva raccontato il mio amico Lermontov mentre fisso il puntatore che lampeggia su “Scrivi un messaggio” dopo che lui mi ha inviato su WhatsApp la prima foto di suo figlio.
Marzo

Per molto tempo, io e mio padre ci siamo visti il martedì e il venerdì e, per due volte al mese, la domenica a pranzo. La destinazione delle nostre passeggiate settimanali era spesso il tavolino di un bar. Una mattina d’estate scoprii una cosa che si chiamava affogato al caffè e che mi venne servita in un bicchiere alto e stretto, coi bordi ricurvi, mentre io ero piccola e bassa e dovetti alzare il gomito e allungare il collo per prendere le prime due cucchiaiate di gelato. Quando ripetei il movimento per la terza volta, commisi l’errore di inclinare il bicchiere verso di me. I miei pantaloncini di cotone bianco a pallini rosa ne accettarono la conseguenza. Ogni volta che torno indietro nella mia memoria con l’intento di capire quand’è che ho imparato a interpretare i silenzi delle persone, mi viene in mente la faccia di mio padre quella mattina d’estate.
Oggi c’era Turgenev seduto al tavolino di un bar. L’ho visto da lontano, in un angolo, sotto la volta di Port’Alba. In penombra, mi è sembrato un laro, un penato. Lui non mi ha vista e io ho distolto lo sguardo quando gli sono passata davanti e quindi poi non lo so se mi ha vista fingermi in una realtà in cui lui non esisteva o se non mi ha vista e io non sono esistita.
Un paio d’anni fa, ho fatto il concorso della Rai per i diplomati. Dopo la preselezione, bisognava presentarsi in quest’albergo di Roma e fare una prova di quattro step: un test psico-attitudinale; una simulazione di una dinamica di gruppo seguita da un team di psicologi; un colloquio con uno degli psicologi in questione e uno con una commissione di esperti. Durante la dinamica di gruppo dovevamo interpretare gli organizzatori di un festival musicale dedicato agli artisti emergenti e finanziato con i biglietti venduti per la band cui era dedicata la serata conclusiva, ma c’era da affrontare il fatto che la band in questione aveva dato forfait all’ultimo momento. Una ragazza bionda ruppe il silenzio proponendo di rinviare l’evento a data da destinarsi, un altro ragazzo suggerì invece un rimborso in forma di buono da spendere per gli altri eventi organizzati dalla nostra partnership.
«… Oppure», mi inserii, percependo uno degli psicologi, dal fondo della sala, sporgersi per guardarmi bene in faccia, «Oppure potremmo comunque occupare la serata ri-convocando gli artisti emergenti che sono rimasti fuori dalla selezione, dando modo a chi ha già comprato il biglietto di sfruttarlo nella stessa data, se ne ha voglia…»
«Mah, non so…», fece il ragazzo che aveva parlato prima di me, poi, voltandosi verso la ragazza bionda: «I buoni si potrebbero eventualmente spendere anche per la stessa serata conclusiva, proponendo qualche attività ludica o contattando qualche altra band disponibile, che ne dite?».
Più tardi, lo psicologo che si era sporto sulla sedia per guardarmi in faccia mi avrebbe chiesto perché avessi permesso a quel ragazzo di appropriarsi della mia idea senza ribattere. “Ma perché, veramente si è appropriato della mia idea?” pensai, poi assunsi un’aria triste e contrita, convinta che lui, uno psicologo, non avrebbe potuto non cogliere la particolarità della mia essenza.
Stamattina ho detto a uno dei miei alunni di mettere via il libro di inglese, a un’altra di non parlare durante il compito, a uno di chiedere il permesso per andare in bagno, a un’altra di mettere il cellulare in cartella, e l’ho fatto con grande solennità. Mi sono impettita, ho cercato un contatto visivo, ho pronunciato i loro nomi a inizio frase e ho interpretato la virgola che li seguiva, imprimendo al mio tono di voce i segni della mia vasta interiorità, certa che nessuno di loro avrebbe potuto mostrarsi impermeabile alla mia raffinata eleganza e alla profondità del mio animo.
Ebbene io, al concorso della Rai per i diplomati, sono arrivata trecentosessantasettesima.
Io e la mia collega La Donna Cannone ci siamo messi a parlare con il proprietario di questo posto a via Mezzocannone dove ogni tanto andiamo a pranzo. Ci ha detto che lui e una sua amica sono riusciti ad aprire il locale dopo sei anni che lo progettavano. È un posto carino.
«Ma qui, prima, cosa c’era?»
«Il kebabbaro», rispondono in coro la mia collega La Donna Cannone e il proprietario del posto carino.
Questo kebabbaro io non me lo ricordo proprio, niente, zero.
«Ma come?! È stato qui un sacco di tempo.»
«Sì, l’ha chiuso l’Asl… È venuto fuori che qui dentro ci viveva!»
«Ma veramente?»
«Sì, poi è scomparso, non l’hanno trovato più… Noi non abbiamo tolto nemmeno l’insegna, ci abbiamo messo direttamente la nostra sopra.»
Mentre ascolto questa storia a me viene in mente un tempo in cui Pessoa abitava da solo a via Tarsia, un tempo preciso in cui me ne vado via da casa sua delusa per qualcosa che non mi ricordo. Sto scendendo via Mezzocannone quando passo davanti a un ragazzo che sta mangiando un kebab. Ci guardiamo e penso “Io questo ragazzo l’ho visto in una foto”. Qualche anno dopo, con questo ragazzo, io e Pessoa saremmo andati in vacanza, insieme a sua figlia appena nata e a quella che sarebbe diventata sua moglie dopo che Pessoa li avrebbe sposati.
In funicolare incontro spesso un uomo che utilizza le persone per sentirsi rispondere dal suo cane. «Non ti preoccupare, non ti fa niente. È o ver’, né strunz’?»
«Ma certo, non si preoccupi»
«Sta tutt’eletrizzato p’cché aggia accattat e sasicce, capì? Te piacen ‘e sasicce, eh?»
«Mmmh, buone!»
E via così.
Oggi lo sento parlare al telefono:
«Agge accattat ‘e sasicce. Sai che devi fare? Prendi quei pomodori del piennolo che so’ rimasti, mettili a soffriggere a capa sotto con uno spicchio d’aglio…»
Allora mi ricordo il sogno che ho fatto stanotte. Ci siamo io e Fedora nella mia cucina che facciamo soffriggere l’aglio in tante padelle diverse; in una di queste aggiungo i pomodorini tagliati a metà, ma poi ci verso dentro una scatola di piselli al vapore e dico «No! Che cazzo ho fatto?!».
«… Io appena torno a casa ci butto le salsicce dentro, capì?», dice l’uomo guardando il cane, mentre una signora gli risponde:
«Ah, così vi fate pure il sugo per la pasta?»
«No, ci mangiamo solo le salsicce, con un po’ di pane… A nuje accussì ce piacene, è o ver?»
«Eh, così pure è saporito…», fa la signora.
Quando a Fedora racconto il sogno che ho fatto stanotte, lei mi dice: «Ma lascia stare, che secondo me con quei piselli ci usciva qualcosa di buono…»
Io e la mia amica Desideria stiamo camminando sul marciapiede del corso del paese. Senza dircelo, ci teniamo a un metro di distanza, seguiamo le disposizioni del governo. Il paese è il mio e il suo, è quello della nostra infanzia. Ci fermiamo a guardare il manifesto con Gesù, l’espressione sofferente, la bocca semiaperta, bellissimo.
«Che poi forse manco la fanno più ‘sta Via Crucis… Uh, guarda che luna!»
Desideria vive ancora nel paese, due signore vengono nella nostra direzione, la guardano fisso ma è Desideria a capire per prima di conoscerle.
«Ciao! … Eh sì, doveva essere la più luminosa da… Boh, non mi ricordo dove l’ho letto.»
Mi rendo conto di non sapere se è per il Coronavirus o per la domenica pomeriggio che le strade sono semi-deserte, mi sembra offensivo domandarglielo, come se fossi una cazzo di giornalista, come se non venissi da lì.
Mi ricordo di una volta in cui, mentre giocavamo in cortile, per darmi delle arie feci l’accento romano. «Nun se vede gnente!», dissi, riferendomi a un livido che pretendeva le avessi fatto. Desideria scoppiò a ridere «Se vede, nun se vede! Ma come cazzo ti metti a parlare?!». Ecco, penso, se adesso le chiedessi: «Dimmi, Desideria, cosa rende le strade del paese deserte: la domenica pomeriggio o il Coronavirus?», Desideria mi scoppierebbe a ridere in faccia. Perciò aspetto che Desideria faccia un commento, ma non lo fa.
Passiamo davanti alla scuola, facciamo il percorso da lì fino alla casa in cui abitavamo e ci diciamo che quel tragitto ha segnato per entrambe l’inizio della vita adulta. Però adesso, mentre cammino fianco a fianco a Desideria su quella strada, penso che lo spazio tra me e lei si è ridotto a meno di un metro e mi chiedo che cosa è passato a fare, da allora, tutto quel tempo. Però non glielo dico.
Stasera al supermercato c’era un pazzo che parlava da solo. L’ho notato al banco frigo che commentava il livello di sale di un barattolino di Jocca, poi l’ho incontrato di nuovo alle casse e mentre imbustavo l’ho sentito rivolgersi alla commessa senza rivolgersi alla commessa.
«Non è un’influenza, è una pandemia. Come la peste». E dopo un po’ ha aggiunto: «Nel Seicento». Quando la cassiera gli ha passato un etto di prosciutto e una confezione di Jocca, lui mi ha raggiunta e ha fatto per afferrare le maniche della mia busta, allora io ho allungato lentamente la mano e lui ha ritirato la sua e si è scusato con qualcun altro proprio mentre stavo per chiedergli: «Perché proprio nel Seicento?»
Tornando a casa ho pensato al pazzo vestito bene che sapeva leggere l’etichetta della Jocca e che conosceva la storia. C’è stato un prima e un dopo, mi sono detta.
Qualcuno si è accucciato al sole sul davanzale del terrazzo del palazzo di fronte casa mia, dal lato dello studio. Dalla finestra sopra la mia scrivania vedo solo la curva azzurra della schiena nella felpa e una testa bionda tra le braccia incrociate. Ogni tanto la testa si solleva e si scuote sotto la spinta di una mano passato sul viso. Starà sicuramente piangendo.
La mia amica Fedora mi ha raccontato che quando sua nonna le annunciò che i Maya avevano profetizzato la fine del mondo per il 2003, lei si fece due calcoli e ne fu contenta perché questo le avrebbe evitato di fare l’esame di terza media. Sto per assimilare il suo senso di sollievo al mio di quando ho realizzato che il Coronavirus mi avrebbe impedito di fare il concorso per diventare insegnante questa primavera, poi capisco che è il 2020 e che la mia amica Fedora ha preso la licenza media da un sacco di tempo. Guardo fuori dalla finestra e sul terrazzo non c’è più nessuno.
Nel sogno, seguo la voce della mia amica Tamara de Lempicka lungo un corridoio, poi apro una porta bianca di fronte a me e vengo investita da una nuvola di vapore. La mia amica Tamara de Lempicka esce dalla doccia del bagno della mia scuola, con i capelli e il corpo avvolti in un asciugamano. Il mio amico Esenin è seduto su una sedia da cattedra, suona la chitarra annuendo.
«Sei proprio sicura di voler restare in questa casa?», dice Tamara de Lempicka guardandosi attorno dubbiosa; Esenin annuisce.
«Dovevi vederla prima dei lavori!», le dico io, «Prima dei lavori era ancora peggio!»
Ormai sono più dieci giorni che la scuola è chiusa. Io sto correggendo i temi che i miei alunni mi hanno inviato via mail, gli svolgimenti di una traccia lunghissima sulla vulnerabilità. Molti di loro usano impropriamente “in quanto” nel tentativo di elevare il tono della loro argomentazione. In verità non lo so se tentano questo, però il ripetersi di questa locuzione mi ha ricordato la prima edizione del Grande Fratello. Mi ricordo che Salvo stava dormendo sul divano e che Francesca e Marina cominciarono a strusciarglici addosso e che allora lui si alzò e si mise a sedere e prese a passarsi una mano sulla faccia, come uno che cerca di finire di svegliarsi e insieme di cancellare quel momento che ha appena vissuto dalla sua testa. Ecco, dopo quell’episodio, durante una delle prime serate in cui andava in onda il collegamento con la casa, Daria Bignardi chiese alla moglie di Salvo come avesse vissuto la cosa e lei mostrò grande dignità, disse che aveva capito si fosse trattato di uno scherzo ma che l’aveva comunque trovato fuori luogo e nel formulare questa risposta disse un sacco di volte “in quanto” e io pensai “Ah però! Non male, lo devo usare pure io”.
Nell’altro sogno, io e la mia amica La Figlia del Capitano camminiamo lungo una delle strade del paese. Da lontano si legge l’insegna di un negozio La boutique delle carni. Quella è reale. Mi guardo le scarpe bianche che ho appena lavato. Anche questo è reale. «È vero che pensi ancora a Turgenev?», guardo le scarpe: sono sporche di cacca.
La mia collega La Donna Cannone mi ha mandato la foto di uno scontrino su WhatsApp. Sotto ci ha scritto: «Gli ultimi resti della mia vita sociale». È lo scontrino dell’ultima volta in cui siamo andate a mangiare nel posto carino a Mezzocannone. Mi viene in mente l’insegna del kebbabbaro che se ne sta sotto un insegna nuova di un locale chiuso ormai da settimane.
Su via Carbonara c’è una pasticceria, all’ingresso della pasticceria c’è un tavolino e a quel tavolino una signora anziana, piccolina, con i capelli bianchi e un camice verde da lavoro. Quando scesi di casa per andare a prendere il treno per Roma, nel salutare Pessoa tra il tepore delle coperte provai una tremenda nostalgia, poi passai fuori la pasticceria e vidi la signora anziana spazzare il marciapiede. Pensai a tutte le volte che aveva cominciato la sua giornata prima di me. Se non mi fossi chiusa la porta di casa alle spalle alle cinque del mattino, non lo avrei mai saputo. Penso a tutte le cose che accadono fuori di qui.
Aprile
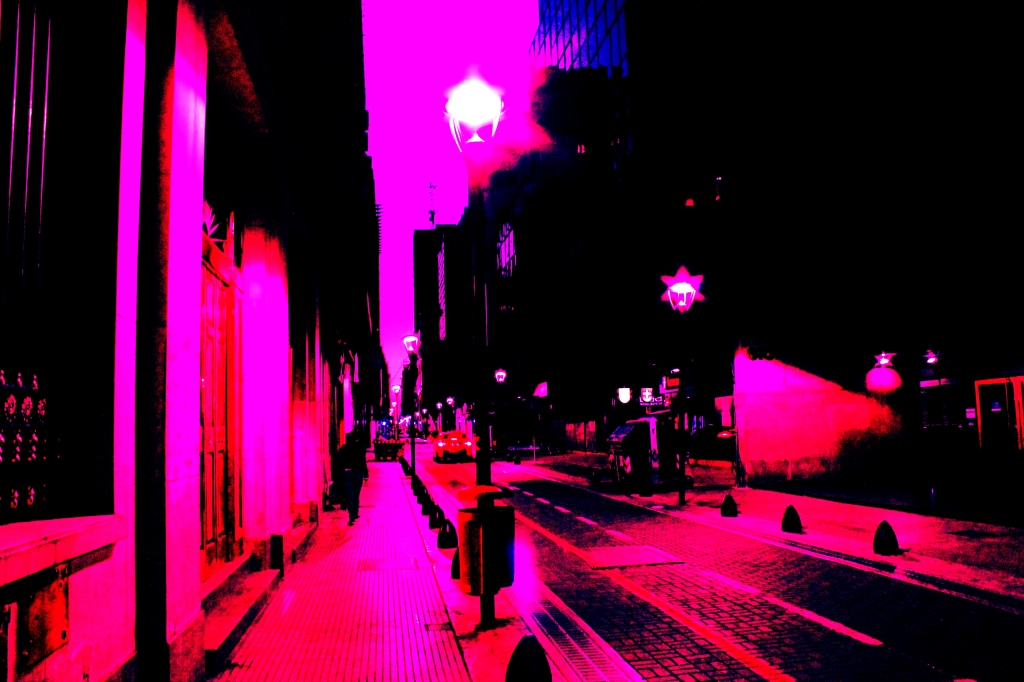
Una volta mio fratello mi disse che non si indica l’arcobaleno. Forse non era mio fratello e forse non era nemmeno l’arcobaleno. Forse era il compagno di mia madre che stavo indicando a mio padre, dietro la porta a vetri di un bar, e lui mi disse di non indicare e forse questa cosa mi è già venuta in mente una volta che ho indicato l’arcobaleno a mio fratello.
Per Turgenev, l’altro giorno, ho finito di scrivere un lungo racconto che ho trovato bellissimo e ho desiderato fargli leggere. Me lo sentivo che non era giusto però, così l’ho inviato alle mie amiche Tamara de Lempicka e Fedora e loro me l’hanno detto subito che no, non dovevo farglielo leggere, che era una cosa sbagliata. Solo che mi hanno detto pure che il racconto era molto bello e allora io c’ho pensato a lungo a questa cosa del racconto molto bello che lui non avrebbe mai letto e non mi è sembrato giusto.
Ora Turgenev è davanti alla fontana, ha le mani nella felpa e lo sguardo rivolto ai lavori della metropolitana di Municipio, alla parte del cantiere ancora in piedi. Quando vedo che ha gli occhiali da sole alle sette di sera penso al primo pomeriggio di primavera in cui chiedevo il permesso di andare giù a giocare. Mentre mi ricordo di quando mi ha raccontato la storia della fontana di piazza Municipio, spero non si volti. Poi succede e io mi chiedo cosa gli sia venuto in mente adesso, mentre mi saluta, come fa, con quel gesto tripartito di alzare il mento, piegare la testa e inarcare le sopracciglia, il gesto di uno che è stato sorpreso, ma non troppo, di uno che ti aspettava, ma si era distratto. Prima ch’io gli arrivi abbastanza vicina imposta il suo saluto con cortesia sbruffona e io mi dico che se sono già fuori gioco è solo perché non è questo il mio campo. Turgenev ha risposto a un racconto lunghissimo e all’e-mail che lo allegava con una richiesta di appuntamento secca, come uno che non ha troppo tempo da perdere e a cui interessa la chiarezza, così ora, ora che sono lì davanti a lui, non voglio allungarmi a salutarlo con i baci sulle guance perché me l’immagino che si tira indietro, addirittura me l’immagino che mi spinge via con le mani, sì, m’immagino proprio che lui prima mi faccia arrivare abbastanza vicina e poi mi metta le mani sul petto per spingermi via, mentre invece dice «Cià’» e mi bacia in fretta.
«Comm’ staje?», mi chiede mentre cominciamo a camminare fianco a fianco, in un tempo in cui sono già stata.
«Mh-bene. Tu?»
«Bonariell’…»
«Embeh, che hai fatto in questi mesi?»
«Ah-ah-ah!» mi giro a guardarlo, alla risata contraffatta dalla sigaretta che ha tra le labbra fa seguire un lieve scuotimento di testa, gli occhi socchiusi lampeggiano per un attimo nello scatto in cui si volta verso di me.
«L’hai fatto un’altra volta…»
«Cosa?»
«Mi hai mandato un’altra lettera in…»
«Un racconto…»
«Un racconto, quello che è, in cui…»
«Un racconto è, te lo dico io…»
«È comunque una cosa che mi riguarda e tu hai fatto un’altra volta tutto da sola…»
«Avresti voluto partecipare?»
«No!»
«E allora che te ne importa?»
«Ma come che me ne importa?»
«Un racconto è un racconto, si definisce per…»
«Lo so che cos’è un racconto, ma perché me l’hai mandato?»
«Perché prende spunto da cose che ho vissuto insieme a te…»
«E…?»
«E niente, mi faceva piacere che lo leggessi»
«Perché?»
«Perché ho pensato ti saresti divertito.»
«…»
«Non ti sei divertito?»
«Non avrei voluto partecipare al tuo racconto. Non avrei voluto parteciparci per niente».
Una cosa faceva la differenza tra i pomeriggi di primavera e quelli d’estate, in cortile. Di sera, in primavera, faceva freddo.
«Non voglio niente, voleva essere solo un modo per ringraziarti, te lo spiegavo nella mail…»
«Marì, io nel frattempo…»
«Lo so, lo so…»
«E non hai pensato che questa cosa avrebbe potuto crearmi dei problemi?»
«Non se ne avessi capito il senso…»
«E se non l’avessi capito? Se neanche adesso lo avessi capito?»
«Mi sarei vergognata ancora di più.»
«Ma questa sei ancora tu, di me stiamo parlando!»
«… Nel dubbio, non volevo che questa storia andasse perduta.»
Turgenev si prende una pausa in cui mi guarda e io capisco che se voglio mettere al sicuro quello che ho appena detto è questo il momento in cui me ne devo andare.
Con la mia amica Desideria, quando eravamo piccole, per darci coraggio a un certo punto ci dicevamo «Dai, scendiamo di nuovo domani».
Questa mattina Pessoa ha provato a telefonarmi e io non ho risposto. Ho visto lo schermo del telefono illuminarsi, il suo nome, la scritta che dice “Scorri per rifiutare la chiamata” e io non ho fatto niente, ho solo aspettato che smettesse. Ho aspettato dieci minuti e poi, siccome non potevo fingere di non essermene accorta, siccome non si può più fingere di non essersene accorti, gli ho scritto «Mi hai chiamato?» e poi ho corretto in «Mi hai chiamata?» ma poi ho corretto di nuovo in «Mi hai chiamato?», per farlo sembrare più spontaneo.
«Sì, ti disturbo?»
A quel punto volevo scrivere qualcosa che facesse capire che no, non mi disturbava, in generale, ma che una telefonata è comunque un impegno serio, così gli ho scritto «No, è successo qualcosa?» e poi ho corretto in «No, è successo qualcosa di grave?» ma nel frattempo lui mi ha telefonata di nuovo e io non potevo non rispondere a meno di non decidere per sempre di smetterla di avere un atteggiamento sussiegoso.
«Pronto?»
«Pronto Mary? Ciao!»
«Ue ciao, come stai?»
«Bene bene, a parte i ritmi lavorativi un po’ compromessi in questo periodo…»
«Eh, immagino…»
«Tu come stai? Come vanno le lezioni?»
«Bene bene, i ragazzi si scocciano meno di me…»
«Eh-eh-eh, il calo fisiologico d’aprile…»
«Eh già…»
Io e la mia amica La Figlia del Capitano eravamo tutte e due da sole nella mia casa del paese la sera del suo compleanno di ventidue anni, ricordo che ci mettemmo davanti al computer a guardare il profilo di Pessoa e lei mi disse di lasciar perdere perché era fidanzato.
«Senti, come sei messa in questi giorni?»
«Perché?»
«Niente, innanzitutto ti volevo restituire un paio di libri che ho preso per sbaglio e poi ti volevo chiedere se a casa c’è il mio secondo paio di occhiali, quelli con la montatura blu…»
Faccio caso a quel modo di dire a casa e mi ricordo che la mia amica La Figlia del Capitano mi disse di lasciar perdere perché era fidanzato e perché non le piacevano i suoi denti.
«Eh sì, stanno qua, te lo volevo dire…»
«Ti fa piacere se ci vediamo per fare questo baratto?»
Oggi la mia amica La Figlia del Capitano compie trent’anni.
La scorsa notte ho sognato di dover calmare il mio alunno Paride. Siamo nella camera da letto di mia madre e lui mi racconta di essere stato aggredito. Lo guardo, ha uno di quei suoi completi, quello grigio, la cravatta cremisi, i capelli pettinati all’indietro, fissati col gel. Nel sogno me l’immagino scendere i gradini dell’ingresso principale con tutti gli altri e penso che io questi ragazzi non li vedo mai uscire da scuola. Non dev’essere facile, mi dico. Così lo abbraccio e siamo riversi sul pavimento, tra il letto e l’armadio, gli tengo la testa sul mio petto. In camera di mia madre la luce è spenta ma dalla porta entra un fascio di luce e dalla cucina vengono voci e risate. C’è una cena, ci sono degli ospiti. Accarezzo la testa del mio alunno Paride. Povero. Povero Paride, penso.
«Una di queste notti ho sognato che abitavi ancora nella vecchia casa di via Tarsia e io ci passavo e pensavo “che strano passare qui sotto così, proseguire senza citofonare”…»
«Mh, interessante…»
«Perché?»
«Che cosa?»
«Perché è interessante?»
«Non lo so, tu perché me lo hai raccontato?»
«Tu perché pensi che io te l’abbia raccontato?»
«Voglio dire perché lo hai trovato abbastanza interessante da raccontarlo, non voglio dire che tu stia cercando di dirmi qualcosa…»
«Ah.»
«Se volessi dirmi qualcosa credo lo faresti e basta, no?»
«Infatti!»
«Quindi secondo te che significa quel sogno?»
Io e Pessoa abbiamo cominciato a camminare cercando un posto dove andare e poi non ci siamo più fermati. Di questo io conosco solo la mia ragione. Penso sia strano sederci al tavolino di un bar, penso soprattutto che non vorrei che qualcuno ci vedesse, mi sembra meglio questo fingere di essersi incontrati per caso finendo per fare un pezzetto di strada insieme.
«Secondo me c’entra il fatto che mi sono chiesta spesso perché tu non ti sia ancora trovato una casa…»
«Eh-eh-eh…»
«Pessoa, io alla fine non citofono però», e a quel punto mi fermo.
«Lo so.»
C’è un attrezzo da cucina, un’affettatrice a spirale per la verdura che si chiama “Super Julietti” e che la mia collega La Donna Cannone desiderava da un po’ di tempo e che suo padre le ha comprato a sorpresa. Le ha mandato una foto su WhastApp e le ha scritto «Vi ho comprato il Super Julietti», la mia collega La Donna Cannone aveva capito che quel vi intendeva «a te, a tuo fratello e a tua sorella» e ne era stata contenta, ma per un attimo era stata anche tentata di chiedere a suo padre se per caso avesse comprato un solo Super Julietti per tutti loro e non le sarebbe sembrato nemmeno così assurdo se fosse rimasta bloccata ancora per un po’ in quel tempo da cui nasceva quel dubbio, ch’era quello della sua infanzia. Fatto sta che qualche giorno fa, dopo la messa funebre per suo cugino, la mia collega La Donna Cannone, suo fratello, sua sorella, i suoi genitori e i fratelli di suo cugino stavano raggiungendo le loro macchine per tornarsene ognuno a casa loro quando il padre della mia collega La Donna Cannone ha esclamato: «Ti ho portato il Super Julietti!» e la mia collega La Donna Cannone ha pensato ai fratelli di suo cugino morto alle sue spalle e avrebbe voluto dargli un pugno in faccia, si è girata verso suo padre e l’ha guardato sperando di fargli male come se gli stesse dando un pugno in faccia.
«… Ma tu te lo immagini mai il tuo funerale?»
Mi chiede la mia amica Fedora. Oggi pomeriggio ci stiamo confessando tutte le cose che immaginiamo.
«… Io me lo immagino spesso, è elegantissimo», e scoppia a ridere nello stesso messaggio vocale.
A quel punto io devo confessarle che no, non immagino mai il mio funerale ma che immagino spesso il funerale dei miei amici e scoppio a ridere anche io e lei mi scrive una risata e poi mi manda un altro messaggio vocale per dirmi che sono una stronza e io le registro che è una cosa che faccio per emozionarmi e sentirli più vicini, che mi serve a ricordarmi di quanto bene voglio loro e allora lei mi chiede quante volte ho immaginato il suo funerale e io ammetto che sono state inferiori alle volte in cui ho immaginato il funerale del nostro amico Esenin e allora lei mi dice che sono una stronza lo stesso.
Questo pomeriggio di messaggi vocali con la mia amica Fedora è una delle cose più belle di questo mese di aprile, perché se il padre della mia collega La Donna Cannone aveva il Super Julietti nel cofano della sua auto il giorno del funerale di suo nipote era solo perché non vedeva sua figlia da quattro settimane e perché a causa del Coronavirus nessuno vede quasi più niente da più di quattro settimane ormai.
Io non ho visto la luce delle sette di sera a piazza Municipio.
Non ho visto Turgenev in piedi davanti alla fontana e non ho mai passeggiato con Pessoa alla ricerca di un posto dove andare.
Maggio

Il mio computer non riesce a più a reggere il programma che la scuola ha scelto per le video-lezioni, così sono passata a fare lezione col tablet, che supporta meglio il programma, ma che fa sparire i riquadri con i volti dei ragazzi quando condivido lo schermo. Mi è sembrato di capire che nemmeno loro vedano più me, così, mentre sto mostrando loro una slide sul primo capitolo della Coscienza di Zeno, mi metto le dita nel naso. A quel punto mi sembra di sentire un riso soffocato e mi raggelo, poi penso a quello che ho sentito dire da un barbone seduto sulla chiesa del Gesù a una sua amica durante la mia passeggiata mattutina. «Tu ti devi vestire di carattere». Così mi ricompongo e chiedo: «Allora ragazzi, chi se la sente di ripetere?».
Stasera fumo. Ho comprato un pacchetto di sigarette un po’ di tempo fa, ma poi per strada ho incontrato la mia collega Ermione che si è lamentata di quanta gente fumi nonostante il momento storico. Così sono tornata a casa e ho nascosto il pacchetto in una scatola di latta che conservo per bellezza: l’ho trovato un nascondiglio molto chic. Però stasera fumo e decido di farlo nello studio, apro la zanzariera a metà, spengo le luci e mi godo questo crepuscolo primaverile. Dei gabbiani si avventano su uno dei terrazzi di fronte, qualcuno sembra ergersi ad affrontarli, poi mi accorgo che quei gabbiani si stanno avventando apposta su quel terrazzo perché quel qualcuno sta lanciando loro del cibo. Penso alle cose che fanno le persone credendo di non essere viste e non mi sembra sia tutto sbagliato.
Sto per cucinarmi gli asparagi quando leggo la notifica di una mail di Turgenev. Dico alla mia amica La Figlia del Capitano che l’emozione provocata da questa notifica è il meglio che mi sia capitato negli ultimi mesi. Glielo dico perché so che me lo dimenticherò presto, alla prima generazione di una nuova attesa.
Spalla a spalla con Turgenev, immagino che il divano su cui siamo seduti, la sua casa e poi lui scompaiano all’improvviso. Così penso al terzo e ultimo desiderio che esprimerei di fronte al suo genio, e allora gli avvolgo le spalle e provo a vedere se si lascia andare sul mio petto. L’esercizio riesce e allora passo ad accarezzargli il braccio magro. Ed ecco tutto.
Seduti su uno dei muretti del pontile che porta a Castel dell’Ovo, io, il mio amico Bojack e la mia amica Veronica Mars ci stiamo godendo la vista del mare e delle persone. Ogni tanto penso a me e Turgenev che passeggiamo poco distanti da lì, meno di una settimana fa, e ogni tanto me lo dimentico. Anzi, quando me lo dimentico me lo segnalo dicendomi “Sei bravissima, lo vedi che stai bene? Ti stai godendo questo pomeriggio con i tuoi amici senza pensare a Turgenev” e subito ricomincio a pensare a me e Turgenev che passeggiamo poco distanti da lì, meno di una settimana fa. Succede la stessa cosa con la mascherina. Me la metto, poi me la tolgo, poi parlo con la bocca troppo vicina alla mia amica Veronica Mars e allora me la rimetto.
«Devi scrivere, certo, ma devi essere consapevole di quello che fai sul piano psicologico. Razionalizzi, non fai mai vedere quando ti emozioni.»
«Ma a chi?!»
«A tutti.»
«Va bene. Lo amo, va bene? Io a Turgenev lo amo!»
«Ma non credi che ti abbia dato troppo poco per capirlo?»
«Eh, mica c’è una misura per queste cose…»
«Vuoi sapere cosa penso? Senza che ti offendi?»
«Va bene…»
«Per quanto lui sia rimasto affascinato dalla tua scrittura, dalle mail, dai racconti… L’hai terribilmente appesantito e angosciato.»
«…»
«Devi ammettere che tu hai tentato di conquistarlo così.»
«…»
«Così hai fatto pure con Pessoa.»
«Embeh? Io sono così! Dovrei cambiare per questi uomini che poi alla fine sono attratti da me proprio per questo?»
«Esistono le sfumature! Tu usi la scrittura come un’arma di seduzione. Dovresti farti conoscere per altro secondo me.»
«L’altro fa schifo.»
«Questo è il punto, che ti fai schifo.»
«Ma lo so! Ti pare che non lo so che mi faccio schifo?»
«E allora dovresti imparare ad amarti.»
«Ma come?! Come!?»
«Ama la tua sofferenza, ama la tua intimità.»
«Cioè, ora dovrei amare il fatto che gli ho scritto per chiudere una volta e per tutte e che poi mi sono pentita e gli ho riscritto chiedendogli di vederci e che poi mi sono pentita anche di questo?»
«Sì, ama anche questo»
«Tanto faccio schifo anche a te.»
«Non è vero Maria, io penso tu abbia tante qualità, ma non quelle che credi tu. Penso tu sappia prenderti cura degli altri. Li aiuti, li sostieni. Dai molti stimoli a chi ti sta vicino. Sai fare quella zuppa con l’uovo buonissima e sei simpatica, a volte buffa…»
«Anche Turgenev ha visto il mio lato buffo…»
«Ok, ma gli hai abboffato la uallera con gli altri lati.»
Turgenev ha acconsentito a vederci ancora una volta, ma non mi ha detto quando. Stasera scrivo questa frase e penso che un giorno la rileggerò.
«… La verità è che io sono molto presa e tu no.»
«Se la vuoi fare così facile, sì.»
«Dobbiamo farla facile per forza, altrimenti continueremo a renderla complessa nel tentativo di trovare un punto d’incontro.»
«Non mi pare si possa comunque trovare un punto d’incontro.»
«No, infatti… Non mi posso raccontare le favole.»
Io e Turgenev siamo seduti sul muretto di contenimento di un’aiuola. Di fronte, il Maschio Angioino. Penso che ai piedi della storia ho parlato di verità, che davanti a un castello ho parlato di favole e mi chiedo se non sia quello il punto d’incontro. Si alza di scatto, poi resta immobile a fissare un ragno che si sta arrampicando sulla sua spalla. Faccio scivolare l’indice sul filamento di ragnatela che aveva cominciato a tessergli sulla manica della maglietta e lo libero da quell’incantesimo, poi penso che ripetere gesti come questo è tutto ciò che avrei voluto. Lascio andare Turgenev all’angolo di via Medina, gli stringo le mani nelle mani e lo ringrazio. Lui ride di quella filosofia orientale e nell’avviarsi ad attraversare la strada mi lancia qualche indizio con gli occhi e col rumore di uno schiocco sotto la mascherina per farmi indovinare un bacio. Camminando verso Piazza Borsa provo a fissare un concetto e mi viene in mente solo la bellezza.
«Ma veramente? Bellissimo!», urlo nelle orecchie del mio amico Alighiero Noschese che mi è venuto a prendere in vespa alla stazione di Aversa. Mi ha appena raccontato di suo nonno che, tornato dalla guerra, era venuto a sapere che un tizio nel frattempo aveva preso a corteggiare la sua ragazza e che lei ora faceva l’indecisa. Così il nonno del mio amico Alighiero Noschese era andato dalla sua ragazza e le aveva dato questo ultimatum «O ‘nu bellu sì che me consol’, o ‘nu bellu no che me ne vac’». È il modo del mio amico Alighiero Noschese per dirmi che ho fatto bene a lasciar andare Turgenev e il modo del mio amico Alighiero Noschese di tirarmi su e fare un giro largo per le campagne di Casaluce e permettermi di cantare Anche questo è sud a squarciagola. Quando arrivo a quel punto che dice «La troverò sopra al mare/sulle labbra la potrò baciare» realizzo che il mio amico Alighiero Noschese non mi ha detto cosa aveva risposto a suo nonno quella ragazza. Sto per chiedergli «Ma quindi quella ragazza era tua nonna?», ma poi mi aggrappo alle spalle del mio amico Alighiero Noschese e al contenuto di speranza di quel verso di Rino Gaetano.
Mi ricordo di Turgenev che mi dice «Ti piace qui? Ti piace la pianta di fichi?» e so esattamente dove devo portare la mia collega La Donna Cannone per riscrivere la mia memoria. I capelli le sono cresciuti e ha indosso i vestiti dell’estate. Sembra una ragazzina. La inchiodo su quel punto del lungomare, vicino alla pianta di fichi, e stabilisco che La Donna Cannone è una mia amica. Ho detto ai miei alunni di avere problemi di connessione per essere lì a quell’ora del mattino. So che La Donna Cannone ascolterà tutto quello che vorrò dirle ma per adesso lascio che mi racconti di quando viveva a Roma, di quella volta che sua madre venne a trovarla e voleva raggiungerla a pranzo, sul posto di lavoro, ma lei finse di essere troppo impegnata e dopo sua madre uscì per fare un giro, passò nei pressi del posto di lavoro di La Donna Cannone e la vide seduta al tavolino di un ristorante che pranzava con le sue amiche. Quando La Donna Cannone tornò a casa sua madre se n’era andata e quando La Donna Cannone andò a dormire trovò sotto il cuscino un biglietto che diceva «Ti voglio bene, la mamma».
Quando ho temuto che i miei alunni mi avessero vista mentre mi mettevo le dita nel naso, ho usato il programma della mia scuola per chiamare mio fratello, ho condiviso il mio schermo con lui e gli ho chiesto «Mi vedi?» e lui ha detto di no, poi ho interrotto la condivisione e la telecamera si è riattivata e «Adesso ti vedo», ha detto lui; così ho ri-condiviso lo schermo e gli ho chiesto di nuovo «E ora mi vedi?» e lui ha detto di no.
Oggi la mia amica Fedora compie trent’anni. Ci ricordiamo del suo compleanno di quindici anni, di quando un nostro compagno di scuola provò a scriverle sul pezzo di asfalto incorniciato dalla vista dal suo balcone “OGGI È UN GIORNO STUPENDO”, ma il padre della mia amica Fedora si affacciò all’improvviso e lo vide e lui scappò via e sull’asfalto rimase per mesi la scritta “OGGI È UN GIORNO STU”. Dico alla mia amica Fedora che quindici anni fa, tra quel giorno e il giorno in cui siamo nate ci separavano lo stesso numero di anni che adesso ci separano da quel giorno e lei mi manda affanculo. In treno per tornare al paese, penso alle diverse prospettive in cui ho visto il corpo, il volto di Turgenev e mi chiedo quali immagini lui abbia in testa di me. Mi viene in mente la storia che mi ha raccontato la mia amica La Donna Cannone. Penso alle cose che facciamo quando crediamo di non essere visti e alle cose che non facciamo quando crediamo di essere visti e non capisco quali ci procurino davvero il bene degli altri.
Giugno

Mia nipote fa una cosa che non è vera. Stasera cammino nel giardino di una pizzeria tenendole la schiena appoggiata contro il mio sterno per non respirarle vicino alla faccia. Le mostro i fiori, le dico «Questo è un gelsomino», poi, con la certezza assoluta di potermi confidare, aggiungo: «Ce l’ha anche Turgenev, sul balcone, fuori la finestra della camera da letto». Dopo la sollevo un po’ e la volto, portandomela al petto, e allora lei mi mette le manine sulle spalle e appoggia la testa nell’incavo del mio collo. Ha sette mesi e non è possibile che questa cosa che ha appena fatto sia vera.
La presidente di commissione dell’esame di Stato è una donna sulla cinquantina, molto curata, con le labbra e le tette rifatte e dei modi molto raffinati. Ostenta precisione e professionalità. Diventa subito oggetto di scherno tra i miei colleghi, ne prendono in giro le pose nelle foto che trovano su Facebook, le scarpe, alludono alla sua vita sessuale. Cerco di capire quali pensieri genera in me e capisco di volerle piacere. Mi arrabbio solo una mattina in cui interviene su Leopardi, quando dice che è pessimista e che è tutta colpa di Recanati. Più tardi, durante la pausa pranzo, ci portano un vassoio di rosticceria. La presidente non tocca niente, parla con la mia collega Petunia Dursley del suo matrimonio, le dice: «Me ne sono andata via dopo due anni e non mi vergogno a dirlo:», si volta a guardarmi «per mesi ho dormito in macchina». Ho un pezzo di panino napoletano in bocca, posso solo alzare un braccio col pugno chiuso per segnalarle il mio apprezzamento. Lei annuisce.
Quando l’ultima alunna a essere esaminata se ne va, sentiamo un’ovazione. Ci affacciamo alla finestra. Tutta la V A si è radunata fuori scuola. Ci emozioniamo, scendiamo le scale di corsa, senza mascherina, non possiamo avvicinarci, restiamo sulla soglia del portone di ingresso, li applaudiamo. La mia collega Pia Serbelloni-Mazzanti scoppia in lacrime, le strofino la schiena in segno di affetto (non penso più che sia una grandissima stronza), mi commuovo un po’ anche io, ma non so se credermi. Sono stanca, sono contenta che gli esami siano finiti e sono anche un po’ arrabbiata con la maggior parte di loro, che la mia materia l’hanno studiata poco e male.
Il giorno dopo io e La Duse facciamo tardi per mettere in ordine gli ultimi incartamenti, per chiudere il pacco da inviare al Ministero. Decidiamo di non andare alla cena di fine anno. Ci raccontiamo che è perché sono già le sette e mezza e siamo ancora a scuola, ma io so che non ci voglio andare perché ce l’ho con i miei alunni e so anche che è sbagliato ma che posso approfittare di una scusa. Lei invece non è convinta, si fa accompagnare alla funicolare, mi chiede un biglietto, lo timbra, poi torna indietro, dice che non le va di passare una serata con Petunia Dursley, che le sembra strano fare una cena dopo gli esami, che il ristorante è troppo lontano. Scendiamo a piedi verso Chiaia, ci fermiamo in un bar, ordiniamo un bicchiere di vino bianco («Ghiacciato, dev’essere ghiacciato», dice La Duse al cameriere), parliamo, lei mi chiede della scuola, di come mi sto trovando, si atteggia a maestra di vita, glielo concedo perché mi rilassa. Tornando verso il centro comincio a farle qualche domanda più personale, lei si irrigidisce, mi dà dell’invadente, la cosa presto degenera.
«La Duse, ma perché non lo decidi una volta per tutte se ti sto sul cazzo oppure no?»
«Non lo so! Non lo riesco a capire perché sei instabile. E anche io sono un’instabile.»
«No, tu sì antipatica.»
«Vuoi entrare nella cerchia delle persone che mi considerano antipatica? Sai quante ce ne sono? Prego!»
«Sei antipatica e contenta di essere antipatica!»
«Ma da cosa lo avresti capito?»
«Ma da certe risposte che dai!»
«’Azz, vogliamo parlare di te?»
«In che senso?»
«Maria, tu sai essere molto scortese. Forse non te ne accorgi, perché ti vesti da pastorella…»
«Se mi fai degli esempi precisi, forse…»
«Cara, gli analisti si pagano.»
«Ma lo vedi come ti piace dare queste risposte a effetto? Metterti in posa per il gusto di essere stronza?»
La Duse mi guarda con odio prima di dirmi:
«È meglio che non ti rispondo.»
«È meglio che me ne vado di là», e giro per via Santa Brigida.
Arrivo fino a Piazza Municipio, compro un pacchetto di sigarette al distributore vicino Palazzo San Giacomo. Non ho l’accendino, chiedo a un gruppo di signore bionde sedute vicino alla fontana di farmi accendere. Stanno festeggiando il compleanno di uno dei bambini di cui sono a guardia, ci sono piatti di plastica con resti di torta sparsi sul muretto e una composizione di palloncini tenuta ferma a terra con un piombino. Mi lascio accarezzare dalla frase che dice la signora che mi fa accendere, «Tieni bella», e prima di arrivare a sedermi sulla panchina dove Turgenev mi ha baciata la prima volta sto già pensando a lui da un pezzo, da quando ho fatto caso al fatto che sparse in giro per la piazza, in mezzo ai lupi di Ruowang, ci sono quasi solo donne e mi sono ricordata che sta giocando il Napoli.
«Gli ho raccontato il fatto di Verga, adesso ti odia, ha detto che sei superficiale».
Il mio amico Bojack si sta riferendo a Fidelio, un ragazzo che ci ha provato con me e che io ho preso in giro con Bojack perché una volta mi disse che i veristi sono scrittori senza fantasia.
«Ma perché gliel’hai raccontato?!»
«Gli ho fatto un favore.»
«Ma in che senso?»
«Nel senso che lui non si spiegava perché tu fossi passata dal chiacchierare amabilmente con lui a evitarlo e io gliel’ho detto.»
«Ma mica è Verga il problema?!»
«È uno dei problemi.»
«Bojack, non si fa così. L’hai fatto sentire umiliato, gli hai fatto immaginare che io e te abbiamo riso di lui.»
«No, ascolta, io ti ho presentato a lui come una mia cara amica, quindi lui immagina che io e te parliamo. Almeno adesso, la prossima volta che ci proverà con qualcuna, eviterà di dire stronzate.»
Il mio amico Sebastian mi mette un braccio intorno alla spalla e mi sussurra all’orecchio: «Parte dell’amicizia con Bojack è non raccontargli nessun cazzo tuo, mai». Così l’effetto prodotto da questa conversazione con Bojack è un enorme sentimento di colpa. Ne parlo con la mia amica Melanie Klein, il giorno dopo, a casa sua, mi dice:
«In effetti pare che tutti i suoi amici lo trattino come una persona che deve restare all’oscuro delle loro vite. E ciononostante riescono comunque ad essergli amici.»
Ripenso a com’è finita la serata con Bojack. L’ho abbracciato di lato, mettendogli la testa sul petto e accarezzandogli la pancia. Lui mi ha guardata e mi ha detto: «Stupida idiota».
Penso sempre a Turgenev e immagino di incontrarlo sempre, dappertutto. Così, quando l’altro giorno è successo, non ne sono stata per niente stupita. Ho aspettato fino alla scomparsa della scritta “Prelevare la carta entro 30 secondi”, poi mi sono voltata e l’ho visto allo sportello accanto al mio. Ho detto «Ciao Turgenev!» e ho atteso che si voltasse e mi riconoscesse prima di abbassare gli occhi per rimettere la carta nel portafogli e richiudere la borsa. Facciamo un tratto di strada assieme e io ho un unico pensiero fisso, mostrargli che per me va bene, che va tutto bene, che per me, lui, va tutto bene e fintanto che dura quel pezzo di strada che dobbiamo fare assieme a me sembra di star bene davvero. Poi arriva il momento in cui ci dobbiamo salutare e io mi rattristo.
Nel sogno di stanotte mi hanno affidato un neonato, molto piccolo, con i capelli molto scuri. Io sono molto emozionata, ho voglia di proteggerlo, mi sembra di cavarmela abbastanza bene, ma a un certo punto quello fa uno scatto con la schiena e io rischio di farlo cadere, allora lo afferro per un braccio per riportarmelo al petto, ma ho paura di aver tirato troppo forte e di avergli fatto male. Lo racconto alla mamma della mia amica Tamara de Lempicka, sulla spiaggia della Marinella, a Palinuro. Lei dice quello che aspettavo di sentirmi dire:
«C’è qualcosa di cui non sei sicura di poterti prendere cura? Qualcuno a cui pensi di poter fare del male o che potrebbe fare male a te?».
In cielo ci sono tanti gabbiani. Con la mia amica Tamara de Lempicka cantiamo Mammeta di Gianfranco Marziano. Lei dice di impazzire per quel punto in cui la canzone dice «In riva al mare, guardo un gabbiano/me faccio o pesce ‘mmano e penso a/mammeta» perché diventa lirico e si capisce che c’era dell’amore. Io penso a Turgenev e dico «È vero, è vero».
Quando mi sono innamorata di Pessoa era giugno. Eravamo seduti su una panchina nel parco di casa dei suoi, una panchina sulla quale una volta dissi che mi avrebbe chiesto di sposarlo, in un futuro che immaginavo otto anni fa. Poi hanno fatto dei lavori di ristrutturazione e quella panchina non esiste più già da un po’. Prima ancora di baciarlo, lo presi per le spalle e lo feci stendere sul mio petto e lui si lasciò andare e a me pareva che questa cosa contenesse tutti gli assoluti. E non era vero.
Quando Turgenev e io ci siamo salutati, l’altro giorno, gli ho avvolto le spalle con le braccia e poi, quando ho sciolto l’abbraccio, mi è sembrato lui mi attraesse di nuovo a sé per darmi un bacio sulla guancia, ma non lo so se è vero e non lo so come continua questa storia. So che prima di andare via gli ho stretto forte il braccio e che lui ha detto «Stai bene».
Luglio

L’altro giorno ho visto La donna che visse due volte, nel senso che l’ho visto davvero, su Netflix, dal mio portatile, seduta sul divano. È la storia di un poliziotto che comincia a soffrire di vertigini dopo che gli scappa un criminale durante un inseguimento sui tetti (lui sta per rimanerci, poi un collega lo salva e alla fine ci rimane questo collega), quindi è costretto a prendersi un periodo di riposo che lui passa andando a scroccare aperitivi a un’amica sua disegnatrice – che però una volta è stata la sua fidanzata e che gli dichiara amore eterno già tipo nella seconda scena – fino quando un amico suo non gli dice una cosa come “Senti, mia moglie è un po’ strana ultimamente, non è che la vorresti pedinare?” e lui dopo qualche resistenza alla fine accetta, si mette a pedinarla di nascosto ma poi questa si butta nel fiume, lui la salva, se la porta a casa sua, la spoglia, la mette a letto e, quando questa si sveglia nuda nel suo letto, lui le si deve presentare per forza e insomma due o tre scene dopo questi si giurano amore eterno e fa niente che lei è un pochino pazzerella, così pazzerella che a un certo momento del film gli dice una cosa tipo “Guarda che io devo andare proprio su quel campanile, però tu non mi seguire” lui ci pensa un po’ e poi la segue ma a quel punto è troppo tardi perché lei si è già sfracellata sul tetto del convento. Allora lui impazzisce, la sua amica disegnatrice lo va a trovare all’ospedale dei pazzi, ma niente, lui è proprio demente, anche se la sua amica disegnatrice dice tipo al medico “No, no, non è che è demente, voi non capite, è innamorato” e se ne va soffrendo tantissimo per non ricomparire mai più. Comunque quello poi mano a mano rinsavisce, esce dall’ospedale, ma niente, pensa sempre a quella che si è buttata dal campanile, così che un giorno che incontra a una tale e quale a lei la insegue fino alla sua camera d’albergo e quella fa un po’ la parte però poi alla fine accetta un invito a cena. Ora, questa qui è rossa e la pazzerella era bionda, quella era raffinata e dai modi eleganti e invece questa qui è un pochino volgarotta, allora lui, piano piano, da che quella era rossa la fa fare bionda, da che era volgarotta le compra dei bei vestiti e alla fine non c’è niente da fare, diventa proprio identica alla pazzerella del campanile, così quella dice una cosa tipo “Ma quindi, visto che mi sono fatta bionda e mi sono fatta pure le sopracciglia come lei, almeno adesso mi ami un pochino-pochino?” e lui dice tipo “Mò vediamo” e lei fa una scemenza, ma una scemenza proprio grossa, si mette una collana. Per capire perché è una scemenza bisogna aspettare tutto il tempo della scena in cui lui se la porta in macchina, di notte, e quella “Ma amore, ma dove mi stai portando?” e lui alla fine è sul campanile che la sta portando, dove le dice “Eri tu, confessa! C’hai la stessa collana sua!” e quella tra le lacrime gli dice “Sì, ero io, ero io!” e gli spiega che è una poveraccia disperata che ha fatto la parte della moglie dell’amico suo, il quale le ha dato un sacco di soldi per aiutarlo a inscenare il suicidio della vera moglie – che lui intanto aveva già ucciso perché se ne voleva andare all’estero col patrimonio della morta – ma che lei però di lui si è innamorata davvero. Però niente, il poliziotto si è proprio offeso per questa cosa e insiste a farla sporgere dal campanile e dice tipo “Hai fatto finta, eh? Hai fatto finta, eh?”, pure se quella gliel’ha detto già che ha fatto finta, e poi compare una suora che però all’inizio non si capisce bene che è una suora, pare un fantasma, e allora quella si spaventa, si butta giù e muore.
Nel 1989, che è l’anno in cui sono nata io, La donna che visse due volte venne inserito nel Registro Nazionale dei film conservati nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, che è un archivio che conserva tutti i film considerati culturalmente, storicamente o esteticamente significativi. Nello stesso anno ci misero pure Via col vento. Sono a tavola coi miei amici Bojack e Lermontov e stiamo parlando di quello che è successo con quel film sul sito della Bbc dopo le proteste legate alla morte di George Floyd e io dico «Ma quanti sono i film al mondo che dovrebbero essere accompagnati da uno spiegone?» e il mio amico Bojack dice «Adesso non me ne vengono in mente, so che se un ragazzino nero guarda quel film e si vede rappresentato come una razza inferiore è un problema» e certo, io sono d’accordo e certo, sono d’accordo pure quando il mio amico Lermontov mi dice «Così rischi di cadere in una fallacia logica. Certe cose non si possono stabilire arbitrariamente, vanno discusse ogni volta che si pone il problema».
C’è questa scena primaria dell’amicizia tra me e Fedora. Siamo in gita con la scuola e lei mi ha confessato che il suo regista preferito è Giuseppe Tornatore e io le racconto della video-cassetta di Nuovo Cinema Paradiso, e ci diciamo di quanto ci spaventava la scena dell’incendio e «Alfredo! Alfredo!» ma la colonna sonora del film, quella proprio non riesce a venirci in mente. Durante la notte, mentre siamo a letto in questo albergo di Iesolo, io a un certo punto dico «Fedo’!» e le prendo la mano e cominciò fare «T’n, t’n, t’n, t’n, t’n, t’n, t’n-ta!…» e lei continua «T’n, t’n, t! T’n, t’n, t’! T’n-t!» e tutte e due «T’n, t’n, t’n-t, t’n-t…». Oggi scopro che la colonna sonora originale di Nuovo Cinema Paradiso dura dieci minuti e che quello di quella notte con Fedora è solo uno dei tanti temi che si ricordano e chissà perché ci venne in mente proprio quello sopra tutti e perché è questa la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho scoperto che è morto Ennio Morricone.
Mia nonna parlava da sola. Certe volte mi svegliavo a casa sua e la sentivo dal piano di sopra, mentre ancora ero a letto, e credevo ci fosse qualcuno in cucina con lei e invece non c’era nessuno. Scendevo le scale, mi affacciavo in cucina e lei era seduta al tavolo, con la faccia rivolta verso la lavatrice e la tv accesa, che parlava da sola e quando io dicevo «Buongiorno nonna!» lei non si sorprendeva, era solo un po’ seccata perché perdeva il filo del ragionamento. Di solito parlava male di sua nuora, di suo figlio che erano anni che non si faceva vivo, della collera che provava per i nipoti che non le avevano fatto vedere più. S’infervorava tantissimo e qualche volta piangeva pure. C’è da dire che mia nonna è rimasta lucida fino alla fine dei suoi giorni – va bene, forse non proprio fino al giorno della fine, ma al giorno prima sì – e non ci ha mai e in nessun modo dato segni di pazzia – va bene, tranne quella volta in cui disse che era venuto a trovarla Obama, vestito di verde, e che le aveva regalato un palloncino rosso e uno blu, ma era colpa delle punture di morfina -, però ogni tanto parlava da sola, e a me da molto piccola questa cosa faceva un po’ ridere, ma poi non ci ho fatto proprio più caso. Me ne sono ricordata stamattina, mentre mi sono sorpresa a parlare da sola e mi sono accorta che lo faccio spesso, che imbastisco queste conversazioni a più voci, dove interpreto me stessa e tutti gli altri interlocutori nella situazione scenica rappresentatami in testa. E niente, sarà uno degli effetti del vivere da sola.
Fidelio mi spiega il significato dei suoi tatuaggi, uno scheletro in frack con un corno al posto delle gambe e un 13 su un braccio. Mi dice che il 13 è anche il numero della carta dei tarocchi che tutti chiamano La morte anche se in realtà è conosciuta come l’arcano senza nome.
«In realtà però ha un doppio significato: può significare la fine ma anche l’inizio di qualcosa.»
E io, anche se in realtà lo conosco il significato dell’arcano senza nome perché la mia amica Fanny me l’ha spiegato un sacco di volte, stasera ho deciso che devo riscattarmi dalla figuraccia che mi ha fatto fare il mio amico Bojack per quella storia di Verga, così dico a Fidelio: «Ah sì?»
«Sì, per questo mi sono fatto tatuare il 13, sono sempre stato attratto da questo doppio significato… E tu? Non hai mai pensato di farti un tatuaggio?»
«No Fide’, ho paura che un giorno me lo guardo e dico “Come ero scema, dieci anni fa”. Tipo…»
A quel punto Fidelio mi guarda negli occhi, nel senso che mi guarda davvero, e mi dice:
«Vabbeh, io già lo so di essere un po’ scemo».
Capisco che Fidelio mi sta lanciando un messaggio cifrato, che si sta riferendo a quella storia di Verga, e allora un po’ sono stupita da questa sua improvvisa sagacia, un po’ guardo quegli azzurri imploranti, questa pelle ambrata, questo fisico asciutto e tonico e penso “Certo che Fidelio è proprio bello” e mi sento invadere dalla tenerezza, vorrei tirarlo a me, afferrarlo per la nuca, dirgli “No che non sei scemo” e baciarlo, proprio lì, a piazza Bellini, davanti a tutti, come per rassicurarlo, come per restituirgli quella manifestazione di umiltà con il premio della mia concessione. Ma alla fine non lo faccio, inclino solo un po’ la testa e lo guardo con uno sguardo corrucciato, come a dire “Non dovresti dire così, sai?”, perché anche se Fidelio è bello, è gentile, è dolce, non è Turgenev.
Una volta a casa non riesco a prendere sonno. È una notte caldissima, mi rigiro tra le lenzuola fino alle cinque, poi spalanco le tapparelle e guardo fuori e il palazzo di fronte, le antenne sui tetti, un pezzetto di Vesuvio, i gabbiani, la luna impallidita, la stella del mattino, tutto mi sembra bellissimo e io, calata in questa solitudine immensa, mi sento in perfetto equilibrio e all’improvviso Venere mi porta questa illuminazione: “Sono Fidelio”, mi dico, “Io sono un Fidelio al quale Turgenev non è riuscito a resistere” e non me lo dico con la presunzione di aver capito con esattezza cosa Turgenev abbia provato per me, me lo dico con la certezza che gli altri possono suscitare in noi un’attrazione pari alla forza del desiderio che provano di noi e che per tutta una serie di motivi può capitare di incastrarsi per un attimo ma che, come mi ha detto una volta il mio amico Anacleto, non te la puoi prendere con nessuno se «La complicità, semplicemente, non succede». Così mi sono sentita in armonia col mondo, con questa estate, con quella Napoli che di mattina presto è così discreta, così gentile, e con questa pacificazione nel cuore mi sono addormentata.
Poi mi sono svegliata tutta sudata.
Io e la mia amica La Figlia del Capitano siamo andate alle terme di Suio, nel primo stabilimento che abbiamo trovato libero. Quando siamo arrivate vicino alle piscine, dopo che il bagnino ci ha aperto le sdraio, mi è venuto in mente che in quello stabilimento ci eravamo già state tanti anni fa, quando siamo andati in vacanza a Minturno con i nostri amici. Mi ricordo che eravamo tutti in piscina e non riuscivamo a capire dove fosse il nostro amico Micheal J. Fox quando all’improvviso sentimmo partire Un romantico a Milano e lo vedemmo tornare trionfante, dicendoci che l’aveva fatta partire lui da questa specie di juke-box, poi si buttò in piscina e cominciammo tutti a cantare e a ballare e a fare gli stupidi. Raccontato così sembra davvero un ricordo bellissimo, il ricordo di una bellissima vacanza con gli amici, il bellissimo ricordo dell’estate dei nostri diciott’anni. Ma mentre ero in acqua e cantavo e ballavo e facevo la stupida, ricordo anche di aver pensato che quella avrebbe potuto essere la scena di un film su un gruppo di ragazzi spensierati in vacanza, ma che nella realtà Dylan Dog, il mio ragazzo di allora, non mi dava le attenzioni che volevo, la mia amica La Figlia del Capitano non mi capiva, la mia amica Rory Gilmore stava troppo sulle sue, la mia amica Desideria sembrava prendermi in giro ogni volta che aprivo la bocca, il mio amico Micheal J. Fox era troppo antipatico e il mio amico Esenin troppo egoista e che quindi quello non era un film, era la realtà, e la realtà non era abbastanza e allora mi dissociai e pensai a come avrebbe potuto essere la mia vita se fosse stata simile a quella di un film. Così, mentre ero alle terme con la mia amica La Figlia del Capitano ho pensato di dare alla giornata l’importanza che meritava perché, ho pensato, un giorno, in qualche forma, avrei potuto sentirne la mancanza, per particolari che ancora non so. Magari io e La Figlia del Capitano resteremo amiche e resteremo vive e con la voglia di tornare alle terme ancora a lungo, ma un giorno potrei rimpiangere il modello del mio costume da bagno, il fatto che andassero di moda le scarpe da ginnastica o che di lì a poco sarebbe accaduto qualcosa di davvero importante nella mia vita e che quindi quella giornata alle terme avrebbe potuto rappresentare una sorta di snodo significativo. Non so se ci sono riuscita davvero per tutto il tempo, so che mentre eravamo in macchina, al ritorno, alla radio c’era questa trasmissione sulla musica da film e noi siamo state in silenzio ad ascoltare il tema principale di The Mission e anche se la strada che attraversava le campagne di Cellole in cui siamo finite perché avevamo sbagliato l’uscita autostradale due volte non era proprio la foresta pluviale e anche se quel giorno non ci eravamo esattamente adoperate per salvare degli Indios, non è stato poi così male.
A casa di Turgenev trovai un mazzo di tarocchi e così, per gioco, gli dissi «Ecco, adesso pesco una carta e facciamo che è la carta di questo momento» e cominciai a mischiare i tarocchi marsigliesi come se fossero un mazzo di carte napoletane e Turgenev disse «Che stai facendo? Non si fa così» e io non gli diedi retta perché era un gioco e alla fine sfilai dal mazzo la carta del bagatto. Io di tarocchi non ne capisco niente ma la mia amica Fanny mi aveva spiegato che il bagatto ha qualcosa ha a che fare con l’inizio, con la costruzione di qualcosa, e quindi me la risi e Turgenev inarcò le sopracciglia e fece uno scatto con la testa, come a dire “‘Azz”. Seppi che era fondamentale non dire nulla, non commentare, così mi misi a pescare altre carte e a dire che cosa mi aveva detto a proposito la mia amica Fanny e Turgenev mi chiese «Ma chi è ‘sta Fanny?» e ci mettemmo a parlare di altre cose. Ogni tanto però ci ripenso, al bagatto. Ripenso a me e Turgenev sul divano di casa sua con le carte dei tarocchi sparse sul tavolino che parliamo dei rapporti di amicizia e a come quel momento mi sembrava iniziasse a contenere tutta una serie di momenti futuri che nei ricordi sarebbe stato impossibile scindere gli uni dagli altri perché divenuti parte di un periodo più o meno ampio che avrebbe avuto a che fare con l’inizio della nostra conoscenza. Poi ripenso a come, all’improvviso, non è stato più così e sento questo pugno nello stomaco, questa sofferenza che mi sembra impossibile da tollerare.
Poi ieri, per caso, ho preso uno dei miei diari e ho letto una cosa che avevo scritto una mattina di maggio di circa sette anni fa: «Nessuno conoscerà mai la misura della sofferenza che ho provato stamattina». Era successo che qualche giorno prima io e Pessoa ci eravamo lasciati e il giorno in cui avevo scritto questa frase ero stata malissimo, mi ero disperata, mi ero buttata sul pavimento in lacrime, avevo creduto di morire. Invece non era successo, ero andata avanti per qualche giorno, triste, inappetente, incapace di credere che qualcosa in questo mondo potesse ancora avere un senso, ma abbastanza lucida da sopravvivere fino al giorno in cui io e Pessoa non finimmo per parlare, chiarirci e tornare insieme. Oggi credo alla misura della sofferenza di quella mattina di maggio, ci credo perché l’ho conosciuta, ma so anche che non era vero che sarei morta, che forse non sarei morta nemmeno se io e Pessoa non ci fossimo parlati, non ci fossimo chiariti e non fossimo tornati insieme. Se questo non serve a rendere più sopportabile la sofferenza per Turgenev è perché sul divano di casa sua sono stata felice, di quella felicità di cui si ha coscienza nel momento in cui la si sta vivendo, e il pensiero che un giorno potrei dimenticarmi di questa felicità, il pensiero che per smettere di soffrire dovrei dimenticarmi proprio di questa felicità, questa idea, non quella che le cose finiscano, mi fa molta paura.
Guardo le foto della prima vacanza che io e Pessoa abbiamo fatto insieme. Ce n’è una che ricordo di aver preferito tra tutte e alla quale non pensavo da un sacco di tempo. Gran parte della foto è occupata dal profilo di Pessoa con gli occhi chiusi, col naso poggiato sulle nostre mani intrecciate che appaiono al centro, sul fondo. Pessoa è riverso sulle mie gambe, sulla parte sinistra si intravede un pezzo della mia coscia e l’asciugamano gialla e blu su cui è poggiata. La luce è quella della spiaggia alle sei del pomeriggio. Cerco di immaginarmi nel momento in cui, con l’unica mano libera, ho scattato la foto. Le spalle curve, la canottiera rossa che le fotografie successive suggeriscono stessi indossando. A guardarla adesso, Pessoa mi sembra ancora bellissimo e non faccio fatica a immaginare quello come uno dei momenti più romantici della nostra vacanza, ma l’emozione che lo accompagnava e anche quella con cui ho guardato questa fotografia per molto tempo, non riesco a recuperarla. Noto tre piccoli lividi sulla mia coscia, i segni inconfondibili della pressione di tre polpastrelli. Mi stupisce la somiglianza con quelli che mi lasciò Turgenev nello stringermi in quello stesso punto.
La mia amica Tamara de Lempicka mi ha fatto promettere di non farmi piacere il suo amico Limonov. Mi ha detto:
«È adorabile come amico ma, te lo giuro su quello che vuoi, con le donne è una merda, non puoi capire in che modo.»
«Raccontami!», le dico io.
«Sul serio?»
«Sì, dimmi tipo “Guarda, quello con te sarebbe capace di…”»
«È sicuro che, se scopate, quello dopo due ore sta al bar con gli amici a dire com’erano culo e tette, appese, sode, se sei pippa a letto, se ti curi…»
«Hai ragione, come amico è uno spasso.»
Così ho cercato di resistere agli attacchi di Limonov per tutta la sera fino a quando, mentre parlavamo, un po’ distanti dagli altri, del paesino calabro di cui è originaria parte della sua famiglia e della sua adolescenza a Torino, non gli ho chiesto come si erano conosciuti i suoi genitori.
«Mia madre venne su per andare a insegnare…»
«Sì ma poi dove, come si conobbero?»
«Non lo so, non gliel’ho mai chiesto.»
«E adesso?» gli domando, sapendo di aver in faccia un’espressione inutilmente allarmata e di aver appena detto una cosa stupida perché i genitori di Limonov sono morti tutti e due.
Limonov mi guarda negli occhi, sorride forte e scuote un po’ la testa mentre mi risponde:
«E adesso niente. Non lo saprò mai.»
Sono passata per Piazza Municipio.
Si vedevano ancora i segni per terra, ma i lupi di Ruowang non c’erano più.
«Munnezz’!»
Sto percorrendo il corridoio mobile che congiunge le due linee della metropolitana di Napoli, quello che porta dalla stazione di Museo a quella di Cavour, quando sento questo grido. Subito dopo, un ragazzo bengalese mi supera a destra. Sento i passi rabbiosi di qualcun altro e non faccio in tempo a girarmi che un altro uomo mi supera urlando «Lota!» poi, prima di proseguire, si volta un attimo verso di me e mi dice:
«M’ha fatt’ ‘nu rutt’ dint’ ‘a ‘recchia, ‘sta munnezza!» e comincia a rincorrerlo.
L’uomo vende mini block-notes e penne di pessima qualità nelle stazioni della metropolitana di Napoli e io lo incontro spesso, l’ho incontrato anche all’inizio di questa storia, circa un anno fa. Ora mi piacerebbe raccontare questo aneddoto e dire che stavolta camminavo dritta con la schiena e stabile sui miei passi, mi piacerebbe dire che non ho avuto paura di affrontarlo, che ho detto a quell’uomo di lasciar stare quel povero ragazzo, che, per rabbonirlo, ho aggiunto che la cucina bengalese è un po’ pesante e che quello magari aveva fatto un rutto passandogli accanto ma non certo per farglielo in un orecchio. Mi piacerebbe, ma non faccio nulla di tutto questo. La verità è che mi sento sollevata dal fatto che quell’uomo non ce l’abbia con me, che sia distratto da qualcun altro e che mi sia passato accanto e l’unica cosa a cui penso ora è che è più o meno così che funziona, che a volte le cose ci passano accanto e a volte le cose ci succedono.

