di Matteo Romano
Copertina di Marta Di Giovanni
Parte prima
Nunzio fu scosso da un tremore lungo la schiena. Pensò che la morte gli fosse passata addosso, ma solo per un istante, come dicevano i vecchi del suo paese in quei casi. Se fosse stato davvero così avrebbe significato che anche quella volta era stato graziato. In verità, e malgrado l’estate, il vento del mattino, proveniente dal bosco, portava sempre con sé un’umidità che non solo scuoteva carne e ossa, ma irretiva e rabbuiava le anime più tormentate, proprio come la sua.
Il bambino non prestava attenzione alle costellazioni che pian piano si dissolvevano nel cielo. Con le mani infossate in tasca, teneva lo sguardo fisso sul vecchio pozzo, nel quale gettava, uno ad uno, i pensieri che avevano agitato il suo sonno. A tratti l’avvolgevano le folate nauseabonde che mandava il vaso da notte posato sull’erba, a pochi metri da lui. Udì il gallo cantare per la seconda volta che sembrò ridestarlo e richiamarlo alle incombenze che l’attendevano in quella ormai prossima e lunga giornata di lavoro.
La sua immaginazione, però, quasi a volerlo sollevare dalle ansie di quelle, gli pose davanti agli occhi la locandina di un film che aveva notato affisso, già da qualche giorno, accanto al bar nella piazza del paese. Nunzio non ricordava il titolo, ma aveva ben impressa nella mente la donna che vi era raffigurata. Una dai capelli scuri, sciolti, le labbra piene, lo sguardo ammiccante che sfidava quello dello spettatore. Aveva le cosce scoperte, la mano sul fianco tondo, la spalla nuda, il braccio forte e lucido, sul quale ricadeva, con maliarda noncuranza, la spallina della maglia rossa sotto la quale premevano i seni alti ed esuberanti.
Non appena affissa, la locandina aveva riscosso un immediato scalpore. Gli uomini si erano accalcati per studiare e commentare senza troppo ritegno quelle forme così procaci e impudenti. Nonostante l’aria greve e campagnola, a loro molto familiare, e in netto contrasto con la bellezza lasciva del suo volto, ai più sembrava addirittura inverosimile che potesse esistere una donna del genere. Alcuni l’avevano paragonata a una lupa, fiera e temibile. Altri, meno svergognati, passavano davanti al bar, lenti o veloci, sbirciandola di sottecchi, sognando di stringerla e respirare il suo odore penetrante e selvatico.
Ma quella locandina aveva suscitato anche sdegno e riprovazione. Le donne mormoravano fra i denti indicibili imprecazioni, si facevano il segno della croce e col palmo occultavano quell’oscenità agli occhi dei propri figli. Don Michele aveva ammonito il sindaco di non permettere la proiezione del film in piazza e di bruciare la pellicola e l’immagine di quella donna laida e lussuriosa. Il sindaco spiegò al parroco che il film non infrangeva alcuna norma della censura e lui replicò che l’unica legge che contava era quella di Dio, l’unica che rispettava la morale e l’uomo. Per non inimicarselo, il sindaco giunse ad un compromesso: gli promise che il film sarebbe stato proiettato per una sola sera e la locandina rimossa al termine dello stesso.
Il cinema era uno svago di cui gli abitanti del paese potevano godere talvolta solo in quelle calde serate estive. Nunzio avrebbe desiderato moltissimo assistere alla proiezione, ma suo padre Antonio gliel’avrebbe senz’altro proibito, e per risparmiarsi una tremenda sberla sul muso, se non anche peggio, non si sarebbe neppure azzardato a domandargli il permesso.
Proprio mentre rimuginava sull’attrice, udì uno scampanellio in lontananza. Distolse lo sguardo dal pozzo dirigendolo alla sua destra e restò in attesa. Man mano che quel suono diveniva più acuto, riconobbe anche un monotono scricchiolio accompagnato da pesanti passi che facevano vibrare il suolo. Dall’oscurità, sempre più languida, emerse un mulo che trainava pigramente un carro guidato da un uomo. Dietro di lui troneggiava un’enorme cisterna. Nunzio raccolse il vaso e andò incontro al carro. Quando il bambino gli fu vicino, l’uomo tirò a sé le briglie emettendo un verso tetro e baritonale che indusse la bestia ad arrestarsi. Nunzio respirò mal volentieri il tanfo degli escrementi e del piscio dei suoi compaesani. Porse il vaso all’uomo e spiò come al solito la sua grossa mano sinistra, una carnea tenaglia priva delle falangi dell’anulare e del mignolo. L’uomo scaricò il vaso nella cisterna e glielo restituì. Subito dopo scrollò lievemente le briglie incitando con un altro verso il mulo a riprendere la marcia. Lo scampanellio si andò spegnendo lungo il sentiero.
Nunzio osservò per qualche secondo i solchi profondi lasciati dalle ruote sull’erba e udì uno dei maiali grugnire nel porcile. Andò al pozzo, riempì il secchio e lo tirò su facendo cigolare la carrucola arrugginita. Con quell’acqua lavò il vaso, lo asciugò con una pezza e poi lo portò in casa lasciandolo all’ingresso. Infine si diresse alla stalla, sommerso da una vaga tensione che gli opprimeva le viscere.
Offrì del fieno alla vacca da mungere e quella lo addentò e lo masticò con gusto. Mentre mangiava, le accarezzava la testa e il dorso pezzato. Nunzio si accomodò sullo sgabello, tastò appena le mammelle tese e gonfie, posizionò il secchio al di sotto di esse e pulì i capezzoli con acqua tiepida. La mucca mugghiò un poco, ma poi s’acquietò subito. Il bambino avvolse le mani attorno ai capezzoli, alla loro base. Quando si sentì pronto, li spremette delicatamente in giù per tirare fuori il latte che bagnando il fondo metallico del secchio diffondeva brevi sibili. Nella stalla ronzavano mosche di cui Nunzio però non si curava troppo. Le lasciava zampettare sulle sue braccia, sulle gambe esili, ma le cacciava via con uno sbuffo se per caso gli tormentavano fronte o bocca.
Sgonfiata la prima mammella, si spostò sull’altro lato della vacca per mungere anche la seconda. Quella levò in alto la coda scrosciando un copioso fiotto di urina che gli schizzò appena le gambe. Continuò ancora a lungo con la mungitura, concentrandosi solo sul biancore immacolato del latte, finché, avvertendo il passo fiacco e claudicante di suo padre, s’irrigidì e, contro la propria volontà, spremette un capezzolo più del dovuto che però non procurò alcuna sofferenza all’animale.
L’aria nella stalla gli parve ancora più densa. Non si voltò e non rallentò il ritmo del lavoro. Con le orecchie ben aperte, però, avvertiva il respiro trafelato del padre, sintomo ineccepibile della sua sforzosa andatura. Immaginava il suo piede storpio trascinato sul pagliericcio, i suoi occhi scuri posarsi sulle vacche, sul foraggio ammucchiato in piccoli cumuli per terra, sullo sterco fresco e sulla propria schiena. Neppure quando gli si avvicinò chinandosi per controllare la quantità di latte nel secchio osò guardarlo. Inalò il suo fiato, che sapeva ancora del vino bevuto la sera precedente. Antonio si allontanò e prese a vagare per la stalla. Nunzio lo sentì armeggiare con gli attrezzi, schiarirsi la gola, riavviarsi e fermarsi sulla soglia.
«Quando finisci leva la merda. E dopo vai nel pollaio» disse Antonio.
La ruvida voce del padre gli scorticò le spalle. Ebbe un sussulto, impercettibile. Udendo lo strascichio del suo piede disgraziato, si girò e con la coda dell’occhio lo vide andare via sfregando le punte del forcone sul pietrisco sparso davanti alla stalla.
Terminata anche la mungitura delle altre vacche, spalò lo sterco e obbedì a suo padre.
«T’ho detto già che non posso».
«Ma come non puoi?» domandò lamentoso Peppino.
«Guarda» disse Antonio indicando il porcile. «Di maiali non ne ho più».
Una scrofa, sdraiata su di un fianco, e quattro maialini che si rincorrevano e rotolavano nel fango.
«Dammene uno, mi va bene pure se è piccolo!».
Antonio scosse la testa.
«E dai! Ti sto chiedendo un piacere. È per il matrimonio di Marisa. Che gli devo far mangiare agli invitati?».
L’altro però si chiuse in un cocciuto silenzio.
«Oh, ma che pensi che lo voglio regalato? Te lo pago bene, te lo pago pure il doppio. Il triplo, se vuoi! Che ti fa schifo qualche lira in più?».
Antonio abbassò lo sguardo divenendo pensoso. Stropicciandosi un lembo della camicia ingiallita, Peppino scrutava la faccia del fattore in attesa di un segno di assenso. Ma il suo mento ispido, la bocca e la fronte bruciate dal sole restavano immobili. Solo il sopracciglio destro si arcuò all’improvviso denotando ulteriore incertezza e cattive sensazioni.
Trascorso qualche istante, Antonio sollevò gli occhi e disse: «E va be’, te lo sistemo. Vieni a pigliartelo uno di questi giorni».
«Grazie, Antò!» disse Peppino stringendogli le mani.
Il fattore però rifuggì subito quella presa suscitando nell’uomo un rammaricato stupore.
«Vado a pigliarti i pomodori» e così dicendo s’incamminò verso le cassettine impilate davanti all’uscio di casa.
Seguendo quell’andatura storta e ciondolante, Peppino ripensò a quando in paese si sparse in un baleno la notizia del ritrovamento di Antonio in fondo alla gravina. Se n’era accorto un ragazzo, sceso al torrente per pescare trote, che aveva udito il suo pianto e le grida disperate. Antonio sostenne e giurò sempre di essere scivolato giù, ma tutti pensarono prevedibilmente al tentativo di suicidarsi: aveva appena perso la moglie Caterina in seguito al parto. Due disgrazie, l’una appresso all’altra. In ogni caso, il destino fu implacabile e ironico con lui. Per punire il suo gesto, gli aveva donato una menomazione, un figlio da tirare su da solo e un dolore che l’avrebbe spolpato e accompagnato fin dentro la tomba.
Peppino ricevette la cassettina e la esaminò con fulminea circospezione. Pagò e salutò Antonio che, dopo aver trattenuto lo sguardo su di lui per alcuni secondi, si andò a sedere sotto il pesco per ripararsi dal sole già cruento in quelle prime ore del mattino e fumarsi una sigaretta.
Diede un’occhiata nella stalla e la trovò pulita, poi andò nel capanno degli attrezzi per prendere l’ascia.
Nunzio era fuori dal pollaio. Sull’aia spargeva a piccole dosi il mangime che le galline beccavano rapide e furiose.
«Nù! Vai a pigliare la legna per la cucina» gli urlò Antonio.
Il bambino riannodò il sacco del mangime, lo posò e corse dietro la casa. Nel frattempo Antonio si diresse al ceppo.
Nunzio gli portò la quantità che gli occorreva, compiendo diversi viaggi e imbracciando due grossi pezzi per volta. Una minuscola scheggia gli infilzò il palmo. Gli face male, ma non disse nulla al padre.
L’arsura rese il lavoro ancora più faticoso. Dopo diversi fendenti, Antonio fu costretto a rifiatare e ad asciugarsi il sudore che gli colava negli occhi bruciandoglieli. Spaccava la legna raccolto nei suoi pensieri. Se il filo dell’ascia gli restava incastrato nel ceppo lo smuoveva bruscamente per liberarlo, bestemmiando Dio e la Madonna.
Accatastata la legna, gridò al figlio di conservarla in casa. Andò al trogolo di pietra per rinfrescarsi, ma l’acqua era calda e stagnante. Sul pelo ci galleggiavano rimasugli di fieno. Si abbassò comunque le bretelle per levarsi la maglia. Si sciacquò strofinandosi forte il viso, le ascelle e il petto lanoso.
Dopo essersi lavato, notò una figura minuta discendere il sentiero. Strizzò gli occhi per impedire al sole di offuscargli la vista e capì presto che si trattava della nipote della maciara. Dimenticò la maglia zuppa e imbrunita sul bordo del trogolo, si sistemò le bretelle e attese l’arrivo della piccola.
Anche Nunzio si accorse di Donatella. Mentre faceva la spola tra il ceppo e la casa, le lanciava delle brevi occhiate che però lei non gli ricambiava, dal momento che stava ben accorta a dove metteva i piedi.
La bambina raggiunse Antonio e lo squadrò con un’espressione seria e indagatrice. L’uomo le rimandò il suo con la precisa intenzione di domare quell’azzurro per lui troppo luminoso e insolente. Donatella aveva i capelli raccolti in una treccia, nera. Indossava un leggero vestito blu, con le maniche ricamate da un pizzo bianco e l’orlo della gonnellina appena strappato. In mano stringeva il suo solito canestro. Solo quando Antonio stette a fissarle con insistenza le gambette impolverate e una ferita ancora sanguinante sul ginocchio, la bimba chinò il capo per manifestare la propria resa.
Ghignando, Antonio disse: «Che vuoi, signorina?».
«Dieci uova» rispose. «E due secchielli di latte».
«Due?».
Donatella annuì.
«Ne pigli sempre uno. Che se ne deve fare tua nonna di due? Qualche magagna delle sue, eh?».
«M’ha detto di pigliarne due».
L’uomo restò in silenzio, sospettoso. Lei osò guardargli l’addome prominente e ancora gocciolante.
«Nù!» gridò.
Il bambino buttò per terra la legna e si fiondò dal padre.
«Dieci uova» disse Antonio.
Donatella gli diede il canestro, Nunzio lo afferrò, senza guardarla in faccia, e scappò nel pollaio. Antonio si avviò verso la stalla. Riempì i secchielli, ci sputò dentro e con la mano rimestò la sua saliva col latte. Si ritrovò il figlio all’ingresso della stalla, con il canestro pieno. Nunzio capì dall’espressione truce del padre che avrebbe dovuto levarsi di mezzo, immediatamente, e finire di portare tutta la legna in casa.
Donatella lo ringraziò per le uova, lui però non rispose e neppure in quel frangente ebbe il coraggio di guardarla. Si rimise subito a lavoro, osservato dalla bambina con un insolito interesse che lei stessa non seppe spiegarsi.
«Tiè!» disse Antonio poggiando i secchi sull’erba.
Donatella gli diede i soldi e lui tornò al trogolo per infilarsi la maglia. Vedendola ancora lì impalata, chiese: «Che c’è?».
Donatella se ne stava muta.
«Oh, allora?».
«Non ce la faccio a portare tutto da sola».
«E a me che me ne fotte. Fai avanti e dietro».
«… co’ ‘sto caldo il latte va subito a male. Nonna vorrà poi i soldi indietro».
«Puttanella» sussurrò Antonio tra sé e sé.
Si grattò il mento, le andò incontro e disse: «Sei furba tu, eh! Come la nonna».
Poi tuonò il nome del figlio. Gli comandò di aiutare Donatella a portare i secchi e di sbrigarsi, perché c’era ancora tanto da sgobbare. Infine ricordò alla piccola di restituirglieli quanto prima.
Nunzio afferrò i manici e il dolore causatogli dalla scheggia si acuì. Poi, dondolando un po’, s’incamminò con Donatella lungo il sentiero, che via via aumentava la propria pendenza.
Lo scalpiccio, i cinguettii e l’incessante frinire delle cicale colmavano il loro silenzio. Donatella sapeva bene che Nunzio era un taciturno, che apriva bocca solo se interrogato dal maestro, pertanto non cercò di forzarlo ad avere una conversazione. Il suo sguardo, però, che oscillava tra le uova, lo sterrato e l’erba sul limitare del bosco, dalla quale vedeva sbucare ogni tanto un ramarro o un bombo, non resisteva al desiderio di cogliere in lui un particolare che ad ogni nuova occhiata la profondeva in qualche appassionante ragionamento. Credeva fosse molto sporco e in generale sciatto nell’aspetto. Inoltre, doveva ammettere ciò che sosteneva la maggior parte dei suoi compagni di classe: Nunzio puzzava. L’odore di stalla e siero che diffondeva era talmente invasivo da dare alla testa. Notò che aveva un’ecchimosi sul collo. Era scura, con il contorno giallognolo e sbiadito.
Poi Nunzio emise un gemito, Donatella si voltò verso di lui e disse: «Se vuoi ci fermiamo. Oppure mi puoi dare un secchio».
Ma Nunzio strinse i denti e udendo quelle parole chinò il capo e alzò addirittura il passo. Il sudore gli grondava sulla schiena. La scheggia gli bruciava la mano che sentiva pulsare come un piccolo cuore. Il peso dei secchi a lungo andare lo trascinava sempre più in basso tirandogli spalle e braccia. Sollevò per un attimo la testa e vide che per sua fortuna la salita era ormai terminata.
Il tetto spiovente della casa della maciara spuntò come un canino marcio. La costruzione era prossima alla boscaglia, avvolta nel tepore dell’ombra che contribuiva a conferirle la sua peculiare aria sinistra.
La donna, quella decrepita e diabolica cariatide, così come l’apostrofava il parroco, era stata messa al bando dall’intero paese da tempo ormai immemore. I contadini che nel cuore della notte si avviavano ai campi, costeggiando il bosco, raccontavano che in quei paraggi l’aria diveniva di colpo infetta, che sapeva di zolfo, come l’inferno, e giuravano di udire la maciara urlare e strepitare come una belva indemoniata. Dicevano che compiva riti osceni e disumani, che la notte si accoppiava con lupi, cinghiali e serpi. E la chiamavano la puttana del Diavolo. Da giovane, per ottenere i suoi poteri, aveva accettato di lasciarsi possedere ripetutamente dal Maligno e di ingurgitare il suo venefico seme. Ma c’era chi non credeva e non badava a tutte quelle dicerie. Alcuni pensavano si fosse perfino intenerita da quando aveva accolto in casa la bambina, quell’innocente creatura abbandonata ancora in fasce nel bosco e mai battezzata. Ma altri si angosciavano per la sorte della piccola. La vecchia, ribattevano, in realtà non nutriva per lei alcun affetto: l’aveva accolta solo per farne una servetta, senz’altro utile dato l’inesorabile avanzare dell’età. O forse per farne la propria discepola, erede di un sapere antico e oscuro.
Nonostante tutto, la casa era frequentata specialmente da donne che si recavano lì di nascosto per usufruire dei suoi onerosi favori. Le chiedevano di attaccare al loro sangue gli uomini amati. Di lenire la cefalgia e altri malanni, dileguare la paura e scagliare tremendi malefici alle proprie rivali o alle persone odiate.
Proseguirono ancora per un po’, finché Nunzio si bloccò e poggiò i secchi. Non aveva la minima intenzione di andare oltre. Da quel punto la casa della maciara distava una cinquantina di metri. Tentò con tutte le sue forze di trattenere il tremolio delle braccia dovuto alla fatica, ma non ci riuscì, e questo non sfuggì né all’occhio né all’animo di Donatella.
«Grazie, poi te li riporto» disse lei.
Nunzio si fece dubbioso. Eludendo per l’ennesima volta lo sguardo azzurro di Donatella, disse: «Non lo bere».
«Che?».
«Il latte… non lo bere».
«E perché?».
«Tu non lo bere e basta».
Si voltò e andò via, instillando in lei domande e pensieri che non avrebbe sbrogliato in nessun modo. Non appena sentì la porta della casa aprirsi si affrettò.
«Sei caduta di nuovo, cretina» stridette una voce roca e profonda. A quella fece seguito un suono secco che Nunzio conosceva molto bene. S’immaginò presto gli occhi acquosi di Donatella che straripavano in silenzio sulla sua gota arrossata.
Rotolando sulla discesa polverosa, scioglieva le braccia per riacquisire vigore e sensibilità. A un tratto si fermò per osservarsi il palmo. Era gonfio. Se lo pizzicò per provare a far uscire la scheggia, ma l’unico risultato fu un fastidio ancora più lancinante. Per una scheggia così piccola e corta, pensava, avrebbe avuto bisogno di una pinzetta. Poi, rinsavendo, si lanciò sulla strada a tutta velocità, augurandosi che il padre non lo strigliasse o punisse per aver tardato.
Antonio non disse nulla al suo ritorno, si sincerò soltanto che si fosse rimesso subito all’opera: c’era ancora la catasta di legna da conservare.
Terminato anche quel lavoro, Nunzio non ebbe neppure un attimo di tregua, fu spedito direttamente nel porcile per pulirlo e riempire la mangiatoia col pastone. Odiava farlo. Gli capitava spesso di pestare escrementi mischiati al fango e di dover poi impiegare diverso tempo per levarseli a dovere dalle suole. La scrofa inoltre, nelle giornate in cui era più inquieta, non si esimeva dal tentativo di morderlo. Per tenerla alla larga doveva picchiarla con un nerbo di bue. Ma era la puzza dei maiali che proprio non poteva soffrire. E a nulla servivano i ripetuti lavaggi al trogolo e sfregarsi il corpo fino a irritarlo. Se la portava fin dentro il suo letto. La sentiva trasudare dalla pelle e si convinceva di essersi tramutato lui stesso in un lurido porco.
Suo padre seppe come impegnargli il resto di quella mattinata infuocata. Resistette ad un improvviso capogiro che gli oscurò la vista per alcuni istanti, ai morsi sempre più voraci della fame, ma soprattutto alla scheggia che continuava imperterrita a tormentargli la mano.
Solo quando il sole cessò di proiettare le ombre, Antonio decise che poteva bastare. Pranzarono con pane e salame, e la frescura della cucina procurò a entrambi enorme sollievo. Il bambino si nascose una fettina di salame in tasca nel momento in cui il padre si alzò per riempire la brocca di vino.
Antonio fumò una sigaretta dopo mangiato, poi se ne andò a dormire.
Nunzio rimase ancora seduto. Fissava il pacchetto di sigarette e la scatola di fiammiferi dimenticati sul tavolo fra le briciole e la pelle del salame accartocciata. Non passò molto che udì il padre russare gravemente. Sfilò una sigaretta, spezzò un fiammifero e uscì di casa in punta di piedi.
Se ne stava sdraiato sotto il pero. I nugoli di fumo gli suggerivano le forme più bizzarre. Fumare gli alleggeriva la testa e, anche se per poco, l’aiutava a tenere a bada i brutti pensieri.
Vedendo Ciaciu balzare fuori dalla sterpaglia, si tirò su per sedersi e spense il mozzicone. Il gatto gli si strofinava addosso facendo le fusa. Aveva già fiutato il suo spuntino. Si rotolò un paio di volte e alla fine si accovacciò tra le gambe incrociate di Nunzio che a quel punto lo accontentò imboccandogli il salame. Ciaciu si lasciò accarezzare la testolina nera, finché, attratto da un improvviso fruscio, si rituffò nella sterpaglia.
Si alzò per raggiungere il sentiero. Il sole infieriva sulle sue gracili membra e lo ingannava mostrandogli illusorie pozze d’acqua. Nunzio si voltò a sinistra parandosi la visuale dai raggi. Laggiù, ma non molto lontano, si estendeva il paese che sonnecchiava e sfrigolava esausto in una possente bolla di calore. Le case, per lo più bianche, risplendevano nitide e accecanti. Nunzio immaginò gli scuri delle finestre serrati e le strade mute e deserte. Fu rapito dal desiderio di fiondarsi giù solo per andare a sbirciare la locandina del film e scoprire il nome dell’attrice, ma forse qualche vecchia pettegola, nascosta dietro gli scuri, avrebbe potuto beccarlo e rimproverarlo della propria impudicizia, così preferì inoltrarsi nel bosco.
Il sole filtrava a fatica tra le chiome degli alberi, ma ciò non era sufficiente a rendere l’aria meno afosa. Man mano che Nunzio si addentrava, la vegetazione s’infittiva e si aggrovigliava su se stessa. Scorse le tracce degli zoccoli dei cinghiali, impresse sulla terra umida, e sobbalzò scovando nell’erba la muta di un serpente che aveva creduto vivo e pronto ad azzannarlo. La raccolse e provò ad avvolgersela attorno al braccio, ma era talmente secca che si spezzò. Pensò che se fosse stato velenoso e terribile come una vipera nessuno avrebbe osato mai fargli del male.
Proseguì ancora per un po’, accarezzato dalle foglie, graffiato dai rovi, e alla fine giunse allo stagno. Si spogliò completamente, lasciò i suoi cenci sulla riva e non appena sfiorò l’acqua rabbrividì. Mentre avanzava vedeva i pesci, una rana e quelle piante acquatiche di cui non conosceva i nomi. Si fermava sempre quando l’acqua gli arrivava al petto. Andando oltre, i suoi piedi non avrebbero più toccato il fondale. Si lavò con dovizia, insistendo soprattutto sui capelli, le orecchie e il collo ustionato. Il refrigerio dello stagno gli diede solo l’impressione che la scheggia fosse uscita dal palmo. Si mise a galleggiare come un morto. Fissò per qualche momento lo scuro fogliame sopra di lui e poi chiuse le palpebre. Gli sembrava di poter sentire i pesci nuotare e scappare via e che l’acqua gli fosse entrata in testa penetrandogli le orecchie. Si fece cullare dal quel silenzioso dondolio per diversi minuti, poi si risvegliò. Tornato a riva, udì un fruscio seguito da un forte scricchiolio. Tremante, raccolse i vestiti per coprirsi. Si guardò intorno, ma non vide niente e nessuno. Si rivestì in fretta e s’incamminò verso casa. Lungo il tragitto si annusò più volte: era ancora un maiale.
Suo padre l’aveva atteso sulla soglia. In mano stringeva il nerbo. Nunzio gli andò incontro e quando gli fu innanzi piegò lo sguardo.
«Dove sei stato?» domandò Antonio.
«Giù, in paese».
«Guardami» gli ordinò il padre.
Lui gli ubbidì.
«A fare che?».
«Niente».
«Niente…» ripeté Antonio.
Stette a fissare il figlio negli occhi e aggiunse: «E le sigarette?».
Nunzio non rispose, allora Antonio gli rifilò un manrovescio sui denti che lo fece crollare a terra. Il piccolo sputò un rivolo di sangue.
«Così impari a rubare! A me ruba, a me! Che gli do il pane tutti i santi giorni!» ringhiò Antonio.
Nunzio si rannicchiò, coprendosi il viso. Il padre prese a frustarlo, ma non come si fa con le bestie. Lo frustava esplodendo tutta la ferocia del proprio rancore, inveendogli contro, chiamandolo bastardo e infame. Lo prese a calci, rischiando di inciampare lui stesso a causa del piede malfermo. Quando la tensione e il suo respiro si frantumarono in mille pezzi, Antonio si placò.
«Nel pollaio, muoviti» disse ancora ansante. «E stasera non mangi!».
Nunzio raccolse rapidamente le forze e fuggì nel pollaio agitando le galline al suo arrivo.
Si accorse di avere un graffietto sulla guancia. Se lo tamponò con il colletto.
Finito di lavorare, si lavò via il sangue rappreso e il trogolo gli restituì il suo torbido riflesso increspato.
Poi calò la sera.
Nunzio fu costretto a cucinare la zuppa di fagioli e a guardare il padre mangiarla. Sedeva zitto, con gli occhi incollati sul tavolo. Sentiva la legna ardere e scoppiettare nel forno della cucina, i timidi lamenti del proprio stomaco e la bocca del padre succhiare la zuppa. Sollevando di poco lo sguardo, poteva vederlo leccarsi le labbra e i baffi imbrattati dopo ogni cucchiaiata.
«Vai a pigliare il vino» disse Antonio masticando.
Inclinare la damigiana era un’operazione che gli procurava sempre non poche preoccupazioni. Fece attenzione a non strabordare, ma sporcò il pavimento con qualche goccia. Le asciugò strofinandoci su il piede e tornò a tavola.
Antonio beveva un bicchiere dopo altro. Ruttava, si schiariva la gola e ad ogni respiro la sua pancia si comprimeva sul bordo del tavolo.
«Metti l’altra» disse lanciandogli il coccio di terracotta.
Nella pentola erano rimasti altri tre mestoli. La vuotò tutta e servì il padre che gli rivolse un’occhiata soddisfatta. Era convinto che dopo quella lezione il figlio avrebbe smesso per sempre di rubargli le sigarette, o qualsiasi altra cosa. Scrutò ancora per un po’ il suo viso austero, lievemente accigliato, e la leggera escoriazione che gli segnava la guancia. Dopo, sogghignando, riprese a ingozzarsi.
Il tintinnio del cucchiaio contro il coccio suonava al bambino irritante e beffardo. Restò con lo sguardo chino sulle proprie gambe, sperando disperatamente che il padre cambiasse idea lasciandogli mangiare almeno un tozzo di pane.
«Vai» digrignò Antonio sbattendo la brocca sul tavolo.
Nunzio la riempì ancora, nonostante non fosse del tutto vuota. Per concludere il pasto, Antonio tagliò qualche fetta di salame. Nel farlo spiò il figlio, che però fu impassibile.
Quando sfregò il fiammifero sulla minerva, Nunzio sussultò. Quel suono gli era parso come uno strappo. Antonio sbuffò il fumo e disse: «Metti a posto e vattene».
Nunzio sparecchiò, lavò le stoviglie e salì nella sua stanza, piccola e squallida, arredata solo con un letto e una vetusta cassapanca. C’era una finestrella tonda che di notte teneva aperta per non soccombere all’opprimente calura assorbita dalla stanza durante il giorno. Si spogliò restando solo con canotta e mutande. Si stese e, trovata la posizione più comoda, s’immobilizzò, altrimenti le foglie di granturco avrebbero continuato a pungerlo su tutto il corpo.
Scandagliava inutilmente il soffitto buio e ascoltava tutti i rumori, perfino i più lievi, provenienti dalla cucina. La sedia stridere sul pavimento, il gorgoglio del vino versato dalla brocca. Sentiva il padre sbattere di tanto in tanto un pugno sul tavolo, sbraitare e imprecare da solo. Nunzio pregava che il vino e la stanchezza lo stordissero da un momento all’altro. Pregava di udire quel russare che paragonava sempre al grugnito di un verro. Invece gli giunsero dei singulti strangolati e soppressi nella rabbia. Poco dopo si dipanò un indecifrabile silenzio, ma al bambino fu subito inequivocabile che quello non avrebbe resistito ancora a lungo.
Le assi scricchiolavano sotto i passi che si arrampicavano a tentoni sulla scala. Per reggersi Antonio strisciava la mano sul muro scorticato. Le tenebre e i fumi dell’alcol trasfiguravano la percezione della rampa facendogliela apparire troppo ripida e angusta. Ansava, ma uno scuro e inflessibile istinto gli infondeva la forza necessaria per proseguire. Giunto in cima, varcò la porta.
Le luci della notte rischiaravano debolmente l’oscurità della stanza, nella quale aleggiava un intenso odore di muffa. Il figlio giaceva sul letto, con la testa affondata nel cuscino. Antonio avanzò barcollando fino a lì. Incrociò gli occhi spalancati del bambino che rilucevano di un pallore spettrale. La bocca socchiusa non emetteva fiato. Il corpo seminudo gli pareva rigido, come un cadavere. Provò terrore e odio per quel mucchietto di carne e ossa. Poi si levò le bretelle, si abbassò i pantaloni e cominciò a toccarsi il membro. Il figlio si mise prono, si scoprì il sedere e divaricò appena le gambe. Quando il suo pene s’indurì, Antonio se lo sputò. Infine salì sul figlio, possedendolo come una bestia.
Nunzio sopportava quegli attimi interminabili trincerato nel proprio silenzio, annientato da una crudele vergogna. Non si domandava più le ragioni di ciò che subiva. E non piangeva più, né durante né dopo. Quella notte però tentò di seppellirsi nel dolore ancora vivo nel palmo, ma non fu abbastanza. Allora immaginò, come tutte le volte, di tuffarsi nel vecchio pozzo. Di sprofondare negli abissi e finalmente morire. Solo così sarebbe stato salvo da suo padre. E invece sopravvisse anche a quella notte.
Parte seconda
Antonio era a torso nudo. Immerse la testa nel trogolo e si asciugò con uno strofinaccio penzolante dall’orlo della cintura. La giornata era più torrida della precedente, perfino le ombre sobbollivano sciogliendosi lente sul suolo. L’uomo fu attraversato da un pensiero improvviso e tornò in casa. Prese due piccole forme di formaggio che avvolse in un canovaccio bianco e pulito. Uscì e guardandosi intorno cercò il figlio.
«Nù! Nunzio!».
Lo vide spuntare da dietro il pollaio. Il suo incedere gli pareva sonnolento.
«Oh!».
Sollecitarlo non sortì alcun effetto. Antonio credeva lo facesse di proposito, per innervosirlo o sfidarlo, ma non cedette all’ira.
«Tiè» disse mettendogli il canovaccio in mano. «Portalo al dottore. E fai ‘na cosa di giorno. M’hai capito?». Nunzio annuì, senza rivolgergli un’occhiata, si girò e prese il sentiero che presto lo condusse in paese.
Camminava a testa bassa, rasente alle abitazioni per calarsi nell’ombra. Si sentiva addosso gli occhi dei passanti o delle donne affacciate alle finestre e ai balconi per stendere il bucato. Nessuno però lo salutava o gli prestava troppa attenzione, il che fu per lui un conforto.
Seduti ai tavolini del bar, notò alcuni uomini intenti a discutere fumando e bevendo. Da quel capannello si levavano risate e strepiti. Si avvicinò solo per poter sbirciare la locandina. Riso amaro, lampeggiava il titolo in rosso. Silvana, il nome dell’attrice. Proseguì svelto, costeggiando la chiesa, e lungo la via che portava alla casa del dottore incrociò Daniele e Gianni. I due lo squadrarono ridacchiando e bisbigliando fra loro. Suonò il campanello e Angelina aprì la porta.
«Nunzio, ciao!» disse la ragazza mostrando un largo sorriso.
Annusando l’aria, arricciò però il naso, sperando che quel gesto, seppur irriflesso, non avesse urtato la sensibilità del bambino.
Nunzio le porse l’involto che lei maneggiò con cura.
«Mi dispiace se t’ho fatto venire fino qui, ma oggi ho tanto da fare, non potevo proprio salire da voi». «Non fa niente» disse lui.
«Vado a prenderti i soldi».
Lo lasciò sulla soglia e, dondolando i fianchi, si recò nell’ultima stanza in fondo al corridoio, lo studio del dottore. Ritenendolo sconveniente, Nunzio scostò lo sguardo dai fianchi di Angelina fissandolo sul pavimento dai motivi floreali. Poi si voltò a destra. In lontananza vide che i due bambini erano ancora nel punto in cui li aveva trovati. Ebbe la sensazione che lo stessero tenendo d’occhio, ma li ignorò. Udendo come un lieve trottare si accorse che Angelina era già di ritorno.
La ragazza sbuffava sorridendo e con la mano si sventolava il viso umido e accaldato. Mandava una fragranza inconsueta: quella suadente di un giovane corpo misto a una nota più aspra, enigmatica, quasi seccante, che tuttavia più veniva inalata più smuoveva negli uomini forze profondamente sopite.
Quando Nunzio aprì il palmo per ricevere il denaro, Angelina fece una smorfia. Rattristati all’improvviso, i suoi begli occhi bovini esaminarono la mano gonfia e rossa di Nunzio.
«Che hai fatto qui?» disse afferrandogliela con delicatezza.
La ragazza se l’avvicinò e intuì subito il problema.
«Vieni» disse prendendolo per la spalla.
Nunzio avvampò a quel tocco così premuroso. Sarebbe voluto scappare via, ma i modi di Angelina glielo impedirono. Mentre camminavano nel corridoio, la ragazza gli appiccicò il fianco alla spalla scheletrica. Sotto la veste sottile, Nunzio avvertiva la morbidezza di quel corpo e il suo strano odore.
Angelina bussò e disse: «Papà!».
«Sì?».
Entrarono. Nunzio si guardò intorno spaesato. Sulla sinistra campeggiava una libreria colma di tomi dai bordi consunti. Un tappeto al centro della stanza e, addossato al muro, un divano. Una scrivania, dietro la quale sedeva il dottore, e due poltrone in pelle.
«Nunzio. Come andiamo, giovanotto?» disse il dottore alzandosi per raggiungerlo.
«Buongiorno» rispose il bambino con un filo di voce.
Quando si trovò l’uomo davanti inclinò la testa.
«Ha una spina nella mano» disse Angelina.
«Fa’ vedere» disse il dottore.
Nunzio allungò la mano, il dottore la prese nella sua e la osservò in silenzio. Gliela tastò e il bambino si lamentò un po’. Lo invitò a sedersi sulla poltrona e uscì dallo studio, scambiandosi uno sguardo con la figlia. Angelina accarezzò la spalla di Nunzio accorgendosi poi del livido sul collo.
Nunzio fissava la possente scrivania in mogano, vivendo un’ansia che non poteva calmare. Essere in quello studio, su quella poltrona, gli sembrava sbagliato. Le attenzioni che la ragazza e il padre gli stavano riservando immeritate. I suoi piedi non toccavano neppure per terra. Avrebbe voluto ciondolarli per allentare la tensione, ma si contenne.
Il dottore rientrò con tutto l’occorrente e lo posò sulla scrivania. Inforcò gli occhiali, afferrò una pinzetta e chiese a Nunzio di porgergli la mano. Gli pizzicò la parte interessata, ma stavolta il bambino non si lagnò. Mentre lo medicava, teneva lo sguardo sui baffi bianchi e curati del dottore che gli coprivano quasi completamente la bocca.
«Eccola qui» disse estraendo la scheggia e mettendola su una garza.
Strappò del cotone, lo imbevve di acqua ossigenata e disinfettò il forellino scavato dalla scheggia. Nunzio la guardò: era più lunga di quanto avesse immaginato.
«E questo?» disse il dottore disinfettandogli anche il graffio in faccia.
Nunzio non rispose.
«Bene. Abbiamo fatto, giovanotto. Adesso sei come nuovo. La mano si sgonfierà subito, vedrai» disse dandogli una pacca sulla coscia.
«Grazie» disse il bambino.
«Prego. Ma cerca di stare attento, eh! E ringrazia tuo padre. E digli pure che il suo formaggio è il migliore che io abbia mai mangiato in vita mia. Ricordati di dirglielo, mi raccomando».
Nunzio assentì, salutò e Angelina lo condusse fuori dallo studio, posandogli la mano sulla schiena.
Sulla soglia, la ragazza si congedò da lui accarezzandolo e baciandolo sulla fronte. Nunzio si sentì il cuore in gola, poi si riavviò. Passò di nuovo davanti al bar, scoprendo che la proiezione del film era proprio quella sera stessa. Non rivide più Silvana, ma ne conservò il ricordo.
Risaliva il sentiero ciottoloso più in fretta che poteva. Solo allora si rese conto che la medicazione gli aveva sottratto tempo preziosissimo. A un tratto, alle sue spalle, udì uno scalpicciare frenetico. Si voltò: Daniele e Gianni. Alzò il passo e i due lo imitarono. Stava per scivolare, il che innescò l’immediata ilarità dei bambini.
«Culo di merda!» gridò Daniele.
Un ciottolo gli volò accanto, un altro invece gli centrò la schiena. Non si fermò, né si girò: non voleva cadere nelle loro provocazioni. Voleva tornarsene a casa, e basta.
«Oh! A te dico, coglione!».
Nunzio cominciò a correre e i due si fiondarono al suo inseguimento, come segugi per acchiappare una lepre. A lungo andare però il pendio gli bruciò le gambe, che iniziava a sentire sempre più dure e pesanti. Dal trapestio e dai corti respiri dietro di sé, indovinò che anche loro avevano rallentato la corsa, tuttavia era certo che non avrebbero mollato. Lo sforzo lo costrinse a smorzare l’andatura e infine a fermarsi del tutto terminando così la propria fuga. Si piegò e prese a boccheggiare per riprendere fiato. Aveva la gola secca. Pensò che recuperando un po’ le energie avrebbe potuto darsela di nuovo a gambe, ma Daniele e Gianni, nonostante fossero altrettanto stremati, lo avevano ormai raggiunto. Non aveva altra scelta se non affrontarli.
«Dove credevi di scappare, Culo di merda?» disse Daniele asciugandosi il sudore dal volto.
Teneva un occhio chiuso a causa del sole. Si accovacciò per raccogliere un ciottolo e cominciò a giochicchiarci lanciandoselo da una mano all’altra.
«Allora, non dici niente? Sempre zitto stai. Ma che sei muto, per caso?» disse.
«Forse non parla perché gli puzza pure il fiato! Culo dietro e culo in faccia!» sghignazzò Gianni.
Anche lui prese una manciata di ciottoli conservandoseli in tasca.
Nunzio sentiva il proprio respiro regolarizzarsi. Ipotizzò che se avesse afferrato un sasso per difendersi da un eventuale attacco i bambini avrebbero fatto subito fuoco senza dargli la possibilità di rispondere. Accapigliandosi, invece, avrebbe avuto la peggio, essendo in inferiorità numerica. Inoltre Daniele e Gianni erano più robusti e forti rispetto a lui, non avrebbe potuto spuntarla neppure fronteggiandoli singolarmente. Forse volevano solo intimorirlo e tormentarlo un po’, come capitava spesso a scuola. Allora decise di starsene quieto, indugiare e non aizzarli in alcun modo.
Daniele avanzò di un passo scrutando la sua preda. Gianni in sordina si allargò sulla destra per circondare Nunzio, al quale ora restavano soltanto due vie di fuga: il pendio, che l’avrebbe ulteriormente sfiancato, e il bosco, senz’altro la più impervia.
Nunzio abbassò lo sguardo e indietreggiò e loro vennero avanti stringendolo ancora di più.
«Dacci i soldi, Culo di merda!» lo intimò Daniele. «Veloce. Sennò ti pigliamo a sassi».
«Non ne ho» disse Nunzio.
«Stai zitto! Tanto non ci fai fessi, lo sappiamo che ce li hai. Sbrigati o ti spacchiamo quella faccia da Culo di merda che c’hai!».
Ma Nunzio non mosse un muscolo, si limitò a sollevare gli occhi incrociando quelli di Daniele. Il bambino, stizzito da quell’inaspettata opposizione, gli andò incontro per frugargli le tasche. Nunzio previde le sue intenzioni e gli schiaffeggiò la mano. Sempre più sorpreso, e irritato da quel gesto per lui arrogante, Daniele gli tirò un ceffone in pieno viso. La guancia di Nunzio non tardò a imporporarsi. I bambini risero, poi Daniele tornò serio e tentò ancora una volta di frugare Nunzio che si difese spintonandolo.
«Mo so’ cazzi tuoi!» gridò Daniele.
Gli tirò il ciottolo che aveva in mano e ne raccolse un altro per continuare la sua offesa. Gianni fece lo stesso. Nunzio si parava il viso e la pancia scoprendo però altre parti del corpo. Una pietra gli colpì una costola e urlò di dolore. Era deciso a fuggire, doveva tentare. Se fosse giunto nei pressi di casa sua, i due avrebbero desistito vedendo il padre. Invece, di colpo, Nunzio aggredì Daniele buttandolo a terra, come quelle bestie ferite a cui non resta altro che combattere per vivere. Gli graffiò la faccia, gli tappò la bocca e gli sferrò un pugno sul naso. Gianni nel frattempo s’imbambolò, terrorizzato da quella furia micidiale. Daniele reagì morsicando Nunzio, che però afferrò alla rinfusa una grossa pietra con la quale gli colpì l’occhio. Scattò in piedi e fuggì via. Gianni non provò ad inseguirlo, si piegò sull’amico per soccorrerlo. Nunzio correva. Correva all’impazzata. Le grida e i pianti di Daniele gli rimbombavano nelle orecchie.
Antonio ricevette il denaro dal figlio, ma non gli chiese perché fosse tutto sporco e impolverato, perché ci avesse impiegato così tanto, si preoccupò solo di rimetterlo a lavorare.
Quella mattina Antonio era stato impegnato con la raccolta delle pesche riempiendo diverse cassette. Poi si era trattenuto nei paraggi per scovare qualche cicoriella.
Era piegato sulla terra, a seminare cipolle, quando Gaetano comparve sulla strada trascinandosi dietro il figlio, tenendolo stretto per la manica.
«Antò!» urlò.
Il fattore si girò e riconobbe quell’ottuso contadino che tanto detestava. Un imbroglione che, a suo parere, utilizzava una bilancia tarata male. Erano anni che non comprava più il grano da lui, dopo il loro ultimo litigio.
«Vieni, vieni a vedere!» gridava Gaetano.
Antonio iniziò a maledire sottovoce tutta la stirpe del contadino. Si diresse verso di lui, strascicando il piede, con inaudita pazienza, portandosi appresso anche la zappa come sostegno.
Nunzio era al pozzo. Trasportava l’acqua per riempire il trogolo nella stalla.
«Che fai ancora là? Vieni, Antò! Vieni» continuava a cantilenare quello, come per prenderlo in giro.
Ma Antonio si fermò, ne aveva abbastanza di camminare e sorbirsi quell’insopportabile litania. Aspettò che il contadino e il figlio Daniele gli venissero incontro.
«Guarda, guarda che ha fatto quel delinquente di tuo figlio. Quell’animale!» disse l’uomo fuori di sé.
Antonio studiò il volto tumefatto e macchiato di sangue del bambino. Con una pezza si tamponava l’occhio.
«Fagli vedere, Daniè».
Togliendo la pezza il bambino mostrò il sopracciglio spaccato e ancora sanguinante.
«Cieco me lo stava facendo diventare!» strillò Gaetano. «Dove sta quella carogna?! Oh, giuro che se non gliele dai di santa ragione qua, davanti a me, gliele do io al posto tuo!».
«Nunzio!» lo chiamò Antonio.
Il bambino fece piombare il secchio giù nel pozzo e si avviò meccanicamente dagli altri.
Ritrovandosi Nunzio a poca distanza da sé, il contadino si sentì prudere le mani. Avrebbe desiderato spezzargli un braccio come un rametto.
Torvo e insofferente, il fattore scandagliò il figlio e, dopo qualche attimo di silenzio, gli ordinò: «Chiedi scusa».
Nunzio non fiatò e quel suo atteggiamento reticente e ostile non fece altro che accrescere il risentimento di Gaetano.
«T’ho detto chiedi scusa!» tuonò Antonio.
Il bambino tremò ma fu sordo al monito del padre. Allora quello levò in alto il pugno, pronto a colpirlo sulla nuca. Avvertendo l’imminente pericolo, Nunzio si strinse nelle spalle e gridò: «Mi volevano rubare i soldi!».
«Bugiardo schifoso! Non è vero!» singhiozzò Daniele.
«Sì che è vero!» ribatté lui.
I due uomini si guardano negli occhi, perplessi. Antonio si scurì in volto e si rifugiò nei propri pensieri. Poi disse al figlio: «Vattene».
Nunzio non se lo fece ripetere.
«Andatevene pure voi» disse Antonio.
«Che? Ma che oltre a essere zoppo sei pure scemo?!».
Antonio restava muto.
«Lo poteva pure ammazzare!» aggiunse Gaetano per suscitare nell’altro una reazione contrita e ragionevole.
«Se l’è meritato. I soldi mi voleva fottere».
«A te non ti funziona più la testa! Non hai sentito che è una bugia? Io non me ne vado di qua se non meni tuo figlio davanti agli occhi miei».
«Non faccio proprio un cazzo».
«E allora ci penso io» disse Gaetano avanzando.
Ma Antonio gli sbarrò la strada.
«La vedi questa?» disse brandendo la zappa. «Se non te ne vai te la ficco in testa, a te e pure a tuo figlio».
L’uomo fu avvinto da una terribile soggezione. Negli occhi scuri e scellerati di Antonio lesse la tangibile volontà di ciò che aveva appena udito e che non agognava mettere alla prova. Prese il figlio, avvolgendogli le spalle, e batté in ritirata.
Nunzio osservò il padre rimettersi presto a zappare la terra di buona lena. A volte tentava di sondare i suoi pensieri, ma vanamente. Gli sembravano un garbuglio di sterpi e rovi capaci solo di pungere.
Antonio aveva già imprigionato il maialino legandogli le zampe. L’aveva sistemato su un tavolaccio, sul fianco, con la testa sporgente dal bordo. Sotto un secchio. Malgrado la bestia si dimenasse, grugnendo e strillando, riusciva a tenerla ferma con una sola delle sue enormi mani. Nell’altra impugnava il coltello. Nunzio poteva assistere senza batter ciglio all’uccisione di un pollo, ma vedere il padre scannare un maiale gli procurava puntualmente un’eccezionale dose di patimento e compassione che non era in grado di controllare e definire.
Antonio si raccomandò col figlio di tenere il secchio ben saldo per raccogliere tutto il sangue una volta sgozzata la bestia.
«Signor Antonio» disse una vocina alle loro spalle.
Il fattore si spazientì vedendo la nipote della maciara.
«Che vuoi tu?».
«Ti ho portato i secchi».
«Lasciali là a terra».
La piccola obbedì e rivolse un’occhiata fugace a Nunzio che però la scansò. Poi, inevitabilmente, gli strepiti e la disperata, quanto inutile, resistenza del maialino la sconcertarono fino a pietrificarla.
«Che c’è ancora?!» sbraitò Antonio. «Vattene, strega!».
Donatella fuggì a gambe levate.
«Scassacazzo» digrignò l’uomo seguendola nella sua corsa.
Sparita dalla sua vista, tornò a occuparsi del maiale. Con la lama gli sfiorò la gola ma a un tratto si fermò. Porgendo il manico al figlio, disse: «Piglia. Sennò non imparerai mai».
Nunzio fu come ipnotizzato dalla freddezza della lama. Restò con le braccia lungo i fianchi, i pugni stretti, e frastornato dai versi dell’animale.
«Piglia!».
«Io… no» farfugliò il bambino.
Antonio strabuzzò gli occhi e si accigliò. Picchiarlo fu il suo primo istinto, tuttavia prese a scrutarlo, con l’intento di scavargli dentro, di comprendere quale sentimento o pensiero avesse riscosso così tanta impertinenza.
«Che hai detto?» domandò cercando il suo sguardo.
Nunzio stava zitto, preoccupandosi per le conseguenze del proprio diniego e che reputava ormai irrimediabili.
Con impalcabile pervicacia, Antonio gli avvicinò ancora di più il manico e disse: «Muoviti, o facciamo subito i conti».
Qualche secondo dopo Nunzio afferrava il coltello e il padre il secchio. Vide una lacrima scivolare dall’occhio del maialino.
«Ammazzalo!» urlò Antonio.
Il bambino pose la mano sulla bestia, chiuse le palpebre e la sgozzò. Il grido che quella liberò gli perforò lo sterno. Affondare la lama nella carne gli stritolò lo stomaco. La sua mano percepiva ancora la lotta impulsiva dell’animale. Una fonte scarlatta gli apparve innanzi quando riaprì gli occhi. Il padre mescolava il sangue velocemente, servendosi di un mestolo. Il maialino continuava a dibattersi, urinando e defecando. Le forze lo abbandonavano goccia dopo goccia. Un ultimo spasmo e si acquietò per sempre. Nunzio si fece indietro, mollò il coltello. Aveva la mano schizzata di sangue.
Antonio attaccò il gancio alla corda che legava le zampe del maiale. Lo tirò su con uno strappo deciso. Gli squarciò il ventre per eviscerarlo e poi lo divise a metà. Per la pulizia e la macellazione fece da sé.
Arso dalla canicola, Nunzio andò a lavarsi e infine s’impalò al pozzo. Osservò Antonio sciacquare i coltelli, più tardi lo chiamò per pranzare. Si sforzò di mangiare almeno una pera, attese che il padre andasse a dormire e sgattaiolò via.
Parte terza
Un sibilo di vento fece stormire le fronde dalle quali si diffondevano sparuti cinguettii. Per il resto non si udivano altri richiami di animali, né altri rumori nel bosco. Nunzio constatò che lo stagno non era così freddo. Le alghe, sinuose, gli accarezzavano polpacci e caviglie. Poco distante, le libellule si libravano a scatti sullo specchio d’acqua. Cominciò a lavarsi, strofinandosi le gambe annerite.
Lo affliggeva il peso della colpa. Della morte. Non si era opposto fino in fondo al volere del padre, e pur di scamparsi l’ennesimo castigo, non aveva più esitato a recidere quella gola. Gli risuonavano i versi strazianti del maialino. L’aveva vista la sua lacrima, non era stata suggestione. La bestia, ragionava il bambino, aveva compreso di essere vicina alla fine. Aveva paura di morire. E allora si domandò se anche lui avrebbe riconosciuto il preciso momento della sua morte. Se avrebbe pianto, se si sarebbe dimenato come un ossesso. O se l’avrebbe accettata con imperturbabilità e rassegnazione, perché, riflettendoci su, non riteneva la propria vita degna di essere vissuta.
«Nunzio!» si sentì chiamare.
Gli si accapponò la pelle. Si voltò e vedendo Donatella si immerse fin sotto al mento. Per fortuna, pensò, l’aveva visto solo di spalle. O forse era lì già da tempo e l’aveva guardato mentre si spogliava, nascosta tra le frasche. Questo pensiero lo angosciò e lo fece vergognare seduta stante.
Controllando il terreno, la bambina si fece largo tra i cespugli e si fermò sulla riva. Si arrotolava l’orlo della gonnella. Poi, racimolato tutto il proprio coraggio, disse: «Posso… posso venire anch’io?».
Nunzio fu strabiliato e intimidito da quella richiesta. Si sentì raggelare addirittura il sangue. Nell’attesa di una risposta, Donatella smuoveva adagio la terra col piede, come se volesse scavare un solco. Nunzio annuì e il suo assenso gli parve immediatamente dopo inconsulto. Se ne pentì, ma era troppo tardi. Un sorriso illuminò la bocca carnosa della bambina. Donatella si sciolse la treccia, si tolse le scarpe, e quando cominciò a sfilarsi il vestito, Nunzio scostò lo sguardo, inabissandolo nello stagno. Udì il vestito frusciare sul suo corpo, lo sciabordio e un lamento, suppose dovuto al contatto con l’acqua. Poi la sentì ridere e sciaguattare, ma le onde prodotte da quel moto gli arrivano completamente fiacche. A quel punto Nunzio si arrischiò a guardarla. Donatella avanzava verso di lui saltellando e l’acqua le sfiorava l’ombelico. Qualche ciocca corvina le dondolava sul petto piatto ma appuntito. Nunzio sondò rapido l’acqua che gli rivelò solo le gambe fosche e ondose di Donatella.
Trovandosi a pochi centimetri l’uno dall’altra, Donatella sorridendo disse: «Ciao».
«Ciao» rispose lui, ricambiando il sorriso.
Si ammutolirono per un po’, finché Donatella emise uno strillo cercando qualcosa sul fondale.
«Sono i pesci» la tranquillizzò Nunzio. «Si mangiano la pelle morta dei piedi. Io gliela lascio mangiare, anche se fanno un pochino il solletico».
Donatella ci pensò e rise.
«Andiamo più in là?» gli propose lei.
«No, non mi va».
«Non sai nuotare?».
Nunzio scosse il capo.
«Ma è facile! Devi muovere le gambe e le braccia, come un cane. Così, guarda».
Gli mostrò come fare, spruzzando qua e là, e poi domandò: «E a galla, sai stare?».
«So fare solo il morto».
«Ma quello non ci vuole niente a farlo! Lo sanno fare tutti. Guarda».
Si mise supina, galleggiando sul pelo dell’acqua, e serrò gli occhi. Quelli di Nunzio caddero però sulla vulva liscia della bambina. Ne aveva solo sentito parlare, ascoltando talvolta i discorsi dei suoi compagni di classe che giuravano di averne perfino toccata una, ma prima di quell’istante non l’aveva mai vista e non era neppure mai riuscito ad immaginarsela. Quel taglietto gli sembrò così strano da indurgli sensazioni mai avvertite. Lo fissò, con quella veemente curiosità che poteva essere mossa solo da ciò che è nuovo e misterioso, fino a quando Donatella si ridestò. Lei si inabissò e riemergendo sputò l’acqua in faccia a Nunzio.
«Dai, vediamo se mi acchiappi! Tanto non mi pigli!» disse allontanandosi dove lo stagno diveniva più profondo.
Il bambino la inseguì, nuotando come le aveva visto fare qualche minuto prima. Donatella era molto più a suo agio nell’acqua rispetto a lui. Era agile e veloce. Ogni volta che Nunzio riusciva finalmente ad acciuffarla per un piede, lei gli sgusciava via, guizzando e ridendo, come una bella anguilla. A Nunzio piaceva toccare quella pelle liscia, quel corpo che, sfuggendogli sempre dalle mani, rinnovava il suo caparbio desiderio di ghermirlo a sé.
Si rese conto che stava nuotando nell’acqua alta. Si fermò ansimante, un po’ spaventato, e prese a muovere braccia e gambe disegnando larghe circonferenze. Donatella lo raggiunse.
«È facile. Te l’avevo detto, io» disse sorniona.
Le loro mani si sfiorarono inavvertitamente.
Si avvicinarono verso la riva, dove continuarono a giocare, schizzandosi e tentando di sopraffarsi l’un l’altra.
Se ne stavano seduti in prossimità della riva. Non temevano più di spiarsi, ma conservavano ancora un pudore per non ferirsi a vicenda. Anche Donatella non aveva mai visto un maschio nudo, ma del corpo di Nunzio fu pure attratta e impressionata dalla quantità di ematomi, graffi e cicatrici che lo solcavano. Non domandò nulla, tacque. Gli si accoccolò vicino, posandogli il capo umido sulla spalla. Nunzio si rinfrescò grazie a quel contatto, ma dentro di sé avvertì un immediato calore che nonostante tutto non seppe contraccambiare.
«Ero io ieri, scusami se t’ho spaventato» disse la bambina.
Nunzio capì a cosa alludeva ma non replicò.
Contemplavano lo stagno, talmente lento e muto da apparire a mala pena vivo. Un’idea affiorò dall’animo del bambino. Oscenità e spietatezza sconvolsero all’improvviso la sua fantasia. Senza scostare lo sguardo dallo stagno, chiese a Donatella: «È vero che tua nonna fa anche le magie cattive?».
«Sì».
«E non hai paura di lei?».
Donatella fece di sì con la testa, si raddrizzò e disse: «Tu lo sai che c’è dopo il bosco?».
«Altri paesi… e le città, che poi sono come paesi più grandi».
«Ci sei mai stato in una città?».
«No».
Il silenzio li incupì per diversi attimi, dopo Donatella disse: «Me ne voglio andare di qua».
«Pure io».
Donatella gli baciò il braccio. Nunzio fissò quella minuscola bocca turgida, la tastò e l’accarezzò col pollice, infine la baciò. Sorrisero. Poi, con un movimento brusco e repentino, Donatella buttò Nunzio schiena a terra e gli salì addosso bloccandogli i polsi. Lui fu inizialmente sorpreso e sussultò avvertendo il sesso di lei premergli sull’inguine. Le ciocche di Donatella gli ricadevano sul viso. S’incantò dinnanzi allo scintillio del suo azzurro dolce e scarnificante. Rise e si lasciò domare. La bambina allora lo baciò con ancora più impeto. Lei si adagiò sul suo corpo, strusciandosi appena. Si legarono e restarono l’uno nelle braccia dell’altra. Seppur con un magro boccone, le loro giovanissime labbra avevano conosciuto il sapore della carne. Le loro anime invece custodivano già un segreto di cui loro stessi erano inconsapevoli.
Si rivestirono e fecero ritorno alle rispettive case, con la promessa di rivedersi l’indomani dopo pranzo, sul sentiero.
«Ma tu ti pensi che qua non teniamo un cazzo da fare, eh?! Dove stavi?» gli urlò in faccia Antonio.
Il bambino abbassò la testa.
«E rispondi!».
«So’ andato alla gravina, a lavarmi nel torrente».
«A lavarsi è andato, il signorino… Vai, spicciati!».
Continuarono ad ammazzarsi di lavoro, senza sosta, terminando un’ora prima del tramonto.
Antonio si sciacquò il viso sospirando amaro, ma pensò che il giorno dopo si sarebbe riposato come meritava.
L’uomo ruminava famelico. Sul tavolo c’erano pane, salame, formaggio e due pere. Aveva tagliato al figlio una sola fetta di pane: doveva farsela bastare. Ma Nunzio, così come a pranzo, non aveva appetito. Mangiò soltanto quella. Memore del digiuno impostogli la sera precedente, Antonio se ne sorprese, tuttavia non lo esortò a prendere altro, tant’è che sbucciò e divorò anche la pera che gli aveva destinato. Pensò che fosse un ingrato, un moccioso che aveva l’impudenza di sputare nel piatto in cui mangiava, che disprezzava la sua immane fatica e il tetto che gli parava la testa. Avrebbe voluto buttarlo fuori a pedate e lasciarlo dormire all’aperto come un cane, o nella stalla, meglio ancora nel porcile, in mezzo alla merda e alle mosche. Forse così avrebbe capito, l’avrebbe ringraziato ogni giorno, commosso, baciandogli le mani callose.
Gli comandò di riempire la brocca, ma quando tornò a tavola pretese che gli portasse l’intera damigiana. Per fortuna del piccolo non era troppo pesante: poté sollevarla e adagiarla per terra accanto al padre.
Antonio beveva turbato dalle proprie riflessioni, da ricordi ormai polverizzati. Non si faceva sfuggire neppure mezza parola. Solo sbuffi e borbottii incomprensibili sibilavano di tanto in tanto dalla sua stretta bocca. Si accese una sigaretta e il fumo che l’avviluppò lo fece apparire al figlio ancora più plumbeo e impenetrabile. Pungolato da una sempre vigile sensazione, Antonio intercettò lo sguardo obliquo di Nunzio. Quello, unito al suo silenzio, lo irritarono. Con un cenno gli ordinò di sparire. Udì i passetti del bambino salire su per le scale e continuò a fumare e a bere fino a stordirsi, appisolandosi a tavola, accasciato sulla sedia.
Il russare del padre non rasserenò del tutto Nunzio che se ne stava sdraiato sul letto. Si toccò la mano: era ormai sgonfia. Non riusciva a prendere sonno, pensava a Donatella, alla sua bocca, al suo corpo nudo e ai suoi occhi penetranti che sembravano indovinare le angosce che l’affliggevano. Andò alla finestra di soppiatto. Nel buio galleggiavano i versi dei grilli e dei rapaci. Nunzio lo scandagliò in direzione del sentiero, con la mente sorvolò la casa della maciara e immaginò Donatella respirare profondamente sul suo guanciale. Tornò a letto, si addormentò, ma a notte fonda fu svegliato da un violento trambusto.
Non ebbe alcun dubbio che il padre stesse salendo la rampa col suo lungo e lento serpeggiare. Lo sentì imprecare per essere inciampato e poi rialzarsi. Nunzio se lo figurava come una belva che smuoveva l’oscurità con la sua ingombrante stazza. Gli tremavano i polsi. Balzò giù dal letto, spinse la cassapanca davanti alla porta e si allontanò sperando che quella barricata di fortuna l’avrebbe protetto.
Antonio provò ad entrare senza riuscirci e a quel punto iniziò a battere i pugni sulla porta.
«Apri ‘sta cazzo di porta o t’ammazzo!» gridò.
Antonio tentava di sfondarla e buttarla giù a spallate. Ringhi e bestemmie accompagnavano o si alternavano ai colpi.
Nunzio stava fermo. Per un attimo pensò di gettarsi dalla finestra per fuggire, ma sarebbe senz’altro precipitato al suolo spaccandosi una gamba. Poi, nella semioscurità, intravide la porta vacillare e spostare di pochi centimetri la cassapanca che strideva sulle assi. Indietreggiò ancora di più, immobilizzandosi al centro della stanza. Due potenti spallate consentirono ad Antonio di aprirsi uno spiraglio. Si aiutò con le mani per allargarlo, lanciando versi simili a ruggiti. S’infilò e fu dentro.
Un manrovescio scaraventò Nunzio per terra. Antonio si slacciò la cintura e la fibbia risuonò come un sonaglio. Raccolse il figlio dal pavimento afferrandolo per i capelli e lo buttò sul letto. Senza più alcuna capacità di discernimento e inebriato dalla tortuosità del vino, gli tirò su la canotta e lo prese a scudisciate. Non le contava, voleva solo sentire il figlio gridare, così inferiva sulla sua schiena, martoriandola, desiderando di squarciarla per annusare l’odore della carne viva. Il piccolo uggiolava ad ogni colpo, ma non cedeva, sopprimeva tutto. Sopportava le sferzate e il fuoco come fosse la sua unica ragione di vita. Poi il padre, trafelato e sempre più folle, scagliò lontano la cintura e lo denudò lacerandogli le mutande. Si strattonava il pene forzandolo a raggiungere quanto prima l’erezione e quando ci riuscì non esitò un istante a penetrare il bambino. La ruvidezza dell’attrito bruciò Nunzio. Sentiva il ventre del padre premergli contro la schiena e il sedere. Inoltre quel miserabile giaciglio acuiva il suo supplizio: le foglie di granturco gli pungevano la faccia e l’addome. Il padre aumentò la velocità delle oscillazioni affondando il viso nella nuca del figlio, stringendogli il collo per imprimergli un marchio funesto. Si accaniva con efferatezza e con la volontà cristallina di annientare quell’essere. Nunzio respirava il suo alito ributtante che gli rivoltava lo stomaco. Detestava il sudore, il contatto di quella pelle viscida. Poi smise di provare dolore. Avvertiva solo il livore del padre trapassargli ogni fibra del corpo. Ma il suo spirito, quello non l’avrebbe toccato. Glielo impedì. Si sentì incendiare da un odio orribile che però non poteva restituirgli. E allora supplicò la morte di uccidergli il padre. Lo fece con un patimento e una devozione che gli strapparono le viscere, ma le sue preghiere non vennero esaudite. Chiuse gli occhi, trattenne il respiro, si tuffò in fondo al pozzo e attese che il padre lo umiliasse definitivamente stillandogli dentro il suo seme.
La belva ridiscese negli inferi. La creatura restò sola. Tremando si toccò l’ano e sentì il sangue.
L’unisona e monotona preghiera dei fedeli echeggiava in ogni angolo della chiesa che era fredda e odorava d’incenso. Le vecchie, mosse da sincera e dolente partecipazione, dondolavano lievemente il capo coperto dal fazzoletto. I bambini invece faticavano a pronunciare le parole latine, o più spesso le avevano già dimenticate. I giovani tentavano di sfiorare lo sguardo delle loro amate che sentendosi chiamate li ricambiavano seppure per un solo momento. Uomini, donne, tutti assorti al contempo in fantasie e pensieri disdicevoli e di cui speravano che Dio, il solo in grado di sondarli, li avrebbe infine perdonati. Nella casa del Signore, proprio lì i fedeli cominciavano a peccare, perché uno sguardo era più che sufficiente ad appiccare il fuoco della lussuria, alimentare un insopprimibile risentimento o a far beccare col rostro dell’invidia.
Gli occhi di Nunzio vagavano sul banco, sugli affreschi che ornavano il soffitto e una parte dell’abside, ma mai osavano soffermarsi sulla sagoma del padre che gli si stagliava imperiosa accanto.
Le voci dei fedeli si estinsero in un silenzio solenne e spigoloso. Don Michele allora riprese la parola e proseguì la funzione.
Nunzio non poté prendere la comunione, conscio che la sua anima era macchiata dal peccato. Il parroco gli mandò un’occhiata severa, mentre imboccava il corpo di Cristo agli altri.
Al termine della messa Nunzio si andò a confessare.
«Ho saputo quello che hai fatto a Daniele. Devo dirti che sono sorpreso e pure arrabbiato, da te proprio non me l’aspettavo. Gli hai fatto molto male. Te ne sei reso conto?» disse don Michele.
«Sì» rispose Nunzio.
Teneva la testa bassa, le dita intrecciate e gli doleva stare inginocchiato.
«Nostro Signore dice: ama il prossimo tuo. Soprattutto il tuo nemico. Alzare le mani non serve a niente, avresti dovuto chiedere aiuto a un adulto, a tuo padre, per esempio. Promettimi che non ti azzufferai mai più con nessuno. Io lo so che sei un bravo bambino. Quando vedrai di nuovo Daniele gli chiederai scusa e diventerete amici. Me lo prometti?».
«Sì».
«Bene. Quali altri peccati hai commesso?».
«Ho rubato le sigarette a mio padre».
«Va’ avanti».
«E poi…».
Ma il bambino si bloccò. Masticò e deglutì, e restò zitto.
Il prete ruppe il silenzio sussurrando: «Di’, coraggio».
Non ebbe alcuna risposta, così si voltò e attraverso la grata fissò la testa di Nunzio.
«Hai avuto pensieri impuri?» domandò.
«No».
«Sei sicuro?».
«Sì».
«Tuo padre non ti ha portato al cinema ieri sera, vero?».
«No».
«Ma hai visto l’attrice sul manifesto?».
«Sì».
«E cosa hai pensato?».
«Niente».
«Nunzio…» disse addolcendo il proprio timbro.
«Che era bella» ammise imbarazzato.
Don Michele rifletté per qualche secondo, sospirò e disse: «Vedi, figlio mio, il Diavolo assume tante forme, perfino quella di una donna, che è creatura di Dio. Cerca di tentare l’uomo in tutti i modi. Quella però non è una donna bella, e non è neppure buona. E sai perché? Perché è priva dell’amore di Dio. L’ha rifiutato e calpestato. La Beata Vergine, lei vive nella grazia del Signore. Di lei devono nutrirsi i tuoi occhi e il tuo cuore. Pensa solo a Maria, la madre di nostro Signore, a quanto è bella e pura. Lei ti ama e ti protegge… C’è altro?».
Il piccolo non rispose.
«C’è altro, Nunzio?» lo esortò il parroco.
Lui si stritolò le dita. Sotto i polpastrelli sentiva le nocche e si guardava le unghie sporche di terra, e sangue. Poi disse: «Ho pensato una cosa brutta su mio padre».
«Cosa?».
Ma ancora non si decideva. Voleva alzarsi e andare via, ma non poteva.
«Coraggio, figlio mio. Dio ti perdonerà».
«Volevo che… che mio padre doveva morire».
Un moto di sdegno e commozione investì il prete, che rivolse un subitaneo pensiero a Dio. Gli domandò come fosse possibile che l’anima di un bambino anelasse una tale atrocità. Gli chiese anche la forza per trovare le parole giuste atte ad ammonirla e salvarla. In cuor suo sperava che il desiderio di Nunzio fosse solo un’ingenuità, priva di alcuna reale intenzione o sentimento, un capriccio dettato da futili ragioni di cui il piccolo stesso non si capacitava.
Riemerso dalla propria meditazione, disse: «Questo è un peccato mostruoso. Non fare mai più un pensiero così orribile. Cosa dice il quarto comandamento?».
«Onora il padre e la madre».
«Bene. Tu non hai più una madre, Nunzio. Ti resta solo tuo padre. È lui che ti protegge e ti dà tutto. Cosa faresti se non ci fosse più, se fosse morto come hai desiderato? Chi ti darebbe il pane? Chi ti vestirebbe? Chi ti amerebbe? Tutto ciò che fa tuo padre è per il tuo bene, perfino quando ti mette in castigo, o ti dà uno scappellotto. Non farlo arrabbiare, fa’ sempre quello che ti dice e non dubitare mai del suo amore. Ti vuole bene e tu devi volergli bene. Non ha nessuno oltre a te. Tu sei la cosa che gli è più cara al mondo, tienilo sempre a mente. E prega che tuo padre viva più a lungo possibile, invece. D’accordo?».
«Sì».
«Bravo».
Gli disse di recitare l’Atto di dolore, Nunzio obbedì e il prete lo assolse dai suoi peccati.
Uscito dalla chiesa Nunzio vide Donatella, addossata al muro di un palazzo. Non frequentava la parrocchia, sua nonna le aveva da sempre proibito di entrarci e di dare confidenza al prete e a tutte quelle altre vecchie bizzoche che le avrebbero messo in testa solo cattive idee. I due si scambiarono uno sguardo, Antonio se ne accorse e chiamò il figlio a gran voce che lo raggiunse lentamente.
«Che va cercando quella da te?» chiese Antonio. «Non ci devi andare appresso a quella là. M’hai capito?».
Fissava il figlio, attendendo una risposta.
«Oh, m’hai capito?!» disse scuotendolo per un braccio.
«Sì».
Se ne tornarono dritti a casa.
Tramortito dal pranzo e dal vino, Antonio si addormentò. Nunzio era già sul sentiero arroventato dal sole. Donatella non tardò ad arrivare, si sorrisero e insieme s’inoltrarono nel bosco.
Parte quarta
Le gambe li condussero inconsciamente allo stagno. Nunzio però si rifiutò di fare il bagno, non voleva mostrarsi a Donatella e lei non insistette. Rimase sdraiata sull’erba, vicino a lui, con l’eccitazione trattenuta di toccarlo. Ogni tanto gli strofinava il viso sul braccio o sulla spalla, come una gatta, ma lui pareva insensibile e assente. Quell’atteggiamento un po’ la feriva, eppure non lo biasimava: presentiva il suo malessere. Ma Donatella era ostinata. Strappò un lungo filo d’erba e con quello solleticò l’incavo del ginocchio di Nunzio. Il bambino ritrasse subito la gamba ridendo e lei colse l’attimo per rubargli un bacio. Lui si sentì trafitto e violato nell’intimo dalla tenerezza del suo azzurro. L’accarezzò e poi nascose lo sguardo, rintanandosi ancora una volta nell’intrico dei propri pensieri.
Restarono sommersi nel quieto brusio del bosco, finché Nunzio, mirando in direzione dello stagno, disse: «Voglio andare da tua nonna. Devo parlare con lei».
Così dicendo, calamitò gli occhi spalancati della bambina. Gli pareva che vacillassero per un terrore che già viveva in lei e che temeva di aver risvegliato angosciandola all’improvviso. Dalla bocca socchiusa di Donatella gli giunse al naso un flebile ma caldo respiro. Gli occhi della bambina si sgonfiarono rimodellandosi nel loro taglio naturale. Poi si alzò in piedi, si pulì il vestito dall’erba e dalla terra e gli disse: «Andiamo».
Nunzio si asciugò la fronte madida di sudore. Erano entrambi spossati per via della calura e della salita. Quando videro affiorare la casa rallentarono e si fecero avvolgere nel lungo manto d’ombra steso dagli alberi. Non era però la vista di quella mesta dimora a opprimere Nunzio, ma piuttosto l’idea, sempre più ossessiva, di ritrovarsi al cospetto della maciara per la prima volta in vita sua. Tutte le storie che aveva ascoltato su di lei si affastellarono suggestionando la sua mente già atterrita. Il bambino dubitava della propria decisione, la casa però sembrava averlo avvinghiato a sé con uno stretto laccio invisibile per attirarlo inesorabilmente al suo interno.
«La vedi quella?» disse Donatella indicando una finestra in basso a sinistra. «È la mia stanza».
Nunzio la contemplò senza dir nulla o cavare un pensiero definito a riguardo.
Arrivati alla porta, Donatella bussò. Dopo diversi istanti di silenzio, dal fondo della casa strisciarono passi lenti mischiati a un rantolo, o forse più un borbottio, che si faceva via via sempre più roco.
La maciara aprì. Squadrò prima la nipote, con la consueta stizza, e poi Nunzio, lasciando trapelare dagli occhi acuminati e dalle rughe, che le graffiavano i lati della bocca ghignante, tutto il suo divertito stupore.
«Ah, guarda guarda» gracchiò. «Il figlio dello zoppo. Che onore!».
I bambini non si azzardarono a parlare. Nunzio guardò di sfuggita le gambe varicose della vecchia che spuntavano da sotto una gonna nera.
«Che sei venuto a fare qua? A batter cassa?» domandò la donna incollando ora su di Nunzio uno sguardo accusatorio.
Ma lui avvertiva la lingua come intorpidita.
«Tornatene da dove sei venuto e di’ a quel caprone di tuo padre che ha fatto male i conti, non ho debiti con lui» sentenziò la maciara.
«Ti deve dire una cosa».
«Zitta tu!».
I piccoli sobbalzarono. Donatella sapeva di essersi spinta troppo oltre, la sua era stata una leggerezza incoraggiata dall’impulsività. Si ripromise di non fiatare più, a meno che la nonna non si fosse rivolta direttamente a lei.
«E sentiamo, allora. Che hai dire?» disse tornando sul bambino.
Niente però riusciva a smuoverlo. Teneva solo gli occhi puntati sul grembo nero e flaccido della donna.
«Ce l’hai la lingua, sì o no?» ridacchiò quella.
«Devo… volevo chiedere una cosa» disse finalmente Nunzio.
La maciara attese un po’, sovrappensiero e sospettosa, ma alla fine spalancò l’uscio per invitarlo ad entrare e lui si fece avanti, seguito da Donatella.
Nunzio scrutò i capelli argentei e radi della vecchia e inalò come un tanfo di verdura cotta che lo nauseò. L’ingresso era vuoto e sul perimetro c’erano solo porte chiuse.
«Vieni» disse la donna avviandosi.
Poi però si arrestò improvvisamente e voltandosi verso la nipote le ordinò: «Tu resta qua. E non origliare com’al solito tuo. Anzi, vattene in camera tua. Fila!».
Solo quando vide Donatella chiudersi nella propria stanza, esortò Nunzio con un cenno del capo a seguirlo in cucina.
Varcando la soglia si sbalordì nel trovarla in ordine. Aveva immaginato la casa della maciara sporca e caotica, e con i topi a scorrazzarci dentro.
Lei si sedette al tavolo e con la mano spronò Nunzio ad imitarla senza esitare troppo. Solo allora il bambino capì che a diffondere quell’odore stomachevole era la vecchia stessa.
«Be’, di’ quello che mi devi dire, ma fai in fretta».
Nunzio inspirò l’alito aspro della vecchia, fissò le sue lunghe dita nodose e disse: «Voglio che fai una magia».
«Una magia?» ripeté quella.
«Sì, una cattiva» disse Nunzio intimorito dalle sue stesse parole. La donna allargò il ghigno e chiese: «E a chi?».
«A mio padre».
«Ah».
Malgrado lo sguardo basso di Nunzio, la maciara aveva percepito nelle sue parole un’impensabile risolutezza. Si frugò in tasca per prendere una sigaretta che accese e aspirò con somma soddisfazione. Quella faccenda si stava srotolando in una trama che infiammava in lei una malsana curiosità. Le pareva un gioco spassoso, al quale per il momento le andava di partecipare e assecondare.
«E dimmi un po’, che cosa gli vuoi fare?» domandò ciccando la sigaretta nel posacenere.
«Non lo so» disse lui.
Nunzio si infilò le mani sotto le cosce pizzicandosele appena. Poi, riflettendo e senza staccare gli occhi dal tavolo, disse solo: «Male».
La vecchia gli sorrise mostrando stavolta i denti gialli. Il canino destro superiore sporgeva rispetto a tutti gli altri rimasti.
«E quanto?» gli chiese.
«Assai».
La vecchia tirò una boccata e assunse un’aria seria e meditabonda. Decise di vangare ancora più in profondità l’anima del piccolo e scoprire quanto potesse essere oscura e maligna.
«Ma allora perché non ti sbarazzi di lui, per sempre?».
Il bambino sussultò. Si sentiva le fauci aride e il respiro pesante. Fissò il fumo sfilacciarsi dalla sigaretta e poi di nuovo il tavolo.
«Vuoi ammazzarlo?» gli domandò la donna.
Gli si gelarono le viscere e si pizzicò ancora più forte.
«Vuoi ammazzarlo?» ripeté quella.
Nunzio sollevò lo sguardo con la volontà di incrociarlo con quello sfingeo e perverso della vecchia. In un istante terribile e inequivocabile ebbe l’assoluta convinzione che quella dinnanzi a sé non poteva che essere la morte, pronta a esaudire il suo desiderio.
«Sì» disse.
La donna approvò con la testa ed emise un breve mugolio di piacere. Spense la sigaretta e sventolò il fumo per diradarlo.
«Bene bene. E come pensi di pagarmi?» disse poi scoppiando in una perfida risata e tossendo.
Nunzio inorridì vedendo quella testa oscillare e rovesciarsi all’indietro. Capì di essere stato uno sciocco, che la vecchia lo stava solo canzonando. Si sentì umiliato, gli venne voglia di piangere, però si trattenne.
Scattò in piedi per andare via prima che glielo ordinasse la maciara, ma non appena lo fece lei strangolò la propria risata.
«Siediti» gli disse.
Lui tremava, le fissava ora gli occhi ora la peluria al di sopra del labbro.
«Ho detto siediti!» gridò la vecchia.
Nunzio obbedì e un ghigno simile a una cicatrice s’incise sulla bocca di lei. La donna si alzò lamentandosi, andò alla credenza, strappò un pezzo di carta da un quadernetto, poi prese un barattolo. Lo aprì e versò della polvere nera sulla carta che chiuse subito dopo a mo’ di busta da lettera. Si riaccomodò e facendola strisciare sul tavolo l’avvicinò al bambino, che fu più che altro stregato e inquietato dalle sue dita ossute.
«Scioglila in un liquido e faglielo bere» disse la vecchia. «Dormirà così tanto che non sentirà manco le cannonate. Deciderai tu che cosa fargli».
Si accese un’altra sigaretta.
Nunzio prese la bustina e la conservò in tasca. Con un gesto perentorio la maciara lo invitò a sparire. Quando fu sola venne colta da una visione: sangue, che scorreva scuro e bollente come una sorgente infernale. Aspirò il fumo e lo sbuffò sorridendo.
Nunzio posò lo sguardo sulla porta della stanza di Donatella e uscì dalla casa. Procedeva svelto, tenendosi stretta in tasca la bustina. A un tratto si fermò girandosi indietro: alla finestra c’era Donatella. S’incamminò e quando tornò a casa scovò il padre nel capanno a riparare una cassetta sfondata. Si accovacciò sotto il pero e lì restò a riflettere e ad avere paura finché non giunse la sera.
Nunzio masticava ingoiando i bocconi come fossero pietre. Antonio invece triturava il cibo con l’abituale voracità. Briciole e residui di formaggio gli restavano intrappolati nei baffi, gli ricadevano sul petto, ma lui non si curava di pulirsi o assumere un contegno più dignitoso. A Nunzio non sembrava neppure che il padre traesse godimento dal cibo. Credeva che ingurgitarlo fosse per lui solo un bisogno corporeo da soddisfare fino a quando il suo stomaco non fosse diventato teso come un pallone.
Antonio tracannava il vino, a volte scolandoselo un po’ addosso e asciugandosi la bocca col dorso della mano o con l’irsuto avambraccio. Di tanto in tanto gettava un’occhiata al figlio, innervosendosi per il suo lento e a suo parere sofisticato modo di mangiare. Voleva soltanto ubriacarsi. Bere, e di questo ne era fermamente persuaso, l’aiutava a tenere a freno la rabbia, a non mollare al bambino un ceffone, o urlargli di non mangiare come una femmina, o un topo da schiacciare sotto i piedi.
Terminata la brocca, l’avvicinò al figlio senza né guardarlo né dire nulla. Nunzio si soffermò istantaneamente sul bordo sbeccato della stessa. L’afferrò e si alzò da tavola.
La riempì per metà, poi prese la polvere, d’istinto se la portò al naso ma ebbe la netta impressione che fosse inodore. La svuotò nella brocca che agitò velocemente e riempì con altro vino.
Quando il padre si portò il bicchiere alle labbra Nunzio trattenne il fiato. Riprese a respirare solo nel momento in cui vuotandolo del tutto lo sbatté sul tavolo. Nunzio si raccolse nei pensieri, dissimulando i propri turbamenti. E attese, con scrupolosa e incrollabile pazienza.
All’improvviso Antonio si sentì sovrastato da una poderosa stanchezza. Avvertiva più caldo strofinandosi la nuca gocciolante. Un formicolio gli si insidiò nei piedi. Li batté sul pavimento per far sì che il sangue ritornasse a circolare con regolarità, ma fu inutile. A poco a poco gli si appannò la vista e cominciò a lottare per tenere le palpebre spalancate. Si stropicciò la faccia e diede la colpa di quei sintomi al vino e alla fatica accumulata nei giorni precedenti. Anche il bisogno di più aria lo colse senza preavviso. Prese a boccheggiare, a riempirsi d’aria che però gli pareva insufficiente e sempre più afosa. Bevve altro vino, pensando senza una valida ragione che gli avrebbe procurato un tempestivo sollievo. In quella lieve foschia emersero i contorni sbiaditi del figlio. Strizzò gli occhi per metterlo a fuoco, poi schiarì la gola e biascicò: «Vattene».
Afferrò il bicchiere avvertendo ora il formicolio anche nella mano e le forze venirgli meno. Sgranò di nuovo lo sguardo e intravide ancora il bambino. Allora la collera s’impadronì di lui.
«Vattene a fare in culo!» gridò tirandogli addosso il bicchiere.
Il vetro scoppiò sul pavimento e quella sagoma si dileguò in un lampo scalpicciando poi su per le scale. Antonio si asciugò sul pantalone la mano bagnata di vino, bestemmiando per averlo versato e infine bevve direttamente dalla brocca.
Rimase a tavola, ingarbugliato fra odiosi pensieri sconnessi, percependo inoltre quelle strane sensazioni divenire sempre più acute e invasive. Dopo, sollecitato da un ultimo barlume di lucidità, raccolse le proprie energie e si sollevò. Claudicando pericolosamente, si trascinò fin dentro la penombra della propria stanza e riconoscendo col ginocchio lo spigolo del letto si lasciò crollare su di esso, ormai privo di ogni forza. Il sonno lo tramortì in pochissimi secondi.
Nunzio aveva aspettato seduto sul letto, macchiato di vino e con le budella attorcigliate. Per tutto quel tempo si era ripetuto che poteva e doveva farlo. Non voleva più annegare in fondo al pozzo ogni notte, risorgere al mattino e ripercorrere quel cerchio di sofferenza per tutta la vita. La morte gli aveva donato per una sola notte il suo potere, non ci sarebbe stata mai più altra occasione.
Si alzò, uscì da quel suo tugurio, con il sentore di abbandonare proprio là dentro tutto il suo dolore, e scese adagio la rampa.
In cucina fu investito dall’odore del vino. Per terra luccicavano i frammenti del bicchiere. La porta della stanza del padre era aperta, immersa nell’oscurità. Da lì giungeva il suo profondo russare, a tratti congestionato e che metteva il bambino in una trepidante allerta.
Andò al mobile e aprì il cassetto. Sotto il mestolo e il forchettone trovò il lungo coltello col quale il padre l’aveva costretto a scannare il maialino. Lo prese e per un breve attimo si specchiò nella lama. Ma in quella i suoi occhi erano sfocati e indistinguibili. Non poté riconoscersi, così dimenticò se stesso e si avviò nella camera, varcando la soglia in silenzio, evanescente ma fermo nel cuore come un angelo della morte.
Le tenebre concessero alla luna di illuminare con un tiepido fascio solo un angolo della stanza. La belva dormiva supina e il suo grasso ventre seguiva il ritmo compassato dei respiri. Quando Nunzio fu al lato del letto, vide il capo del padre appena inclinato indietro: gli stava offrendo la gola. Come il maialino, pensò. L’avrebbe ammazzato così. L’aveva già fatto, gliel’aveva insegnato proprio lui. Allora quel sentimento feroce, provato la notte precedente, si risvegliò di soprassalto. L’odio che gli scorreva nel sangue lo fece sentire vivo come non mai.
Afferrò l’uomo per i capelli, strattonandolo e inclinandogli la testa ancora di più, e quello non si riscosse minimamente. Pose il coltello sulla gola, ma anziché squarciarla si arrestò. Sotto la lama la sentiva sgonfiarsi e rigonfiarsi. Gli tremava il polso. Strinse il manico per ritrovare la propria spietatezza e provò ad affondare la lama, poi però sollevò il coltello e indietreggiò. Non la luna ma l’oscurità vide una lacrima bagnargli il viso. Nunzio cominciò a singhiozzare rivolgendo la lama verso di sé, deciso a conficcarsela nella pancia. Restò paralizzato, tremando e piangendo in silenzio per diversi e lunghi attimi. Poi lasciò cadere il coltello e scappò via.
Buio pesto. I suoi passi scricchiolavano rapidi sullo sterrato coprendo il frinire dei grilli. Aveva il fiato mozzato e le gambe in fiamme. Tutto il suo corpo gli pareva un’enorme ferita sanguinante. Calcolava la distanza dalla sua meta provando a valutare la pendenza del pendio. Sapeva però che doveva sbrigarsi, che il tempo era esaurito, e che la morte ora gli era alle calcagna e fiutava la densa scia rossa che segnava il sentiero.
Il terreno si fece improvvisamente pianeggiante, capì allora di essere giunto a destinazione. Fu la luna a mostrargli la casa della maciara. La disperazione l’aiutò a compiere l’ultimo sforzo. Rifiatò una volta alla finestra, ma non riusciva a ragionare. Bussò temendo di frantumarla o destare la vecchia dal suo sonno. Poco dopo la smilza figura di Donatella gli fu innanzi. Lei aprì la finestra ma restò muta. Lui vide rifulgere nei suoi occhi un intenso baluginio blu, lei invece intuì tutto l’orrore e la concitazione che l’animavano accogliendoli dentro di sé. La bambina svanì dalla vista di Nunzio solo un istante per infilarsi le scarpe, poi saltò giù dalla finestra. Nunzio le afferrò la mano e insieme corsero verso il bosco lasciandosi inghiottire. Si orientavano nelle tenebre con lo stesso istinto delle bestie notturne.
In quell’indefinibile euforia Nunzio disse a stesso che se avesse continuato a tenere stretta la mano di Donatella il male non l’avrebbe neppure sfiorato. Poi ebbe la certezza di essere sfuggito alla morte. Correvano e respiravano la notte, col cuore che faceva vibrare loro carne e ossa, con quel segreto che custodivano nell’anima.
Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?

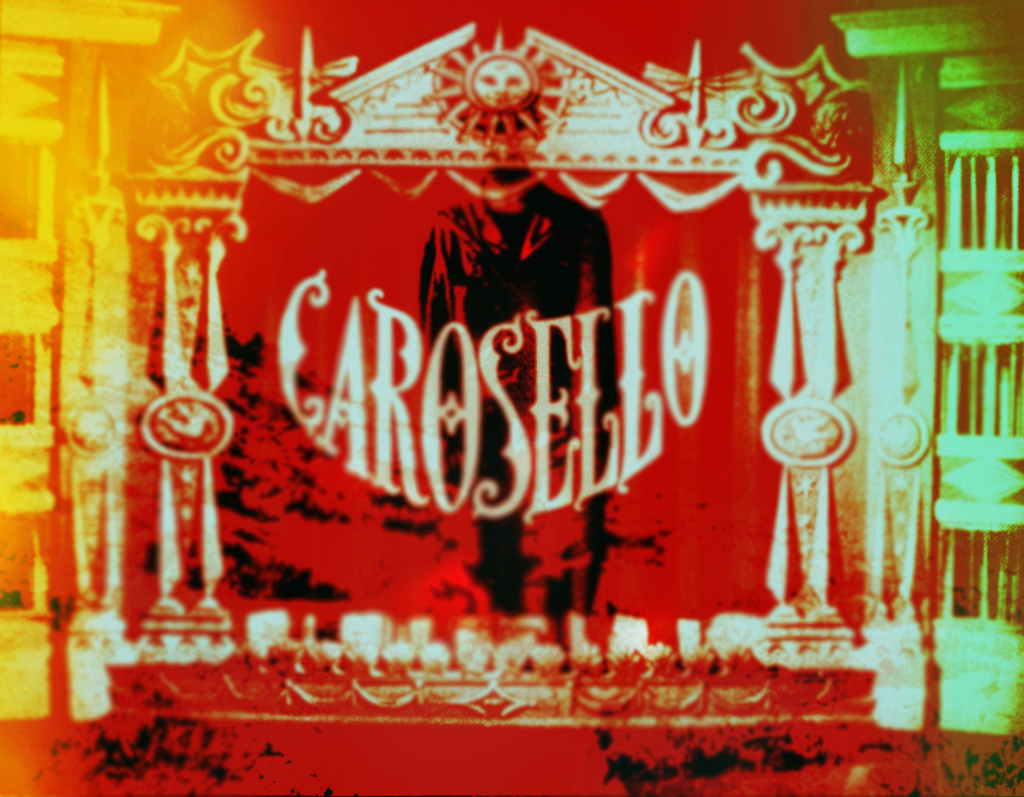
Racconto forse un po’ troppo a tratti troppo descrittivo, ma avvincente, mi è piaciuto tantissimo e non vedo l’ora di leggere la continuazione
Bellissimo racconto! triste rassegnazione ad un padre padrone orco. Mi é sembrato di vedere le immagini di un film del dopoguerra e sentirne quasi gli odori. Complimenti all’autore é stato anche un bravo regista
..povero Nunzio..
..storia emotivamente forte e realistica..
Bella la copertina e complimenti alla redazione.
L’autore è come al solito incisivo coinvolgente ed estremamente preciso nel dettaglio del racconto.. sembra di vedere un film..molto 👏
Coinvolgente, intenso, avvincente, ti fa amare la lettura..