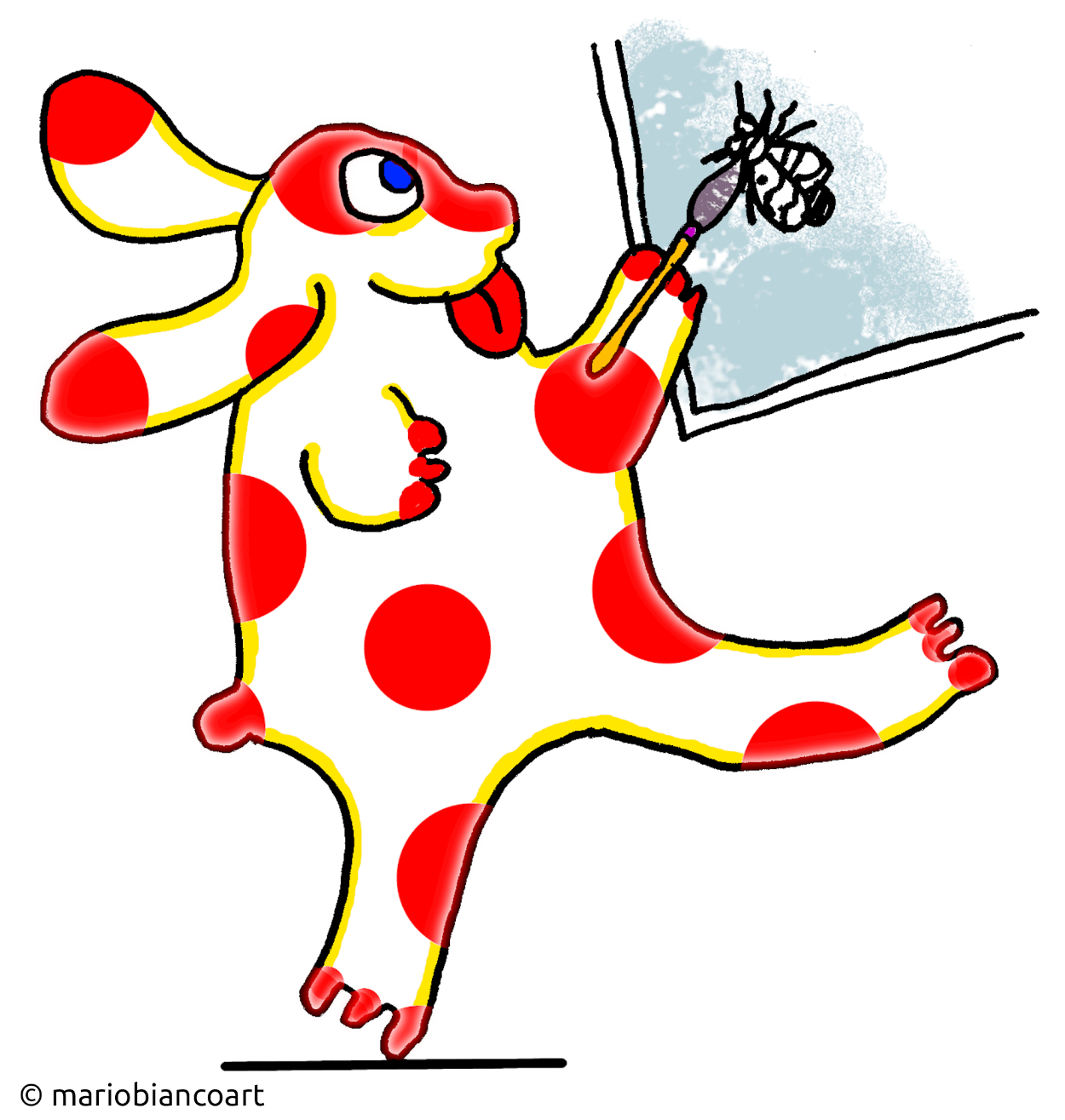di Lucia Zago
Copertina di Mario Bianco
Avevo rincorso le lucciole per tutta la sera, ne avevo catturate tre e le avevo chiuse in un barattolo di vetro. Le osservavo mentre cercavano con forsennata insistenza di volare in uno spazio così ristretto. Un refolo di vento mi fece alzare lo sguardo: il cielo era quasi nero, un nero opaco, inquinato dalle luci della periferia. Si vedevano poche stelle, ma la luna era lì, quasi rotonda.
«Che cos’è la luna, papà?»
Lui era seduto accanto a me, in silenzio, come sua abitudine. E immobile. I suoi occhi erano pieni delle cose del giorno e la sera si chiudevano per la stanchezza, senza lasciare passare nemmeno un po’ di luce. Alla mia domanda si mosse con calma, continuando il suo pensiero come se stesse cercando la risposta già da prima.
«È come una palla, solo che è in cielo.»
«Una palla? E chi l’ha messa lassù?»
«Non lo so.»
«Ma qualcuno ci gioca?»
«Forse… ma forse, invece, è un satellite.»
«Che cos’è un satellite?»
«Non lo so», mi rispose, socchiudendo di nuovo gli occhi, «ho fatto solo la terza elementare.»
«Forse ne hanno parlato in quarta, quando tu non c’eri più. Non importa papà.»
Non ha aggiunto altro, ha solo allungato le gambe, distendendo il corpo come in un momento di resa. Io ho continuato a guardare la luna, che a sua volta mi guardava, con la sua espressione sorpresa e preoccupata.
«Dov’eri, papà, l’anno della quarta, quando a scuola hanno spiegato la luna?»
«Non me lo ricordo» ha detto in un sospiro.
Le lucciole si erano spente. Avevano svolazzato fino allo stremo in cerca di una via d’uscita. Due stavano sul fondo, quasi immobili, la terza camminava intorno al bordo. I fori che avevo chiesto a mia madre di fare sul tappo con l’apriscatole erano minuscoli, ma ero preoccupata lo stesso che potessero scappare. Mi sono girata verso di lui. A volte io gli ponevo una domanda e lui non rispondeva, oppure lo faceva quando stavo già pensando ad altro.
«Qualche volta aiutavo tuo nonno nei campi, ma quando non c’era niente da fare, andavo in giro. Andavo a mangiare l’uva nei filari vicini, raccoglievo i fichi maturi, mi nascondevo tra le vigne e saltavo i fossi per andare ancora più lontano.»
«Ma è pericoloso, papà. E se cadevi?»
«Sono caduto tante volte, non è un problema cadere, ci si rialza. Solo una volta non ci sono riuscito. Quella volta mi ero fatto male sul serio, ma sono rimasto lì, senza piangere, fino a che qualcuno è venuto a cercarmi. Il mio amico, invece, era scappato a casa sua, per non essere picchiato da suo padre per il ritardo, ma quella volta se le era prese lo stesso, per la frutta non sua che nascondeva in tasca.»
«Quanto sei rimasto nel fosso, papà?»
«Non lo so, quando sono venuti a prendermi era già notte. Ho rischiato di morire, sai?»
«Davvero? E cosa hai fatto tutto quel tempo?»
«Ho guardato la luna che compariva e scompariva da dietro le nuvole e poi, forse, mi sono addormentato.»
«E poi?»
«E poi la luna non l’ho vista più, per tanto tempo.»
A tratti pareva dormisse: stava per ore ad ascoltare i rumori del buio, mentre io, alle dieci in punto, dovevo andare a letto.
La luna è distante dalla terra più o meno 384.400 chilometri.
L’astronave Apollo 11 ci ha messo tre giorni per arrivare sulla luna, per la precisione 73 ore; partita con una velocità di propulsione che è arrivata fino a circa 40.000 chilometri all’ora ha poi continuato il suo viaggio per forza d’inerzia fino a rallentare lentamente. A un certo punto, se avesse continuato a rallentare la forza di gravità della terra avrebbe potuto farla ricadere indietro, invece, prima che il suo moto si arrestasse del tutto e invertisse la direzione, l’astronave è stata presa in carico dalla forza di gravità della Luna che ha cominciato ad attrarla verso di sé. Questo passaggio è avvenuto dopo 300.000 chilometri dalla partenza.
Una persona a piedi, in media, cammina a una velocità di circa 5 chilometri orari. Per percorrere 384.400 chilometri ci impiegherebbe in totale 76.880 ore, che sono 3.203 giorni, quindi più di 8 anni e mezzo. Questo se camminasse 24 ore su 24. Se camminasse, come è più probabile, circa 12 ore al giorno diventerebbero circa 17 anni. Troppo tempo.
Una persona in automobile, invece, a una velocità di 90 chilometri orari, impiegherebbe 4.271 ore, cioè 177 giorni, solo 25 settimane, poco più di 6 mesi. Ci si potrebbe dare il cambio, quindi si potrebbe mantenere velocità e tempi, ma sarebbe necessario avere in dotazione un mezzo di trasporto ad alta tecnologia, bisognerebbe progettarlo, costruirlo. Troppo complicato. E costoso.
Io, io ci arriverò in bicicletta.
Era difficile, per me, parlare con mio padre. Lui non giocava con noi, non era il tipo, ma se gli ponevo una domanda ci pensava su e poi cominciava a dire e lo faceva con un certo piacere. Soprattutto d’estate. Magari dopo aver tagliato l’anguria che eravamo andati a comprare insieme con la sua Vespetta.
«Mi parli ancora della luna, papà?»
Lui metteva insieme i pensieri uno alla volta.
«Una notte l’ho rivista, era come se il cielo si fosse strappato, uno strappo netto, dal colore brillante. Tutto intorno era buio.»
«E come mai è ricomparsa?»
«Lei era sempre stata lì, ero io che non l’avevo più cercata. Ma una notte ho cominciato a fare il pane. Ero appena un garzone, mi aveva preso a bottega il panettiere del quartiere. Glielo aveva implorato tuo nonno, per togliermi dalla strada, diceva, e forse gli dava anche dei soldi per tenermi lì.»
Mio padre sorrideva poco, ma quando parlava di quel periodo era come se si dislocasse, anche con l’anima, in un momento di piacere. E allora il sorriso tornava.
«Ti piaceva fare il pane, papà?»
«Impastare non potevo, io ero solo il fornaio: guardavo lievitare le pagnotte ancora crude distese in file regolari, mi piaceva metterle nel forno e aspettare. Mi piaceva il loro odore caldo. Le prime sere avevo sempre la lingua in fiamme perché ne mangiavo qualcuna di nascosto, mentre erano ancora bollenti.»
«E la luna?»
«La vedevo la notte, pedalando in fretta per andare al laboratorio, quando qualche volta guardavo il cielo. Era sempre tua nonna che mi svegliava. Mi alzavo all’ultimo minuto, mi lavavo la faccia e uscivo. Lei era lì ad aspettarmi, quasi sempre.»
Certe sere interrompeva i suoi racconti all’improvviso e io sapevo che non avrebbe continuato. Avevo imparato a non insistere.
Per percorrere quei 384.400 chilometri in bicicletta, con una media di 30 chilometri l’ora, ci vogliono 12.813 ore.
A 30 chilometri l’ora, pedalando non più di 8 ore al giorno, calcoliamo un totale di 1.602 giorni. 1.602 giorni sono 228 settimane. 228 settimane sono 4 anni e 20 settimane.
Con una bicicletta molto leggera e un buon allenamento potrei arrivare anche a fare 50 chilometri all’ora. A 50 chilometri l’ora, pedalando sempre 8 ore al giorno calcoliamo un totale di 7.688 ore, che diventano 961 giorni. 961 giorni sono 137 settimane, che diventano 2 anni e 33 settimane.
Se invece che 8 ore al giorno ne pedalassi 10, potrei ridurre il tempo a 768 giorni, che sono 109 settimane e che diventano solo 2 anni e 5 settimane.
D’inverno il suo umore diventava di roccia. I mal di testa lo tormentavano da sempre e io ero stata abituata fin da piccola a non disturbarlo. Per nessuna ragione. Mia nonna, che viveva con noi, quando lo sentiva rientrare mi intimava di sparire e di fare silenzio, e io mi nascondevo dietro la porta della cucina. Sono cresciuta temendo le sue ire. Ho capito dopo tanto tempo che era solo una minaccia, una beffarda invenzione di lei, che non sopportava i bambini, nemmeno quelli che erano stati i suoi figli.
La nostra casa era sempre molto quieta. Amavo quando, raramente, veniva a trovarci qualcuno perché in quei momenti mio padre diventava all’improvviso ciarliero.
«Tua madre l’ho conosciuta il giorno della Befana. Stavo andando al cinema con un mio amico, l’ho vista mentre loro stavano uscendo e noi stavamo entrando. Avevamo già comprato il biglietto ma ho detto al mio amico: “Questa me la sposo” e l’ho seguita. Ho insistito per accompagnarla a casa, lei non voleva, ma le sono rimasto accanto, con la mia moto, mentre lei pedalava. Era quasi buio.»
«Quanti anni avevi?»
«Dovevo ancora fare il militare, speravo di essere riformato perché ero il quarto figlio maschio della famiglia, invece sono dovuto partire lo stesso.»
Sapevo che si erano scritti ogni giorno per tutto il tempo ma, pur avendole cercate e chieste, non ho mai scoperto dove sono finite quelle lettere. La sua calligrafia la conosco appena, so solo che quando scriveva lo faceva con movimenti larghi e nervosi, come se ci fosse lì, accanto a lui, una maestra severa, pronta a bacchettargli la mano.
«Una volta avevo un permesso solo di due ore ma ho preso il treno e sono andato a trovarla, dovevo tornare alle otto e sono rientrato a mezzanotte, solo per vederla pochi minuti.»
È possibile che i tempi per arrivare saranno inferiori ai due anni calcolati perché, a un certo punto, la forza di attrazione della Luna, la sua gravità, potrebbe accelerare il mio viaggio. È bene comunque considerare l’eventualità più difficoltosa, in modo da evitare brutte sorprese.
La prima cosa da fare sarà quella di costruire un passaggio. Un ponte? Una strada? Forse si potrebbe tirare da qui a lì un cavo abbastanza lungo e spesso in modo da potere, con delle ruote adattate, scorrervi come su una specie di monorotaia. Dovrà essere un cavo tenuto e bloccato ma allo stesso tempo mobile, per accompagnare quella specie di pigra danza che la Luna e la Terra compiono ogni mese.
Dovrò portare dei ricambi, degli accessori e degli attrezzi per le riparazioni in quantità sufficiente. Mi serviranno:
toppe di tutte le misure
dei tubetti di mastice
camere d’aria
copertoni
levagomme
una lima di metallo
una minipompa
pinze
un utensile per rimuovere la ruota libera
una chiave a stella
uno strumento per sistemare la catena
una catena (o più?) di ricambio
dei fili per i freni
delle valvole
un cambio
dei catarifrangenti
e, forse, una seconda bicicletta.
Quando mio padre raccontava del militare io guardavo mia madre di nascosto e scoprivo ogni volta sul suo volto una vanità a me sconosciuta, antica, come i loro segreti più intimi.
«E cosa ti hanno detto, papà, quando sei rientrato?»
«Mi hanno messo in punizione per tre giorni. Allora ti chiudevano in una cella piccola piccola dove non potevi vedere nessuno e non potevi fare niente.»
«Niente di niente?»
«Potevi pensare, e la sera potevi guardare il cielo da una finestrella che stava in alto. Se ne vedeva solo un pezzetto, di cielo, ma a volte compariva la luna. Era seria in quei giorni. Come se mi stesse rimproverando.»
Avevo ascoltato questa storia talmente tante volte da saperla a memoria, ma non me ne stancavo mai. Mi piaceva, allora, ascoltarlo e per anni è stato così. Poi sono cresciuta, oppure ho creduto di esserlo, ma questo è bastato per prendere le distanze dai suoi racconti, dai suoi silenzi, dalle sue storie. Non avevo più voglia di ascoltarlo, avevo solo voglia di mettere alla prova a uno a uno i pezzi che mi componevano in maniera confusa, sceglierne alcuni e scartarne altri.
E poi dovrò mangiare. Il mio fisico dovrà essere pronto a un intenso e costante consumo di calorie.
Il mio peso oggi è di 92 chili e quando pedalo lentamente, in pianura, consumo circa 129 calorie in un’ora. Quando pedalo più veloce ne consumo 426 e se pedalo come fossi in gara ne consumo anche fino a 1.000.
129+129+129+426+426+426+426+1.000+1.000+1.000=3.974/10=397,4
Consumerei circa 400 calorie all’ora. 10 ore di pedalata al giorno significa almeno 4.000 calorie. Più almeno un altro migliaio di calorie per il resto della giornata. Dovrò mangiare, quindi, alimenti leggeri ma in modo costante, e ingerire le giuste dosi di sali minerali, proteine, lipidi e zuccheri. E vitamine.
«Come mai non hai continuato a fare il pane?»
«Perché, un giorno, mi sono accorto di essere troppo stanco. Talmente stanco da non riuscire più a fare niente, avevo solo voglia di riposare. E a vent’anni non si può desiderare solo di riposare.»
«E allora, cosa hai fatto?»
«Avevo un amico che faceva il manovale e gli ho chiesto se potevo farlo insieme a lui. C’era tanto da costruire in quel periodo e abbiamo iniziato a lavorare insieme in una piccola ditta che restaurava vecchie case, che le ingrandiva per le famiglie che diventavano più numerose o le abbelliva per le famiglie che diventavano più ricche.»
«È così che hai imparato a fare tutto quello che sai?»
«Ho imparato con lui, ma poi lui ha deciso di diventare un padrone, un imprenditore, e ha chiesto anche a me di diventarlo insieme a lui, ma io gli ho detto di no. I padroni sono tutti ladri e delinquenti, anche se prima di diventare imprenditori non lo erano. Dopo, tutti lo diventano, prima o poi. Ma io non ero come loro e non volevo diventarlo. Ho preferito continuare a essere un operaio.»
«E questo lavoro non ti stanca, papà?»
La mia domanda era un sussurro, senza quasi essere una domanda. La risposa la conoscevo bene. E infatti lui non parlava molto del suo lavoro: lo odiava. Odiava il suo capo, odiava la fabbrica, la mensa, e forse anche i suoi colleghi. Odiava ogni singolo aspetto del suo lavoro sempre uguale, ogni giorno. Però non lo diceva, non lo diceva mai quell’odio, se lo faceva andare bene, per un assurdo senso del dovere che non lo ha mai spinto a cambiarlo e che lo ha aiutato a sopportarlo fino alla pensione. Non si lamentava, ma diventava di cattivo umore e si chiudeva al mondo e a noi. Riusciva a non parlare per giorni.
Se solo ci fosse una strada. Se solo ci fosse una strada sarebbe facile arrivare ovunque. Ma a volte la strada non c’è. Non perché sia nascosta, sia impervia, o non sia praticabile. Semplicemente non c’è.
Anche per arrivare al cuore di una persona bisogna percorrere una strada. Quella per arrivare a te, figlia mia, per me è una strada difficile, non riesco nemmeno a vederla, non ne sono capace. Era facile quando eri bambina e ti piaceva ascoltarmi, ti piaceva guardare quello che facevo, quando lavavo la macchina, quando aggiustavo la ruota di una bicicletta, quando impastavo la calce o davo il bianco a una parete. Ogni cosa che facevo, per te, era una curiosità e mi stavi a guardare. Poi un giorno mi hai chiesto se potevo aiutarti a fare i compiti di non so quale materia e io ti ho detto che avevo da fare anche se non era vero, così tu hai iniziato a cercare le tue risposte altrove e piano piano io sono come scomparso: era come se tu non mi vedessi più e io, del resto, specie quando ti vedevo studiare, cercavo di stare da un’altra parte.
Sono diventato invisibile.
A casa c’era sempre la televisione accesa, specie d’inverno, e non si poteva parlare. Allora ne approfittavo quando, raramente, mi facevo accompagnare in macchina da qualche parte. Non gli piaceva accendere la radio, allora cercavo di parlare con lui. Gli piaceva guidare anche se, col tempo, i movimenti si facevano sempre più impacciati.
«Mi racconti di quando sono nata?»
Non parlava mai di me. Così, ogni tanto, mi facevo raccontare la storia della mia nascita.
«Sei nata di notte. Per andare in ospedale ho dovuto chiamare Mario, te lo ricordi?»
«Certo, diceva sempre che per poco non sono nata nella sua macchina.»
«L’ho chiamato urlando dal giardino, perché a quei tempi non c’era il telefono, e poco dopo lui era già lì, con il motore acceso.»
«Presto, presto», diceva tua mamma.
«Io, più presto di così non sapevo come fare. Non dicevo niente, volevo solo arrivare. C’era la luna quella notte, ne sono sicuro.»
Vediamo sempre la stessa faccia della luna, perché gira sul suo asse alla stessa velocità con la quale gira intorno alla terra. Lei ci mostra ciò che desidera mostrare. Anche io. Se tu ruotassi più velocemente, o io rallentassi, riusciresti a vedere quella parte di me che voglio tenere nascosta. Per tanto tempo ho cercato di mantenere questo ritmo costante, ma poi tu hai accelerato davvero e io ti ho persa.
E ora tu puoi vedere anche la mia parte oscura.
Sapevo che lui era rimasto deluso quando aveva saputo di aver avuto una seconda figlia femmina perché mi hanno raccontato che ha esclamato: «Un’altra?», e così, come per chiedergli perdono, ho sempre cercato di interessarmi a quello che faceva: potare una pianta, rifare un muretto; guardavo insieme a lui le vecchie comiche mute in bianco e nero e le gare di ciclismo. Che cosa avrebbe fatto di diverso con un figlio maschio? Me lo sono chiesta per anni. Perché non sembrava mai contento.
Tante volte, anche senza volerlo, abbiamo tentato di spegnerti, ma è stato inutile. Ogni volta brillavi più di prima, di una luce tutta tua, più o meno luminosa, come succede a certe persone. Non volevamo opprimerti, ma tutta questa luce ci faceva paura. È pericoloso ciò che non si capisce, figlia mia, fa paura tanto quanto un luogo oscuro e sconosciuto: non se ne vedono i contorni ma se ne percepiscono i pericoli.
«Cosa vuoi fare da grande?»
«Non lo so.»
«Ma dovrai pur fare qualcosa.»
E di volta in volta io gli rispondevo che volevo diventare una pittrice. Qualche volta una giornalista. Qualche volta una scrittrice.
Lui scuoteva sempre la testa. Io sognavo mentre lui era convinto che non sarei mai potuta diventare né una pittrice, né una giornalista, né una scrittrice, era come se avessi dichiarato di voler diventare una principessa, secondo lui era come una questione di sangue. E io ero figlia di operai.
Da quando sono in pensione pedalo ogni giorno. Per almeno 60 chilometri. Qualche volta 70. Quasi la metà in salita. Il che significa che è come se ne facessi almeno il doppio. È un allenamento duro, ma per raggiungere il fisico che mi occorre ci vuole un bel po’ di tempo e tanta fatica, ma a quella ci sono abituato.
Nel frattempo sto studiando tutte le cose che serve sapere, ne parlo con Giovanni, lui mi spiega, e io prendo nota, ci informiamo: anche lui è in pensione, una volta faceva l’impiegato in comune, e lui sì che sa fare bene i conti, e sa ragionare bene. Con lui stiamo pensando a tutto, anche che forse ci servirà l’aiuto di qualcun altro.
Il giorno che mi sono laureata, ancora poche ore prima della discussione lui insisteva per non accompagnarmi.
«Cosa ci vengo a fare?»
«Devi venire, papà. Voglio che tu venga.»
«Non è un posto per me.»
«Sì che lo è. Andiamo, dai.»
«Non capirò niente.»
Avrei voluto dirgli «Non importa», ma sarebbe stato come ammettere che era vero, che non avrebbe capito, invece gli dissi ancora una volta «Andiamo.» E lui alla fine venne.
In una delle poche foto di quel giorno c’è lui che sorride: con le labbra, con gli occhi, con tutta la faccia, come solo lui era capace di fare. Dietro a quel sorriso era nascosto l’orgoglio che non sapeva dire. Il mio professore l’ha abbracciato come un vecchio amico, lui si è schernito e, poco dopo, ha salutato tutti ed è tornato a casa, trascinando via anche mia madre. Ma io ero felice.
Devono venire con me delle persone, come dice Giovanni, uno staff. Devo mettere insieme: un dottore, di sicuro, qualcuno che gestisce il cibo, e poi un astronauta, forse, anche se non sarà facile, non saprei dove trovarlo, oppure forse basterebbe qualcuno che sappia come muoversi lassù. E poi qualcuno che sappia riparare la bicicletta, ma di questo potrei occuparmene io. Lo so fare, è che forse sarò un po’ stanco.
Dopo qualche anno mi sono sposata. Quel giorno, prima della cerimonia, la fotografa è venuta a fare degli scatti a casa e ci obbligava a stare vicini, ci metteva braccia intorno a spalle e mani ad accarezzare guance, senza sapere che quei gesti, noi, in famiglia, non li avevamo fatti mai. Nelle foto stampate ci sono solo sguardi indecisi e sorpresi. Ci sfioriamo appena.
Fino a 12 chilometri siamo dentro la troposfera, fino a 50 chilometri c’è la stratosfera, dove finisce anche l’ozono, fino a 85 chilometri c’è la mesosfera dove si raggiungono fino a -140°C, e poi, fino a 640 chilometri c’è la termosfera dove la temperatura torna a riscaldarsi e, infine, fino a 10.000 chilometri c’è l’esosfera, dove la temperatura aumenta ancora ma dove, mi hanno spiegato, le particelle che la compongono sono talmente lontane l’una dall’altra che se anche sono bollenti, non si percepiscono. Solo dopo, finiti tutti questi strati, inizia lo spazio.
Servirà un abbigliamento adatto.
In pensione gli dissero che per tenere il cuore in allenamento doveva muoversi. Suo padre era morto d’infarto, e anche due suoi fratelli, quindi non era una raccomandazione superflua. A camminare non riusciva a causa di un incidente a un piede di qualche anno prima. Così cominciò a girare con una vecchia bicicletta. All’inizio ci era parsa una buona idea, ma dopo qualche anno, quando l’aveva venduta e aveva comprato prima una bici da corsa usata e poi un’altra, più moderna, più veloce, più scomoda, la bici era diventata il nostro incubo: i chilometri, le salite, il caldo, il sole, il suo fisico appesantito. Ci preoccupava tutto. La mattina partiva subito dopo l’alba e tornava che era quasi ora di pranzo. Non pedalava mai al buio, né con altre persone. Ma lo faceva quasi tutti i giorni, con la serietà che aveva messo in tutte le cose che aveva affrontato nella vita. Non conosceva un altro modo.
Il Giro d’Italia è lungo più o meno 3.500 chilometri, andare sulla luna in bicicletta è come fare 110 volte il Giro d’Italia. Nessuno ha mai fatto per 110 volte il giro d’Italia, ma ogni atleta che partecipa si allena per molte migliaia di chilometri ogni anno per arrivare in forma al Giro. Il mio viaggio sarà come un lungo allenamento. Un lunghissimo allenamento. Ma ci arriverò.
Quando guardi in alto, la luna, a volte, non si vede. Magari la cerchi e continui a cercarla; ma poi gli occhi ti si chiudono, e hai trovato il modo per raggiungerla.
Ti è piaciuto questo racconto? La copertina? La redazione? Tutti e tre?